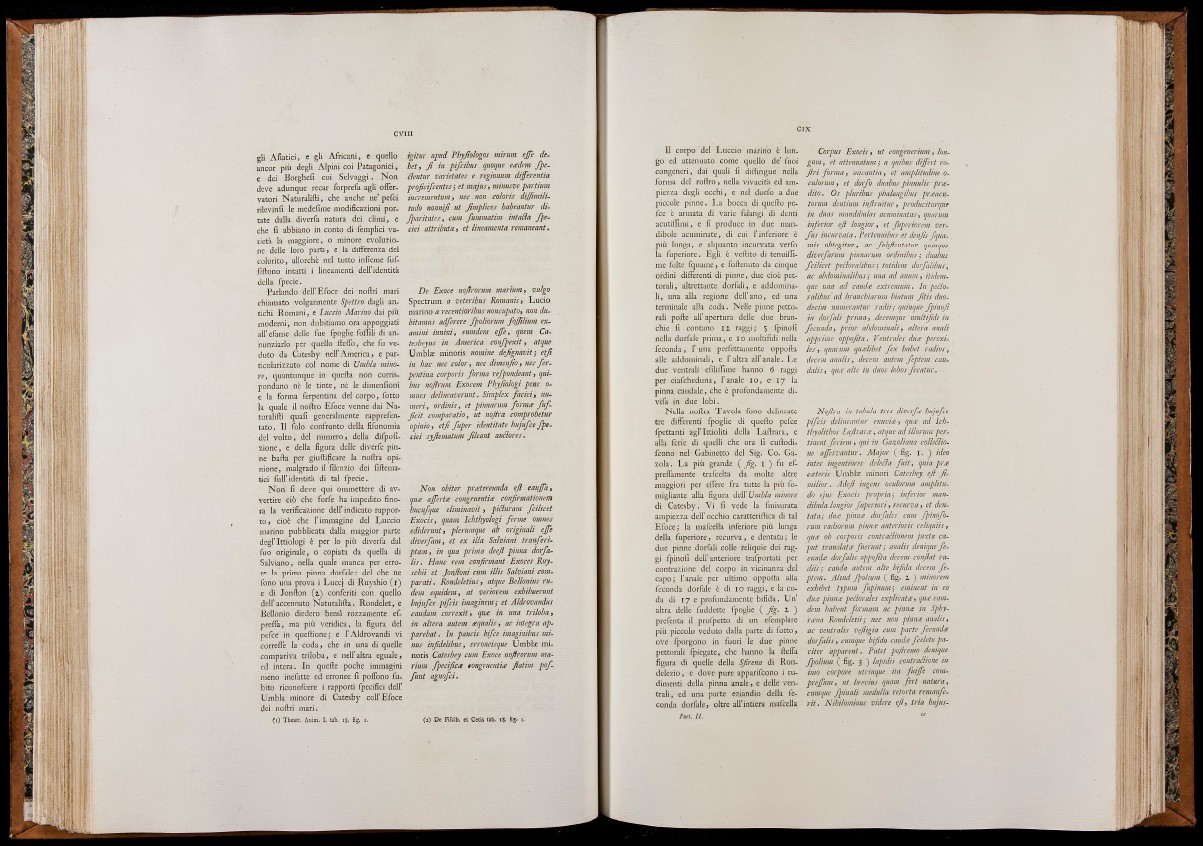
cvm
i
gli Afiatici, e gli Africani, c quello
ancor più degli Alpini coi Patagonici,
e dei Borghell coi Selvaggi . Non
deve adunque recar forprefa agli oiTervatori
Naturalifti, che anche ne' pefd
rilevinfi le medefime modificazioni portate
dalla diverfa natura dei climi, e
che fi abbiano in conto di femplici varietà
la maggiore, o minore evoluzione
delle loro parti, e la differenza del
colorito, allorché nel tutto infìeme fuffiftono
intatti i lineamenti dell'identità
della fpecie.
Parlando dell'Efoce dei noftri mari
chiamato volgarmente Spettro dagli antichi
Romani, e Luccio Marino dai più
moderni, non dubitiamo ora appoggiati
all' efame delle fue fpoglie foifili di annunziarlo
per quello fteifo, che fu veduto
da Catesby nell'America, e particolarizzato
col nome di Vnihla m/HOrc,
quantunque in quella non corrispondano
ne le tinte, nè le dimenfioni
e la forma ferpentina del corpo, fotto
]a quale il noftro Efoce venne dai Naturalifti
quafi generalmente rapprefentato.
11 folo confronto della fifonomia
del volto, del numero, della difpofizione,
e della figura delle diverfe pinne
bafta per giuftificai'e la noftra opinione,
malgrado il filenzio dei fiftema-
(ici full'identità di tal fpecie.
Non fi deve qui ommettere di avvertire
ciò che forfè ha impedito finora
la verificazione dell'indicato rapport
o , cioè che r immagine del Luccio
marino pubblicata dalla maggior parte
degf Ittiologi è per lo più diverfa dal
fuo originale, o copiata da quella di
Salviano, nella quale manca per errore
la prima pinna dorfale: del che ne
fono una prova i Luccj di Ruyshio (l )
e di Jonfton (i) conferiti con quello
dell'accennato Naturalifta. Rondelet, e
Bellonio diedero bensì rozzamente efprefla,
ma più veridica, la figura del
pefce in queftione; e TAldrovandi vi
corre/Te la coda, che in una di quelle
compariva triloba, e nell'altra eguale,
ed intera. In quefte poche immagini
meno inefatte ed erronee fi poiTono fubito
riconofcere i rapporti fpecifici deU'
Umbla minore di Catesby coli'Efoce
dei noftri mari.
(i) Theacr. Anini. 1. tab. i8- fig. iigitur
ttpud Phyfiologos mirum ejje debet,
ß in pifcibus quoque eeedem fpc.
Sentur varietates e regiomm differentia
proßcifcentes i et majus, minusve partium
incrementmn, nec non coloris dijfimilìtudo
nonnifi ut fimplices habeantur difparitates,
cum fummatim intaéìa fpeciei
attributa, et lineament a remaneant.
De Exoce noßrorum marium, vulgo
Spectrum a veteribus Romanis, Lucio
marino a recentioribus noncupato, non dubitamus
adßrere ßpoliorum fojßlium examini
innixi, eumdeni effe, quem Catesbeyus
in America conßpexit, atque
U m b k minons nomine deßgnavit ^ etß
in bac nec color, nec dimenfio, nec ßerpentina
corporis forma refpondeant, quibus
noflrim Exocem Phyßologi pene omnes
delineaverunt. Simplex faciei, nu.
meri, ordinis, et pinnarum forma fufßcit
campar atto, ut noflra comprobetur
opinio, et fi fuper identitate hujufce fpedei
syficmatum fileant auRores.
Non obiter frtetereunda efl muffa,
qu,e afferta congruentiie confirmationem
hucußque eliminavit, piäuram fcilicet
Exocis, quam Icbthyologi firme omnes
edidcrunt, plerumque ab originali effe
diverfam, et ex fila Sahiani tranfcriptam,
in qua prima deefi pinna dorfalis.
Hanc rem confirmant Exoces Ruyscbii
et Jonfioni cum Ulis Salviani comparati
. Rondeletius, atque Bellonius rudern
equidem, at veriorem exhibuerunt
bujufoe pifcis imaginemi et Aldrovandus
caudam correxit, quie in una triloba,
in altera autem tequalis, ac integra apparebat.
In paucis hifce imaginibus minus
infidelibus, erroneisque Umblx minoris
Catesbey cum Exoce noßrorum marium
fpccificic tongruentiie ßatim pof.
funt agnofci.
(2) De Pìfcib. et Cetis tab. iS. fis.- i.
CIX
5 '
ï i
Il corpo del Luccio marino è lungo
ed attenuato come quello de' fuoi
congeneri, dai quali fi diftingue nella
forma del roftro, nella vivacità ed ampiezza
degli occhi, e nel dorfo a due
piccole pinne. La bocca di quefto pefce
è armata di varie falangi di denti
acutilllmi, e fi produce in due mandibole
acuminate, di cui finferiore è
più lunga, e alquanto incurvata verfo
la fuperiore. Egli è veftito di tenuiffime
folte fquame, e foftenuto da cinque
ordini differenti di pinne, due cioè pettorali,
altrettante dorfali, e addominali,
una alla regione delfano, ed una
terminale alla coda. Nelle pinne pettorali
pofte air apertura delle due branchie
fi contano IL raggi ; 5 fpinofi
nella dorfale prima, e 10 moltindi nella
feconda , f una perfettamente oppofta
alle addominali, e 1' altra alf anale. L,e
due ventrali efìlilfime hanno 6 raggi
per ciafcheduna, fanale 10, e- 1 7 la
pinna caudale, che è profondamente divifa
in due lobi.
Nella noftra Tavola fono delineate
tre differenti fpoglie di quefto pefce
fpettanti agi'Ittioliti della Laftrara, e
alla ferie di quelli che ora fi cuftodifcono
nel Gabnietto del Sig. Co. Gazola.
La più grande ( fig. i ) fu efpreiFamente
trafcelta da molte altre
maggiori per eiTere fra tutte la più fomigliante
alla figura delf Umbla minore
di Catesby. Vi fi vede la fmisurata
ampiezza dell' occhio caratteriftica di tal
Efoce 3 la mafcella inferiore più lunga
della fuperiore, recurva, e dentata ; le
due pinne dorfali colle reliquie dei raggi
fpinofi dell'anteriore trafportati per
contrazione del corpo in vicinanza del
capo; fajiale per ultimo oppofta alla
feconda dorfale è di 10 raggi, e la coda
di 17 e profondamente bifida. Un
altra delle fuddette fpoglie ( fig- t )
prefenta il profpetto di un efemplare
più piccolo veduto dalla parte di fotto,
ove fporgono in fuori le due pinne
pettorali fpiegate, che hanno la ftefla
figura di quelle della Sfirena di Rondelezio,
e dove pure apparifcono i rudimenti
della pinna anale, e delle ventrali,
ed una parte eziandio della feconda
dorfale, oltre alfintiera mafcella
l'ari. II.
Corpus Exocis, ut congenerium, longum,
et attenuatum i a quibus differt ro.
firi forma, micantia, et amplitudine 0-
culorum, et dorfo duabm pinnulis priedito.
Os pluribus pbalangibus praacu.
torum dentimn inflruitur, produciturquc
in duas mandibulas acuminatas, quorum
inferior eß longior, et fuperiorem verfus
incurvata. Pertcnuibus et denfis fquamis
obtegitur, ac fubfientatur quinqué
diverfarum pinnarum ordinibus j duabus
fcilicet peñoralibu.r tot idem dorfalibus,
ac abdomiualibus ; una ad anum, it/demque
una ad caudte extremum. In pe£ioralilms
ad brnncbiarum biatum fitis duodecim
numerantur radii j quinqué fpinofi
in dorfali prima, decemque multifidi in
fecunda, prior abdominali, altera anali
ap>prime oppofita. Ventrales dua perexilesy
quarum qucelibet fex habet radios,
decern analis, decern autem feptem cau.
dalis, qua alte in duos lobos fecatur.
Nofira in tabula tres diverfíC hujufce
pif'is delinean tur exuvia, qu,e ad Ichthyolitbos
Laflrarte, atque ad illorum pertinent
feriem , qui in Gamliana collezione
affervantur. Major ( fig. i. ) ideo
inter ingentiores delecta fuit, quia prie
ceteris Umblx minori Catesbey efi fimilior,
Adeß ingens oculorum amplitudo
ejus Exocis propria i inferior mandíbula
longior fuperiori, recurva , et dentata
i duie pinme dorfales cum fpinoforum
radioram pinn.e anterioris reliquiis,
cjUte ob corporis contraäionem juxta caput
translatte fuerunt ; analis denique fe.
cundie dorfalis oppofita decern confiat radiisj
cauda autem alte bifida decem feptem.
Aliud fpolimn ( fig. z ) minorem
exldibet typum fupinum'., eminent in eo
dUiC pinnce peBorales explicatie, qua eamdem
habent formam ac pinna in Sphyrtena
Rondeletii; nec non pinna analis,
ac ventralis vefligia cum parte fecunda
dorfalis, cmnque bifido cauda fceleto pariter
apparent. Patet poßremo denique
fpolium ( fig. 3 ) lapidis contrazione in
imo corpore utrinque ita fuiffe compreffum,
ut brevius quam fert natura,
cumque fpinali medulla retorta remanfcrit.
Nihilominus videre eß, tria hujusi
^í 1
4
i
(
4 I