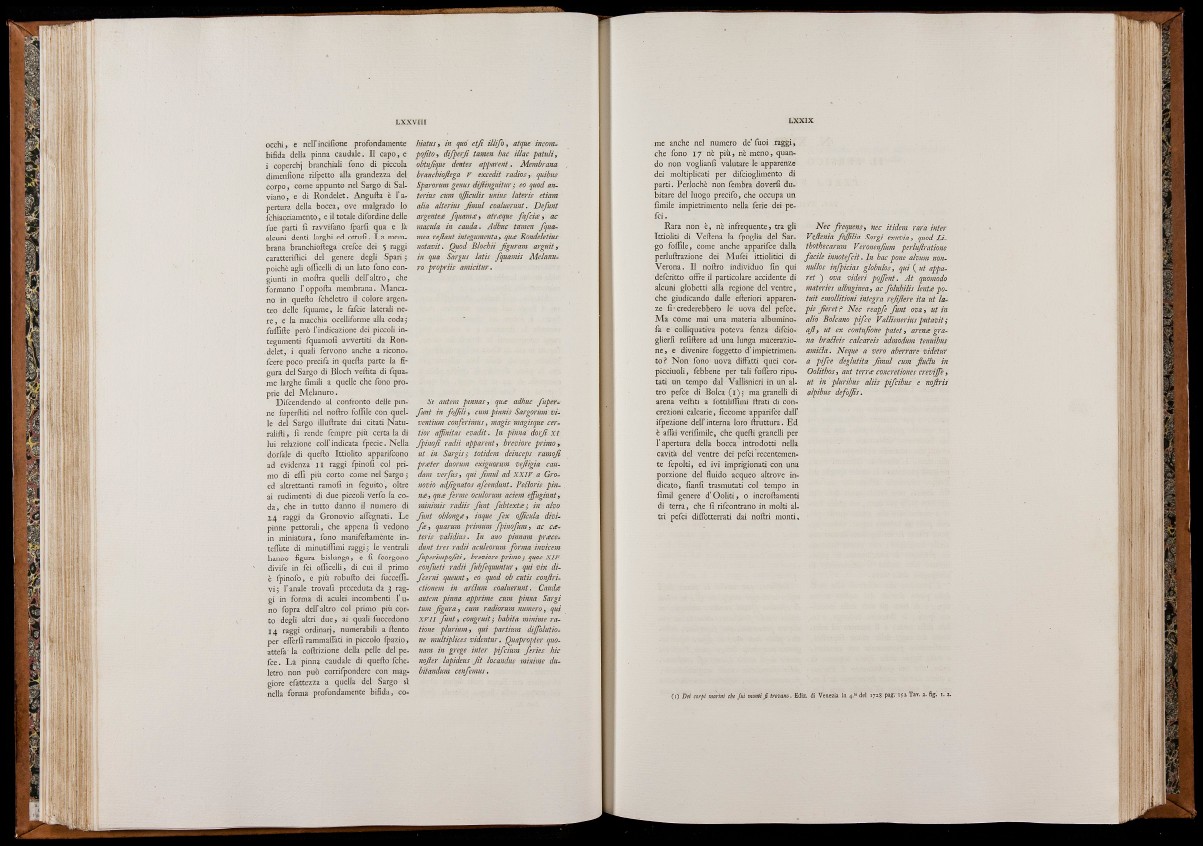
occhi, e nell'incifione profondamente
bifida della pinna caudale. II capo, e
i coperchi branchiali fono di piccola
dimenfione rifpetto alla grandezza del
corpo, come appunto nel Sargo di Salviano,
e di Rondelet. Angufta è l'apertura
della bocca, ove malgrado lo
Ìchiacciamento, e il totale difordine delle
fue parti fi ravvifano fparfi qua e là
alcuni denti larghi ed ottufi. La membrana
branchioftega crefce dei 5 raggi
caratteriftici del genere degli Spari ;
poiché agli oiTicelli di un lato fono congiunti
in moftra quelli dell'altro, che
formano l'oppofta membrana. Mancano
in quefto fcheletro il colore argenteo
delle fquarae, le fafcie laterali nere,
e la macchia ocellifornie alla coda;
fnfllfte però l'indicazione dei piccoli integumenti
fquamofi avvertiti da Rondelet,
i quali fervono anche a riconofcere
poco precifa in quefta parte la figura
del Sargo di Bloch veftita di fquame
larghe fimili a quelle che fono proprie
del Melanuro.
Difcendendo al confronto delle pinne
fuperftiti nel noftro foiTiIe con quelle
del Sargo illuflrate dai citati Naturaliiti,
fi rende fempre più certa la di
lui relazione coli'indicata fpecie. Nella
dorfale di quefto Ittiolito apparirono
ad evidenza 11 raggi fpinofi col primo
di effi più corto come nel Sargo
ed altrettanti ramolì in feguito, oltre
ai rudimenti di due piccoli verfo la coda,
che in tutto danno il numero di
1 4 raggi da Gronovio aiTegnati. Le
pinne pettorali, che appena fi vedono
in miniatura, fono manifeftamènte inteiTute
di minutiflìmi raggi; le ventrali
hanno figura bislunga, e fi fcorgono
divife in fei officelli, di cui il primo
è fpinofo, e più robufto dei fucceillv
i ; l'anale trovafi preceduta da 3 raggi
in forma di aculei incombenti l'uno
fopra dell' altro col primo più corto
degli altri due, ai quali fuccedono
1 4 raggi ordinar), numerabili a ftento
per elTerfi rammaifati in piccolo fpazio,
attefa la coftrizione della pelle del pefce.
La pinna caudale di quefto fcheletro
non può corrifpondere con maggiore
efattezza a quella del Sargo si
nella forma profondamente bifida, cohiatus,
in quo etfi illifo, atque incom.
-poßto, difperß tarnen hac iliac -pattili,
obtußque denies apparent. Membrana
bratichioßega F excedit radios, quibus
Sparonnn genus dißinguitur ; eo quod anterius
cum ojßculis unius lateris etiam
alia alterius ßmul coaluerunt. Deßmt
argentea fquame, atrieque fafciis, ac
macula in cauda. Adhuc tarnen ßquamea
reßant integmnenta, quie Kondeletius
notavit. Quod Blochii figuram arguit,
in qua Sargus latis ßquamis Melanuro
proptiis amieitur.
Si autem pinnas, qu^e adhuc ßtiperßmit
in fijfili J cum pinnis Sargorum viventium
conferimus, magis magisque certior
affinitas evadit. In pinna dorß XI
ßpinoß radii apparent, breviore primo ,
ut in Sargisi totidem deineeps ramoß
praeter duorum exiguorum veßigia caudam
verßus, qui ßmul ad XXIF a Gronovio
adßgnatos afcendunt. Peäoris pinme,
qua ferme oculorum aciem effugiunt,
minimis radiis funt fubtexta^ in alvo
funt oblongx, inque ßex ojßcula divifiS,
quarum primum fpinofum, ac cueteris
validius. In ano pnnnam prcece.
dunt tres radii aculeorum ßirma invicem
ßuperimpoßti, breviore prima j quos XIV
confueti radii fiibfiquuntur, qui vix difcerni
queunt, eo quod ob cutis conßrictionem
in arßum coaluerunt. Caudie
autem pinna apprime cum pinna Sargi
tum ßgura, cum radiorum numero, qui
XVn funt, congruità habita minime ratione
plurium, qui partium dijfolutione
multiplices videntur. Quapropter qiionam
in grege inter pifcium firies hie
noßer lapideus ßt locandus minime dubitandum
cenßemus.
me anche nel numero de'fuoi raggi,
che fono 17 nè più, nè meno, quando
non voglianfi valutare le apparenze
dei moltiplicati per difcioglimento di
parti. Perlochè non fembra doverfi dubitare
del luogo precifo, che occupa im
fimile impietrimento nella ferie dei pef
c i .
Rara non è, nè infrequente, tra gli
Ittioliti di Veftena la fpoglia del Sargo
folTile, come anche apparifce dalla
perluftrazione dei Mufei ittiolitici di
Verona. Il noftro individuo fin qui
defcritto offre il particolare accidente di
alcuni globetti alla regione del ventre,
che giudicando dalle efteriori apparenze
fi ' crederebbero le uova del pefce.
M a come mai una materia albuminofa
e colliquativa poteva fenza difcioglierfi
refiftere ad una lunga macerazione,
e divenire foggetto d'impietrimento
? Non fono uova diffatti quei corpicciuoli,
febbene per tali foifero riputati
un tempo dal Vallisnieri in un altro
pefce di Solca ( l ) ; ma granelli di
arena veftiti a fottiliilìmi ftrati di concrezioni
calcarle, ficcome apparifce dall'
ifpezione dell'interna loro ftruttura. Ed
è affai verifimile, che quefti granelli per
l'apertura della bocca introdotti nella
cavità del ventre dei pefci "recentemente
fepolti, ed ivi imprigionati con una
porzione del fluido acqueo altrove indicato,
fianfi trasmutati col tempo in
fimil genere d'Ooliti, o incroftamenti
di terra, che fi rifcontrano in molti altri
pcfci dilTotterrati dai noftri monti.
Nec frequens, nec itidem rara inter
Vejienia fojplia Sargi exuvia, quod Lithothecarum
Veronenjìum perluftratione
facile innotefcit. In hac pone alvum non.
nullos infpicias globulos, qui ( ut apparet
) ova videri pojfent. At quomodo
materies albuginea, ac folubilis lentie potuit
emollitioni integra rejijlere ita ut lapis
Jieret? Nec reapfe flint ova, ut in
alio Solcano pifce Vallisnerius putavit ^
ut ex contufione patet, flre»<e grana
braiieis calcareis admodum tenuibus
amiBa. Neque a vero aberrare videtur
a pifce deglutita Jìmul cum fiuBu in
Oolithos, aut terne concretiones crevijfe,
ut in pluribus aliis pifcibus e nojìris
alpibus defofps.
( 0 Bei corpi marini che fui monti ^ tromno. Ediz. di Venezia in 4." del lyjS pag: i f iTa v . z. fig. i. z.
' i.j! «
ì i