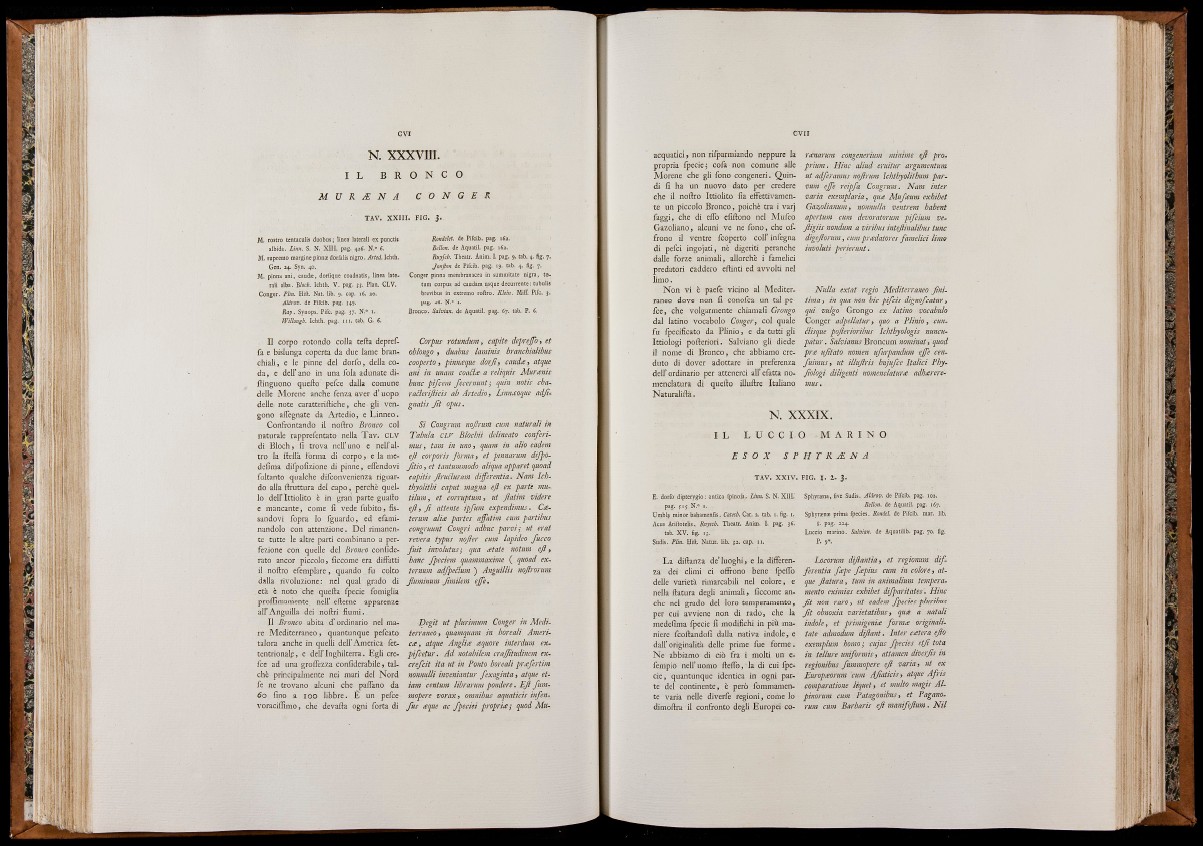
i'J^ i' '
t i f f
C V l
N. xxxvni.
I L B R O N C O
M U R M N A C O N G E R
T A V . XXIII. FIG. 3.
cvii
M. rostro tcntacuHs duobus; linea laterali ex punctis
albida. Linn. S. N. XIII. pag. 426. N.° 6.
M. supremo margine pinniE dorfalis nigro, Artsd. Ichth.
Gen. 24. Syn. 40.
M. pinna ani, cauds, dorlique coadnatis, linea laterali
alba. mcb. Ichth. V. pag. jj. Pian. CLV.
Conger. Fìin. Hift. Nat. lib. 9. cap. 16. ao.
Aldrov. de Pifcib. pag. 549.
Rny. Synops. Pile. pag. 37. i.
Willoiigb. Iclith. pag. III. tab. G. i.
Il corpo rotondo colla tefta depreffa
e bislunga coperta da due lame branchiali,
e le pinne del dorfo, della coda,
e dell'ano in una fola adunate diflinguono
quello pefce dalla comune
delle Morene anche fenza aver d'uopo
delle note caratteriftiche, che gli vengono
aiTegnate da Artedio, e Linneo.
Confrontando il noftro Bronco col
naturale rapprefentato nella Tav. CLV
di Bloch, fi trova nell'uno e nell'altro
la ftefTa forma di corpo, e la medefima
difpofizione di pinne, eflendovi
foltanto qualche difconvenienza riguardo
alla ftruttura del capo, perchè quello
dell'Ittiolito è in gran parte guafto
c mancante, come lì vede fubitO) fissandovi
fopra lo fguardo, ed efaminandolo
con attenzione. Del rimanente
tutte le altre parti combinano a perfezione
con quelle del Bronco confiderato
ancor piccolo, ficcome era difTatti
il noftro efemplare, quando fu colto
dalla rivoluzione : nel qual grado di
età è noto che quefta fpecie fomiglia
proffimamente nell' efterne apparenze
all'Anguilla dei noftri fiumi.
I l Bronco abita d'ordinario nel mare
Mediterraneo , quantunque pefcato
talora anche in quelli dell'America fettentrionalp,
e dell'Inghilterra. Egli crefce
ad una groflèzza confiderabile, talché
principalmente nei mari del Nord
fe ne trovano alcuni che paiTano da
60 fino a 100 libbre. È un pefce
voraciiTimo, che devafta ogni forta di
RondeUt. de Pifcib. pag.
Bdlm. de Aquatil. pag. l6s.
Rityfch. Theatr. Anini. I. pag. 9. tab. 4. fig. 7.
JonJlott de Pifcib. pag. 19. tab. 4. fig. 7.
Conger pinna membranacea in summitate nigra, totum
corpus ad caudam usqne decurrente : tubulis
brevibus in extremo roitro. Klein. MifT. Pifc. 3.
pag. 26. I.
Eronco. Salvia», de Atjuatil. pag. 67. tab. P.
CorpUí rotundum, capite deprejp), et
oblongo , duabuí laminis branchialibus
cooperto , pinnaque dorjì, caud^, atque
ani in imam coaóhe a rdiquis Murienis
hunc pifcem fecernuntj quin notis charañerifticis
ab Artedio, LinnMque adfignatis
Jlt opus.
Si Congrum nojiruiñ cum naturali in
Tabula CLF Blochii delineato conferimus,
tam in uno, quam in alio eadem
ejl corporis forma, et pinnarum difpo-
Jìtio, et tantummodo aliqua apparet quoad
capitis Jlruciuram differentia. Nam Icbthyolitbí
caput magna eft ex parte mutilum,
et corruptmn, ut Jlatim videre
ejì, Ji attente ipfum expendimus. C¡eterum
ali¡e partes affatim cum partibus
congruunt Congri adhuc parvi^ ut erat
revera typus nojier cum lapideo fucco
fuit involutus^ qua atate notuni cjl,
banc fpeciem quammaxime ( quoad ex.
ternum adfpeéìum ) Anguillis nojlrorum
fuminum Jtmilem effe.
Degit ut plurimum Conger in Mediterraneo,
quamquam in boreali America,
atque Anglice lequore interdum expifcetur.
Ad notabilem crajjìtudincm excrefcit
ita ut in Ponto boreali pricfertim
nonnulli inveniantur f txaginta, atque etiam
centum librarum pendere. Ejl fummopere
vorax, omnibus aquaticis infenfus
teque ac fpeciei propria^ quod Muacquatici,
non rifparmiando neppure la
propria fpecie i cofa non comune alle
Morene che gli fono congeneri. Quindi
lì ha un nuovo dato per credere
che il noftro Ittiolito fia effettivamente
un piccolo Bronco, poiché tra i varj
faggi, che di elTo efiflono nel Mufeo
Gazoliano, alcuni ve ne fono, che of.
frono il ventre fcoperto coli' infegna
di pefci ingojati, ne digeriti peranche
dalle forze animali, allorché i famelici
predatori caddero eftinti ed avvolti nel
limo.
Non vi è paefe vicino al Mediterraneo
dove non fi conofca un tal pefce,
che volgarmente chiamali Grongo
dal latino vocabolo Conger, col quale
fu fpecificato da Plinio, e da tutti gli
Ittiologi pofteriori. Salviano gli diede
il nome di Bronco, che abbiamo creduto
di dover adottare in preferenza
dell' ordinario per attenerci all' efatta nomenclatura
di quefto illuftre Italiano
Naturaliftà.
rccnarum congenerium minime eß pro.
prium. Hinc aliud eruitur argumentum
ut adferamus noßrum Icbtbyolitbum parvum
effe reipfa Congrum. Nam inter
varia exemplaria, quie Mufceum exbibet
Gag,olianmn, nonnulla ventrem habent
apertum cum devoratorum pifcium veßigiis
nondum a viribus inteflinalibus tunc
digeßorum, cmn prtedatores famelici limo
involuti perierunt.
Nulla extat regio Mediterraneo finitima
, in qua non hic pifcis dignofcatur,
qui vulgo Grongo ex latino vocahulo
Conger adpellatur, quo a Plinio, cun.
Bisque pojlerioribus Icbthyologis nuncupatur.
Salvianus "Broncum nominat, quod
prie ufitato nomen ufurpandum effe cenfuimus,
ut illujlris bujufce Italici Phy-
Jìologi diligenti nomenclatura adhcerere-
N. XXXIX.
I L L U C C I O MARINO
E S O X S P H T R M N A
T A V . XXIV. FIG. I. 1. 3.
E. dorfo dipterygio: antica fpinofa. ¿ÌJIH. S. N. XIII.~
pag. N.- i.
Umblg minor bahanienfis. Catssb. Car. 2. tab. i. fig. i.
Acus Aiiftotelis, Ruyscb. Theatr. Anim. I. pag. 36.
tab. XV. fig. 13.
Sndis. Flill. Hift. Natur. lib. 32. cap. li.
L a diftanza de'luoghi, e la differenza
dei climi ci offrono bene fpeflb
delle varietà rimarcabili nel colore, e
nella ftatura degli animali, ficcome an.
•che nel grado del loro temperamento,
per cui avviene non di rado, che la
medefima fpecie fi modifichi in più maniere
fcoftandofi dalla nativa indole, e
dall' originalità delle prime fue forme.
N e abbiamo di ciò fra i molti un efempio
nell'uomo fteffo, la di cui ipecie,
quantunque identica in ogni parte
del continente, è però fommamente
varia nelle diverfe regioni, come lo
dimoftra il confronto degli Europei co-
Sphyraina, five Sudis. Jlih-ov. de Pifcib. pag. ioa.
Eellofi. de Aquatil. pag. 167.
Sphyra-nK prima fpecies. Rondel, de Pifcib. mar. lib.
S. pag. 224.
Luccio marino. Salvia«, de Aquatilib. pag. 70. fig.
P. 9*.
Locorum dijlantia, et regiomm differentia
fape fapius cum in colore, atque
Jlatura, tum in animalium temperamento
eximias exhibet difparitates. Hinc
fit non raro, ut eadem fpecies pluribus
fit obnoxia varietatibus, qua a natali
indole, et primigenia forma originalitate
admodum diflant. Inter cater a efio
exemplum homo; cujus fpecies etfi tota
in tellure uniformis, attamen diverfis in
regionibus fummopere efl varia, ut ex
Europaorum cum Afiaticis, atque Afris
comparatione liquet, et multo magis Alpinorum
cum Patagonibus, et Paganorum
cum Barbaris efi manifejlum. Nil
Hl 1
I !
JP
I
ä «
' t .
J i l l
• i '"í' S '!!•
i 1
'i ': :
; ',1