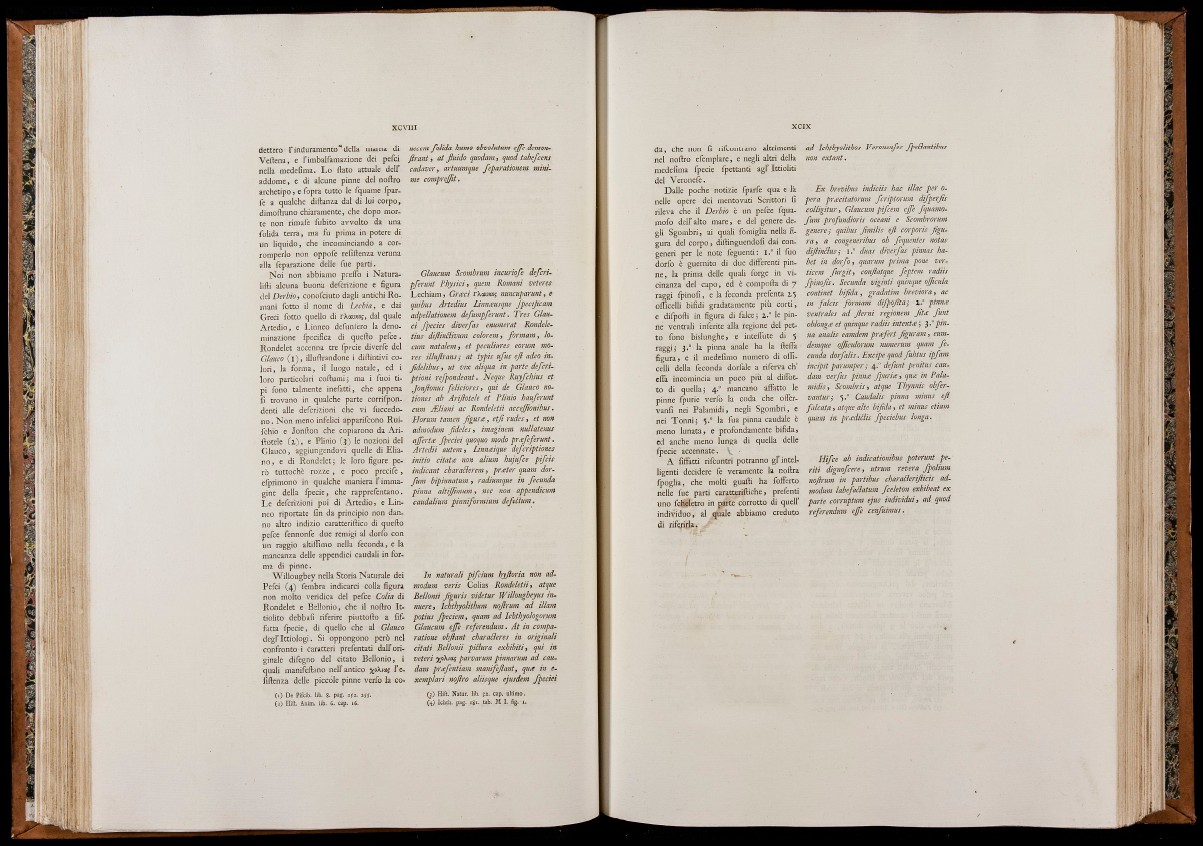
XCVIII
dettero r induramento" della marna di
Veftena, e l'imbalfamazione dei pefci
nella medeQma. Lo flato attuale dell'
addome, e di alcune pinne del noftro
archetipo, e fopra tutto le fquame fparfe
a qualche diftanza dal di lui corpo,
dimoftrano chiaramente, che dopo morte
non rimafe fubito avvolto da una
folida terrà, ma fu prima in potere di
un liquido, che incominciando a corromperlo
non oppofe refiftenza veruna
alla feparazione delle fue parti.
Noi non abbiamo preflb i Naturalifti
alcuna buona defcrizione e figura
òtìDerbio, conofciuto dagli antichi Romani
fotto il nome di Lechia, e dai
Greci fotto quello di rXotuxo;, dal quale
Artedio, e Linneo defunCero la denominazione
fpecifica di quefto pefce.
Rondelet accenna tre fpecie diverfe del
Glauco ( l), illuftrandone i diftintivi colori,
la forma, il luogo natale, ed i
loro particolari coftumi; ma i fuoi tipi
fono talmente inefatti, che appena
fi trovano in qualche parte corrifpondenti
alle defcrizioni che vi fuccedo-
110. N o n meno infelici apparifcono Ruifchio
e Jonfton che copiarono da Ariftotele
(l), e Plinio (3) le nozioni del
Glauco, aggiungendovi quelle di Eliario,
e di Rondelet; le loro figure però
tuttoché rozze , e poco precife ,
efprimono in qualche maniera l'immagine
della fpecie, che rapprefentano.
L e defcrizioni poi di Artedio, e Linneo
riportate fin da principio non danno
altro indizio caratteriflico di quefto
pefce fennonfe due remigi al dorfo con
un raggio altiiTimo nella feconda, e la
mancanza delle appendici caudali in forma
di pinne.
Willougbey nella Storia Naturale dei
Pefci (4) fembra indicarci colla figura
non molto veridica del pefce Colia di
Rondelet e Bellonio, che il noftro Ittiolito
debbafi riferire piuttofto a fiffatta
fpecie, di quello che al Glauco
degl'Ittiologi. Si oppongono però nel
confronto-i caratteri prefentati dall'originale
difegno del citato Bellonio, i
quali manifeftano nelf antico ^o^ittf l'efìftenza
delle piccole pinne verfo la co-
(1) De Pifcib. lib. 8. pag. ifi. 2ff.
(1) Hia. ànim. lib. S. cap. 16.
nccem folida humo obvolutum ejfc demonftrmt,
at jfluido quodam, quod tabefcens
cadaver, artuumque fcparationem mini,
me comprejfit.
Glaiicum Scombrum incuriofe defcvi.
pfenmt Fhysici, quem Romani veteres
Lechiam, Graci rXauxo; nuncuparunt, e
quibus Artcdius Linttisusque fpecißcam
adpellationem defumpferunt. Tres Cianci
/pedes diverfas enumerai Rondeletius
diflinóíivum colorem, formam, locum
natalem, et peculiares eorum mores
illußrans; at typis ufus efl adeo in.
fidelibus, ut vix aliqua in parte defcri.
ptioni refpondeant. Neque Ruyfchius et
Jonflonus feliciores, qui de Glauco no.
tiones ab Ariflotele et Plinio hauferunt
cum Miani ac Rondeletii acceffionibus.
Horum tarnen figune, etfi rudes, et non
admodum fideles, imaginem nullatenus
ajfertie fpeciei quoque modo pnefeferunt.
Artedii autem, Linnieique defcriptiones
initio citata non alium hujufce pifcis
indicant charaQerem, prceter quam dorfum
bipinnatum, radiumque in fecunda
pinna altijjimum, nec non appendicum
caudalium pinniformium defeäum.
In naturali pifcium lyyjioria non admodum
veris Colias Rondeletii, atque
Bellona Jìguris videtur WiUougbeyus in.
nuere, Ichthyolitbum nojirum ad Uhm
potius fpeciem, quam ad Ichtbyologorum
Glaucum effe referendum. At in comparatione
objiant charaBeres in originali
citati Bellona piéiura exhibitit qui in
veteri xoX'cts parvarum pinnarum ad cau.
dam prcefentiam manifejlant, qua in e.
xemplari noftro aliisque ejusdem fpeciei
Q) Hift. Natur. lib, cap. ultimo.
(4) Ichtli. pag. 181. tab. M I. fig. i.
J- !1.. . S'
XCIX
r
da, che non fi rifcontrano altrimenti
nel noftro efemplare, e negli altri della
medefima fpecie fpettanti agi' Ituoliti
del Veronefe.
Dalle poche notizie fparfe qua e là
nelle opere dei mentovati Scrittori il
rileva che il Derbio è un pefce fquamofo
dell'alto mare, e del genere degli
Sgombri, ai quali fomiglia nella figura
del corpo, diftinguendofi dai congeneri
per le note feguenti : I i l fuo
dorfo è guernito di due differenti pinne,
la prima delle quali forge in vicinanza
del capo, ed è compofta di 7
raggi fpinofi, e la feconda prefenta 15
olficelli bifidi gradatamente più corti,
e difpofti in figura di falce; le pinne
ventrali inferite alla regione del petto
fono bislunghe, e inteflute di 5
raggi; 3.° la pinna anale ha la flreffa
figura, e il medefimo numero di officelli
della feconda dorfale a riferva eh'
c f i i incomincia un poco più al diifof^
to di quella; 4.° mancano affatto le
pinne fpurie verlb la coda che oifervanfi
nei Palamidi, negli Sgombri, e
nei Tonni; 5.° la fua pinna caudale è
meno lunata, e profondamente bifida,
ed anche meno lunga di quella delle
fpecie accennate. V •
A fifFatti rifcontri potranno gl'intelligenti
decidere fe veramente la noftra
fpoglia, che molti guafti ha fofferto
nelle fue parti caratteriftiche, prefenti
uno fcheletro in parte corrotto di queU'
individuo, al quale abbiamo creduto
di riferirla.
ad Ichtbyolithos Veronenfes fpeSantibus
non extant.
Ex brevibus indiciis hac illac per 0.
pera pr¡ecitatorum fcriptorum difperßs
colligitur, Glaucum pifcem eje fquamofum
profundioris oceani e Scombrorum
genere^ quibus ßmilis eft corporis figura,
a congeneribus ob fcquentes notas
diftinäusi duas di-oerfas pinnas habet
in dorfo, quarum prima pone verticem
furgit, confiât que feptem radiis
fpinofis. Secunda viginti quinqué oßicula
continet bifida, gradatim breviora, ac
in falcis formam difpofita^ 1.° pinna
ventrales ad fterni regionem fita funt
oblonga et quinqué radiis intexta ; 3pinna
analis eamdem prafert figuram, eumdemque
officulorum numerum quam fecunda
dorfalis. Excipe quod fubtus ipfam
incipit parumper i 4.° défunt penitus caudam
verfus pinna fpuria, qua in Palamidis,
Scombris, atque Tbynnis obfervantar
i 5.° Caudalis pinna minus efi
falcata, atque alte bifida, et minus etiam
quam in prlidiáis fpeciebus longa.
Hifce ab indicationibus poterunt pe.
riti dignofcere, utrum revera fpolium
nofirum in partibus charaSerifticis admodum
labefaBatum fceleton exbibeat ex
parte corruptum ejus individui, ad quod
referendum effe cenfuimus.
'f
i '.i fi
M! I
•î^' i
i , . I "
ü• T '
1|,
I Î
; i ; j
1
IíiI