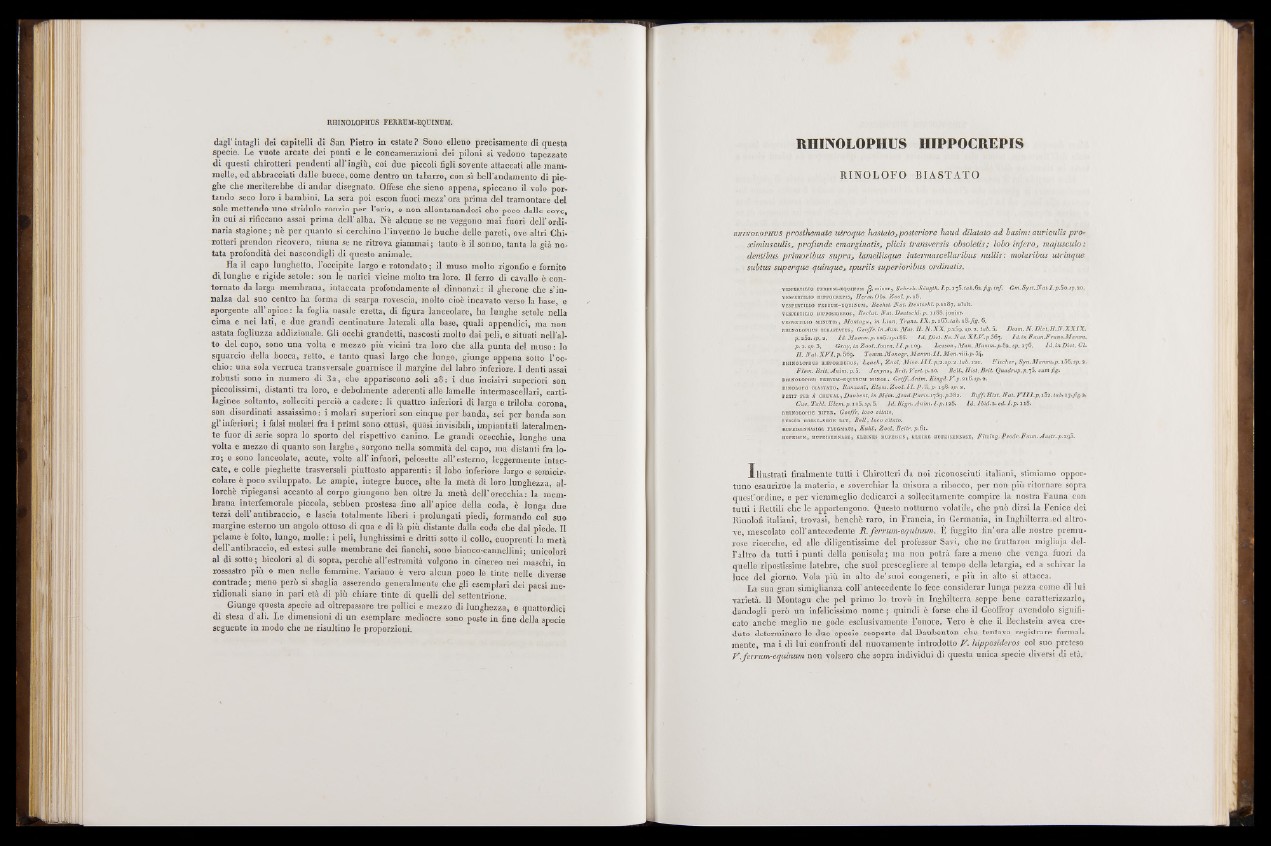
dagl’ intagli dei capitelli di San Pietro in estate ? Sono elleno precisamente di questa
specie. Le vuote arcate dei ponti e le concamerazioni dei piloni si vedono tapezzate
di questi chirotteri pendenti all’ingiù, coi due piccoli figli sovente attaccati alle mani-
melle, ed abbracciati dalle bucce, come dentro un tabarro, con si bell’andamento di pie-
ghe che meriterebbe di andar disegnato. Offese che sieno appena, spiccano il volo por-
tando seco loro i bambini. La sera poi escon fuori mezz’ ora prima del tramontare del
sole mettendo uno stridulo ronzio per l’aria, e non allontanandosi che poco dalle cove,
in cui si rificcano assai prima delP alba. Nè alcune se ne veggono mai fuori dell’ordi-
naria stagione; nè per quanto si cerchino l ’inverno le buche delle pareti, oye altri Chirotteri
prendon ricovero, niuna se ne ritroya giammai; tanto è il sonno, tanta la già no-
tata profondità dei nascondigli di questo animale.
Ha il capo lunghetto, l’occipite largo e rotondato ; il muso molto rigonfio e fornito
dUunghe e rigide setole: son le narici yicine molto tra loro. Il ferro di cayallo è con-
tornato da larga membrana, intaccata profondarnente al dinhanzi: il gherone ehe s’in-
nalza dal suo centro ha forma di scarpa rovescia, molto cioè incavato verso la base, e
sporgente all’ apice: la foglia nasale eretta, di figura lanceolare, ha lunghe setole nella
cima e nei lati, e due grandi centinature laterali alla base, quali appendici, ma non
astata fogliuzza addizionale. Gli occhi grandetti, nascosti molto dai peli, e situati nell’al-
to del capo, sono una volta e mezzo più yicini tra loro ehe alla punta del muso: lo
squarcio della bocca, retto, e tanto quasi largo ehe lungo, giunge appena sollo Poc-
chio: una sola verruca transversale guarnisce il margine del labro inferiore. I denti assai
robusti sono in numéro di 32, ehe appariscono soli 28: i due incisiyi superiori son
piccolissimi, distanti tra loro, e debolmente aderenti aile lamelle intermascellari, carti-
laginee soltanto, solleciti percio a cadere: li quattro inferiori di larga e triloba corona,
son disordinati assaissimo: i molari superiori son cinque per banda, sei per banda son
gPinferiori; i falsi molari fra i primi sono ottusi, quasi invisibili, impiantati lateralmen-
te fuor di sérié sopra lo sporto del rispettivo canino. Le grandi orecchie, lunghe una
volta e mezzo di quanto son larghe, sorgono nella sommità del capo, ma distanti fra loro;
e sono lanceolate, acute, volte alPinfuori, pelosette alPesterno, leggermente intac-
cate, e colle pieghette trasversali piuttosto apparenti : il lobo inferiore largo e semicir-
colare è poco sviluppato. Le ampie, intégré bucce, alte la metà di loro lunghezza, al-
lorchè ripiegansi accanto al corpo giungono ben oltre la metà delP oreçchia : la membrana
interfemorale piccola, sebben prostesa fino alPapice della coda, è lunga due
terzi delP antibraccio, e lascia totalmente liberi i prolungati piedi, formando col suo
margine esterno un angolo ottuso di qua e di là più distante dalla coda che dal piede. Il
pelame è folto, lungo, molle: i peli, lunghissimi e drilti sotto il collo, cuoprenti la metà
delP antibraccio, ed estesi sulle membrane dei fianchi, sono bianco-cannellini • unicolori
al di sotto; bicolori al di sopra, perche all’estremità yolgono in cinereo nei maschi, in
rossastro più o men nelle femmine. Variano è vero alcun poco le tinte nelle diverse
eontrade; meno pero si shaglia asserendo generalinente ehe gli esemplari dei paesi me-
ridionali siano in pari età di più chiare tinte di quelli del settentrione.
Giunge questa specie ad oltrepassare tre pollici e mezzo di lunghezza, e quattordicj
di stesa d'ali. Le dimensioni di un esemplare mediocre sono poste in fine della specie
seguente in modo ehe ne risultino le proporzioni.
RHINOLOPHÜS HIPPOCREPIS
RINOLOFO BIASTATO
rhinolophüS prosthemdte utroque hastatOj posteriore haud dilatato ad basim: auriculis pro-
ximiusculiSj profunde emarginatis, plicis transversis obsoletis; lobo inferOj majusculo :
dentibus primoribus supra, lamellisque intermascellaribus nullis: molaribus utrinque
subtus superque quinque, spuriis superioribus ordinatis.
vespertimo ferrom-equinum ß . minor, Schrei. Säugth. I.p. iy 5.tab.62.fig. inf. Gm.Syst.Nat.Lp.5o.ep.20.
VESPERTIMO HIPPOCREPIS, Ilerm.Obs. Zool.p. 18.
VESPERTIMO FERRUM-EQUINUM, Bechst. Nat. Deutschi. p .ll8j. adult.
VESPERTIMO HipposiDEROS, Bechst. Nat. Deutschi. p. 1188. junior.
vespertimo Mi nut us, Montagu, in Linn. Trans. IX . p. i 63. lab. i8.fig. 6.
RHINOLOPHÜS bihastatus, Geojfr. in Ann. Mus. H. N .X X . p.2 5g. sp. a. tab. 5. Desm. N. Diet, Ti. N. X X IX .
p.a5a.sp. a. Id. Mamm.p. ia 5. sp.i85. Id. Diet. S c.Nat.X LV .p .561]. Id .in F aun.Franc.Mamm.
p .i.sp .5. Gray, in Zool. Journ. I I.p. 109. Lesson, Man. Mamm. p.82. sp, 176. Id.inDict. CI.
II. Nat. X V I . p. 56g. Temm.Monogr. Mamm. I I . Mon.Vüi.p.34«
RHINOLOPHÜS hipposideros, Leach, Zool. Mise. I I I . p.2.sp.2. tab. 121. Fischer, Syn.Mamm.p. i 36. sp. 3.
Flein. Brit. Anim. p. 5. Jenyns, Brit. Vert. p. 20. Bell, Hist, Brit. Quadrup, p.’ß . cum fig.
rhinolophus FERRUM-EQUINUM minor. Griff. Anim. Kingd. V.p.oiß.sp. 3.
RINOLOFO BIASTATO, Ranzani, Eiern. Zool. I I . P. ii. p- 198. sp. 2.
Petit fer £ ÖHEVAL, Daubent. inMem.Acad.Paris.i']5g.p.582. Buff. Hist. Nat. V IH .p .102. tab. ij.fig.2.
Cuv. Tail. Eiern.p. io5.sp.5. Id. Rcgn. Anim. I.p. 128. Id. Ibid.2.ed. I.p. 118.
RH1NOLOPHE BiFER, Geoffr. loco citato,
LESSER HORSE-SHOE BAT, B e ll, loco citato.
HUFE ISEN NASI GE FLUGMAUS, Kühl, Zool. Beilr. p.6l.
HUFEISEN, HUFEISENNASE, KLEINES HUFEISEN, KLEINE HUFEISENNASE, Filzing. Prodr.Faun. Austr. p.2Cß.
Illu stra ti finalmente tutti i Chirotteri da noi riconosciuti italiani, stimiamo oppor-
tuno esaurirne la materia, e soverchiar la misura a ribocco, per non più ritornare sopra
quest’ordine, e per viemmeglio dedicarci a sollecitamente compire la nostra Fauna con
tutti i Rettili che le appartengono. Questo notturno volatile, che puo dirsi la Fenice dei
Rinolofi italiani, trovasi, benchè raro, in Francia, in Germania, in Inghilterra-ed altro-
ve, mescolato coll’antecedente R.ferrum-equinum. È fuggito fin’ora aile nostre premu-
rose ricerche, ed aile diligentissime del professor Savi, che ne fruttaron migliaja del-
l’altro da tutti i punti della penisola; ma non potrà fare a meno che venga fuori da
quelle ripostissime latebre, che suol prescegliere al tempo della letargia, ed a schivar la
luce del giorno. Vola più in alto de’suoi congeneri, e più in alto si attacca.
La sua gran simiglianza coll’ antecedente lo feCe considerar lunga pezza come di lui
yarietà. Il Montagu che pel primo lo trovo in Inghilterra seppe bene caratterizzarlo,
dandogli pero un infelicissimo nome ; quindi è forse che il Geoffroy avendolo signifi-
cato anche meglio ne gode esclusivamente l’onore. Vero è che il Bechstein avea cre-
duto determinare le due specie scoperte dal Daubenton che tentava registrare formal-
mente, ma i di lui confronti del nuovamente introdotto V. hipposideros col suo preteso
V.ferrum-equinum non yolsero che sopra indiyidui di questa unica specie diversi di età.