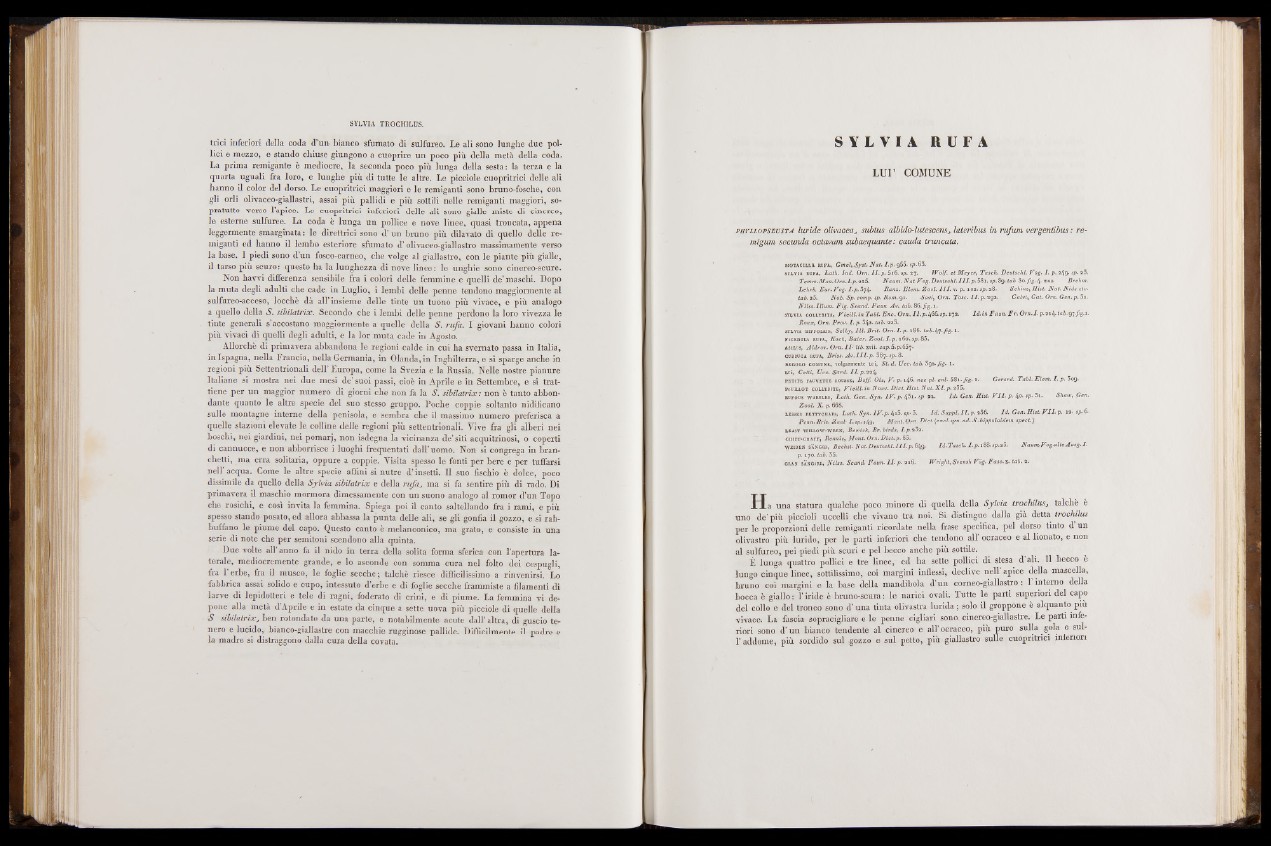
P :
trici inferiori della coda d’u n bianco sfumato di sulfureo. Le ali sono lunghe due pol-
lici e mezzo, e stando clause giungono a cuoprire un poco piu della meta della coda.
La prima remigante b mediocre, la seconda poco piu lunga della sesta: la terza e la
quarta uguali fra loro, e lunghe piu di tutte le altre. Le picciole cuopritrici delle ali
hanno il color del dorso. Le cuopritrici maggiori e le remiganti sono bruno-fosche, con
gli orli oliyaceo-giallastri, assai piu pallidi e piu sottili nelle remiganti maggiori, so-
pratutto verso l’apice. Le cuopritrici inferiori delle ali sono gialle miste di cinereo,
le esterne sulfuree. La coda b lunga un pollice e nove linee, quasi troncata, appena
leggermente smarginata: le direttrici sono d’ un bruno piu dilavato di quello delle remiganti
ed hanno il lembo esteriore sfumato d’ olivaceo-giallastro massimamente verso
la base. I piedi sono d’un fosco-carneo, che volge al giallastro, con le piante piu gialle,
il tarso piu scuro: questo ha la lunghezza di nove linee: le unghie sono cinereo-scure.
Non hawi differenza sensibile fra i colori delle femmine e quelli de’ maschi. Dopo
la muta degli adulti che cade in Luglio, i lembi delle penne tendono maggiormente al
sulfureo-acceso, locchk da all’insieme delle tinte un tuono piu vivace, e piu analogo
a quello della S. sibilatrix. Secondo che i lembi delle penne perdono la loro vivezza le
tinte generali s’accostano maggiormente a quelle della S. rufa. I giovani hanno colori
piu vivaci di quelli degli adulti, e la lor muta cade in Agosto.
Allorche di primavera abbandona le regioni calde in cui ha svernato passa in Italia,
inlspagna, nella Francia, nella Germania, in Olanda.in Inghilterra, e si sparge anche in
regioni piu Settentrionali dell’ Europa, come la Svezia e la Russia. Nelle nostre pianure
Italiane si mostra nei due mesi de’ suoi passi, cioe in Aprile e in Settembre, e si trat-
tiene per un maggior numero di grorni che non fa la S. sibilatrix: non e tanto abbon-
dante quanto le altre specie del suo stesso gruppo. Poche coppie soltanto nidificano
sulle montagne interne della penisola, e sembra che il massimo numero preferisca a
quelle stazioni elevate le colline delle regioni piu settentrionali. Vive fra gli alberi nei
boschi, nei giardini, nei pomarj, non isdegna la vicinanza de’siti acquitrinosi, o coperti
di cannucce, e non abborrisce i luoghi frequentati dairuomo. Non si congrega in bran-
chelti, ma erra solitaria, oppure a coppie. Visita spesso le fonti per bere e per tuffarsi
nell acqua. Come le altre specie affini si nutre d’insetti. Il suo fischio e dolce, poco
dissimile da quello della Sylvia sibilatrix e della r u f a ma si fa sentire piu di rado. Di
primavera il maschio mormora dimessamente con un suono analogo al romor d’un Topo
che rosichi, e cosi invita la femmina. Spiega poi il canto saltellando fra i rami, e piu
spesso stando posato, ed allora abbassa la punta delle ali, se gli gonfia il gozzo, e si rab-
buffano le piume del capo. Questo canto e melanconico, ma grato, e consiste in una
serie di note che per semitoni scendono alia quinta.
Due volte all’ anno fa il nido in terra della solita forma sferica con l ’apertura la-
terale, mediocremente grande, e lo asconde con somma cura nei folto dei cespugli,
fra 1 erbe, fra il musco, le foglie secche; talchb riesce difficilissimo a rinvenirsi. Lo
fabbrica assai solido e cupo, intessuto d’erbe e di foglie secche frammiste a filamenti di
larve di lepidotteri e tele di ragni, foderato di crini, e di piume. La femmina vi depone
alia meta d’Aprile e in estate da cinque a sette uova piu picciole di quelle della
- S sibilatrix| ben rotondate da una parte, e notabilmente acute dali’altra, di guscio te-
nero e lucido, bianco-giallastre con macchie rugginose pallide. Difficilmente il padre e
la madre si distraggono dalla cura della covata.
E
LUI’ COMUNE
p h y l l o p se u s t a luride olivaceOj subtus albido-lutescenSj lateribus in rufum vergentibus: re-
mi gum secunda octavam subacquante: cauda truncata.
motacillA rufa, Gmel, Syst. Nat. I.p. 955. sp.63.
sylvia rufa, Lath. Ind. Orn. II. p. 5 i 6. sp. 27. Wolf, et Meyer, Tasch. Deutschl. Fog. I. p, 249- sp. 2 3 .
Temm.Man.Orn.I.p. 22 5 . Naum. Nat.Fog. Deutschl. III. p. 5 8 l. sp.89. tab 80. fig. 4. mas. Brehm.
Lehrb. Ear. Vog. I.p. 574. Rani. Elem. Zool, III. v. p. 102. sp. 28. Sc him, Hist. Nat. Nids etc.
tab. 2 3 . Nob. Sp. comp. sp. Rom. 91. Savi, Orn. Tosc. I I . p. 292. Calvi, Cat. Orn. Gen. p. 5 i.
Nilss. Ilium. Fig. Scand. Faun Av. tab. 86. fig. 1.
sylvia collybita, Fieill. in TabL Enc. Orn. /I .p .466.jp. 172. ld.inFaun.Fr. Om.I.p.2i4-tab.Qffig.l.
Roux, Orn. Prov. I. p. 342. tab. 2 2 3 .
SYLVIA HIPI'OLAIS, Selby, III. Brit. Orn. I. p. 186. tab.lfl.fig. I.
ficedula rufa, Koch, Baier. Zool. I. p. 160. sp. 8 5 .
ASiLcs, Aldrov. Orn. I F lib. ,xvii. cap.5.p.&5 -].
CDRRUCA RUFA, Briss. Av. III. p. 387. Sp. 8.
regolo couune, Yolgarmente Lui, St. d. Ucc. tab. OQO.fig. 1.
Lui, Cetti, Ucc. Sard. II. p. 224.
petite fauvette rousse, Buff. Ois, V. p. 146. nee pi. enl. 5 8 1. fig. i . Gerard. Tabl.Elem. I. p. 3og.
pouillot collybite, Vieill. in Nouv. Diet. Hist. Nat. XI. p. 23 5 .
rufous warbler, Lath. Gen. Syn. IF. p. 4 5 '1'- sp 22. Id. Gen. Hist. VIL p. 4 °- SP- 3i. Shaw, Gen.
Zool. X. p. 668.
lesser pettychaps, Lath. Syn. IV.p.^Z . sp- 3. Id. S u ppl.il.p. 23 6 . Id. Gen. Hist. V II.p. 12. sp.6.
Penn. Brit. Zool• /. sp. 149. Mont. Orn. Diet, (exc l syn. ad. S. hippolaidem sped.)
LEAST WILLOW-WREN, Bewick, Br. birds, I.p.232.
chiff-chaff, Rennie, Mont. Orn. Diet. p. 83.
WEIDEN SANGER, Bechst. N at.Deulschl. 111. p. 649. Id. Tasch. I. p. 188. sp. 2 3 . Naum.Fog.alte A usg. I.
p. 170. tab. 3 5 .
GRAN sangare, Nilss. Scand. Faun. II. p. 216. Wright, Svensk Fog. Fasc. s. tab. 2.
H a una statura qualche poco minore di quella della Sylvia trochilusj talche e
uno de’ piu piccioli uccelli che vivano tra noi. Si distingue dalla gia detta trochilus
per le proporzioni delle remiganti ricordate nella frase specifica, pel dorso tinto d uo
olivastro piu lurido, per le parti inferiori che tendono all ocraceo e al lionato, e non
al sulfureo, pei piedi piu scuri e pel becco anche piu sottile.
E lunga quattro pollici e tre linee, ed ha sette pollici di stesa d ali. Il becco e
lungo cinque linee, sottilissimo, coi margini inflessi, declive nell apice della mascella,
bruno coi margini e la base della mandibola d un corneo-giallastro: 1 interno della
bocca b giallo: l’iride b bruno-scura: le narici ovali. Tutte le parti superiori del capo
del collo e del tronco sono d’ una tinta olivastra lurida; solo il groppone e alquanto piu
vivace« La fascia sopracigliare e le penne cigliari sono, cinereo-giallastre. Le parti inferiori
sono d’ un bianco tendente al cinereo e all’ ocraceo, piu puro sulla gola e sul-
1’ addonie, piu sordido sul gozzo e sul petto, piu giallastro sulle cuopritrici inferiori