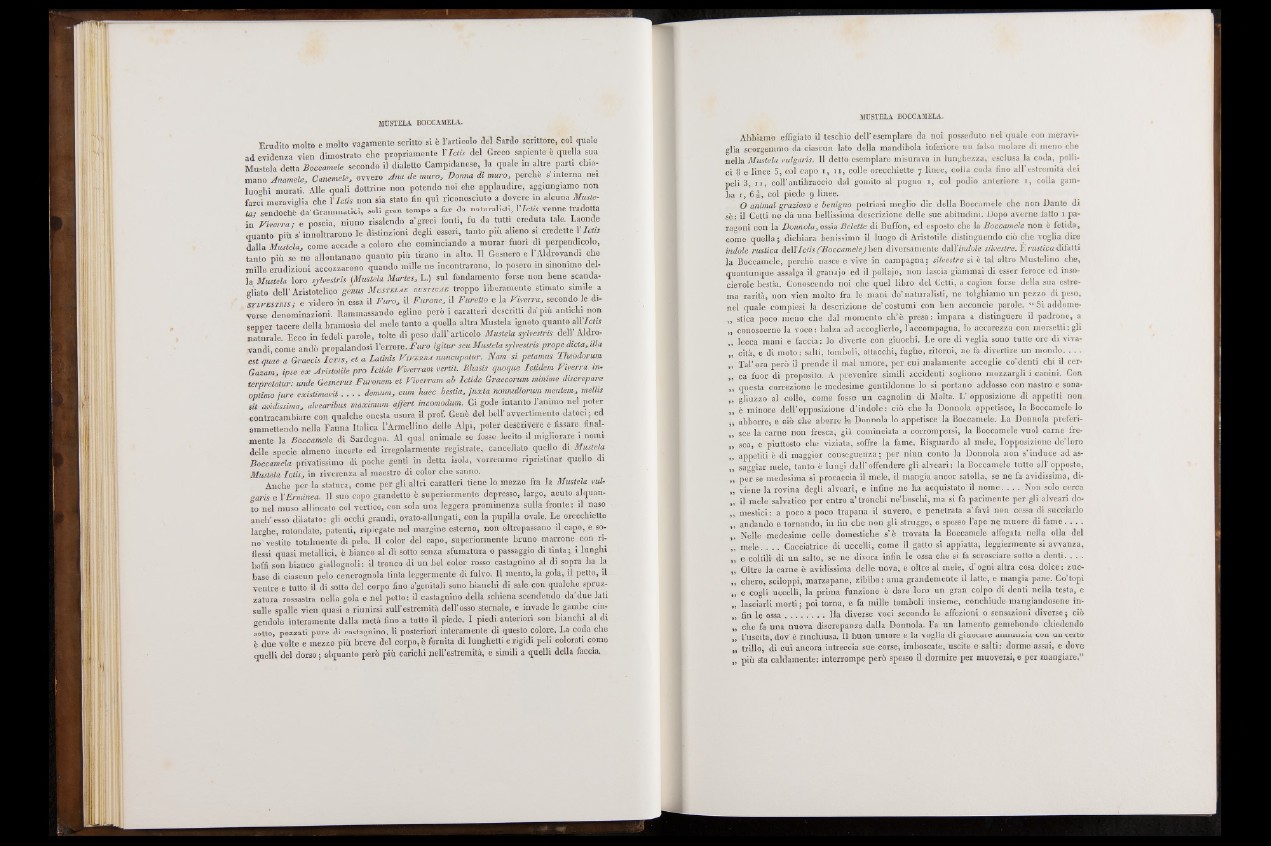
MUSTELA BOCCAMELA.
Erudito molto e molto vagamente scritto si è l’articolo del Sardo scrittore, col quale
ad evidenza -rien dimostrato ehe propriamente Y Ictis del Greco sapiente è quella sua
Mustela delta Boccamele seconde il dialetto Campidanese, la quale m altre part! dm -
mano Anamele^ Canemele, ovvero Ana de murOj Donna di muroJ perché s interna nei
luoghi murati. Alle quali dottrine non potendo noi ehe applaudire, aggiungiamo non
farci meraviglia ehe VIctis non sia stato fin qui riconosciuto a dovere in alcuna Mustel
a , sendochè da'Graminatici, soli gran tempo a far da naturalisti, VIctis Tenne tradotta
in Viverra; e poscia, niuno risalendo a’greci fonti, fu da tutti creduta tale. Laonde
quanto più s’ innoltrarono le distinzioni degli esseri, tanto più alieno si credette VIctis
dalla Mustela, come aceade a coloro ehe cominciando a murar fuori di perpendicolo,
tanto più se ne allontanano quanto pip tirano in alto. Il Gesnero e l'Aldrovandi ehe
mille erudizioni accozzarono quando mille ne incontrarono, lo posero in sinommo della
Mustela loro sylvestris (Mustela Martes, L.) sul fondamento forse non bene scanda-
gliato dell’ Aristotelico genus Mostbiae iwsticae troppo liberamente stimato simile a
snrESTnis; e Tidero in essa il Furo, il Furone, U Furetto e la Viverra, secondo le diverse
denominazioni. Rammassando eglino péri) i caratteri descritti da più antichi non
sepper tacere della bramosia del mele tanto a quella altra Mustela ignoto quanto all Feus
naturale. Ecco in fedeli parole, tolte di peso dall’ articolo Mustela sylvestris dell’ Aldro-
vandi, corne andô propalandosi l ’errore. Furo igitur seu Mustela sylvestris prope dicta, ilia
est quae a Graecis I ctis, et a Latinis ViremA nuncupatur. Nam si petamus Theodorum
Gazant, ipse ex Jristotüe pro Ictide Viverram vertit. Bhasis quoque Ictidem Viverra in-
terpretatur: unde Gesnerus Furonem et Viverram ab Ictide Graecorum minime discrepare
optima jure existimavit____demum,-cum haec bestia, juxta nonmdlorum mentent, mellis
sit avidissima, alvearibus maximum offert incomodum. Ci gode intanto l'animo nel poter
contracambiare con qualche onesta usura il prof. Genè del bell’avyertimento dato«; ed
ammettendo nella Fauna Italica l'Armellino delle Alpi, poter descriyere e fissare. final-
mente la Boccamele di Sardegna. Al quai animale se fosse lecito il migliorare i noroi
delle specie almeno incerte ed irregol arm ente xegislrate, cancellato quello di Mustela
Boccamela priyatissimo di poche genii in delta isola, yorremmo ripristinar quello di
Mustela Ictis, in riverenZa al maestro di color che sanno. . r .,.
Anche per la statura, come per gli altri caratteri tiene lo mezzo fra la Mustela vulgaris
e YErminea. 11 suo capo grandetto è superiormente depresso, largo,: acuto alquan-
to nel muso allineato col yertice, con sola una leggera prominenza sulla fronte: il naso
anch’ esso dilatato: gli occhi grandi, oyato-allungati, con la pupilla oyale. Le orecchiette
larghe, rotondate, patenti, ripiegate nel margine esterno, non oltrepassano il capo, e. sono
°vesùte totalmente di pelo. 11 color del capo, superioxmente bruno marrone .con ri-
flessi quasi metallici, è bianco al di sotto senza sfùmatura o passaggio di tinta; i lunghi
baffi son bianco giallognoli: il tronco di un bei color rosso castagnino al di sopra ha la
base di ciascun pelo cenerognola tinta leggermente di fulyo. 11 mento, la gola, il petto, il
ventre e tutto il di sotto del corpo lino a’genilali sono bianchi di sale con qualche sptuz-
zatura rossastra nella gola e nel petto: il. castagnino della schiena scendendo da’due Jati
sulle spälle vien quasi a riunirsi sull’estremità dell’osso sternale, e invade le gambe cin-
gendole interamente dalla metà fino a tutto il piede, I piedi anteriori son bianchi al di
sotto, pezzati pure di castagnino, li posteriori interamente di questo colore. La ebda che
è due volte e mezzo più breve del corpo, è fornita di lunghetti e rigidi peli colorati come
quelli del dorso ; alquanto perô più carichi nell’estremità, e simili a quelli della faccia.
Abbiamo éffigiato il teschio dell’esemplare da noi posseduto nel quale con meravi-
glia scorgemmo da ciascun lato della mandibola inferiore un fa Iso molare di meno che
nella Mustela vulgaris. II detto esemplare misuraya in lunghezza, esclusa la coda, polli-
ci 8 e linee 5, col capo i , 11, colle orecchiette 7 linee, colla coda fino all’ estremità dei
peli 3, i i , coll’ antibraccio dal gomito al pugno 1, col podio anleriore 1, colla gamba
i, 6i , col piede 9 linee.
O animal grazioso e benigno potriasi meglio dir della Boccamele che non Dante di
sè: il Cetti ne da una bellissima descrizione delle sue abitudini. Dopo ayerne fatto i pa-
ragoiii con la Donnola, ossia Belette di Buffon, ed esposto che la Boccamele non è fetida,
come quella; dichiara benissimo il luogo di Aristotile distinguendo cio che voglia dire
indole rustica dell’/ciis ( Boccamele) ben diversamente izlYindole silvestre. E rustica difatti
la Boccamele, perche nasce e vive in campagna ; silvestre si è tal altro Mustelino che,
quantunque assalga il granajo ed il pollajo, non lascia giammai di esser feroce ed inso-
cievole bestia. Conoscendo noi che quel libro del Cetti, a cagion forse della sua estre-
ma rarilà, non vien molto fra le mani de’naturalisti, ne tolghiamo un pezzo di peso,
nel quale compiesi la descrizione de’costumi con ben acconcie parole. “ Siaddome-
,, stica poco meno che dal momento ch è presa: impara a distinguere il padrone, a
,, conoscerne la voce : balza ad accoglierlo, 1 accompagna, lo accarezza con morsetti : gli
,, lecca mani e faccia: lo diverte con giuochi. Le ore di yeglia sono tutte ore di viva-
„ cita, e di moto: salti, tomboli, attacchi, fughe, ritorni, ne fa divertire un mondo. . . .
Tal’ora perô il prende il mal umore, per cui malamente accoglie co’denti chi il cei-
„ ca fuor di proposito. A prevenire simili accidenti soglionb mozzargli i canini. Con
Si questa correzione le medesime gentildonne lo si portano addosso con nastro e sona-
„ gliuzzo al collo, come fosse un cagnolin di Malta. L’ opposizione di appetiti non
è minore dell’opposizione d ’indole: cio che la Donnola appetisce, la Boccamele lo
, abhorre, e ciô che aborre k Donnola lo appetisce la Boccamele. La Donnola preferi-
, see la carne non fresca, già cominciata a corrompersi, la Boccamele vuol carne fre-
„ soa, e piuttosto che viziata, soffre la fame. Risguardo al mele, l’opposizione de’loro
„ appetiti è di maggior conseguenza ; per niun conto la Donnola non s’induce ad as-
„ saggiar mele, tanto è lungi dall’offendere gli alveari: la Boccamele tutto all’opposto,
„ per se medesima si procaqcia il mele, il mangia ancor satolla, se ne fa avidissima, di-
viene la rovina degli alveari, e infine ne ha acquistato il nome. . . . Non solo cerca
„ il mele salvatico per entro a'tronchi ne’boschi, ma si fa parimente per gli alveari do-
„ mestici: a poco a poco trapana il suvero, e penetrata a’favi non cessa di succiarlo
„ andando e tornando, in fin che non gli strugge, e spesso Tape ne. muore di fame . . . .
Nelle medesime celle domestiche s’è trovata la Boccamele affogata nella olla del
,, mele....... Cacciatrice di uccelli, come il gatto si appiatta, leggiermente si awanza,
,, e coltili* di un salto, se ne divora infin le ossa che si fa scrosciare sotto a denti. . . .
„ Oltre la carne è avidissima delle uoya, e oltre al mele, d’ogni altra cosa dolce: zuc-
„ chero, sciloppi, marzapane, zibibo: ama grandemente il latte, e mangia pane. Co topi
„ e cogli uccelli, la prima funzione è dare loro un gran colpo di denti nella testa, e
„ lasciarli morti; poi torna, e fa mille tomboli insieme, conchiude mangiandosene infin
le ossa.................Ha diverse voei secondo le affezioni o sensazioni diverse; cio
„ che fa una nuova discrepanza dalla Donnola. Fa un lamento gemehondo chiedendo
„ Tuscita, dov’ è rinchiusa, II buon umore e la voglia di giuocare annunzia con un certo
„ trillo, di cui ancora intreccia sue corse, imboscate, uscite e salti: dorme assai, e dove
„ più sta caldamente: interrompe perô spesso il dormire per muoversi, e per mangiare.”