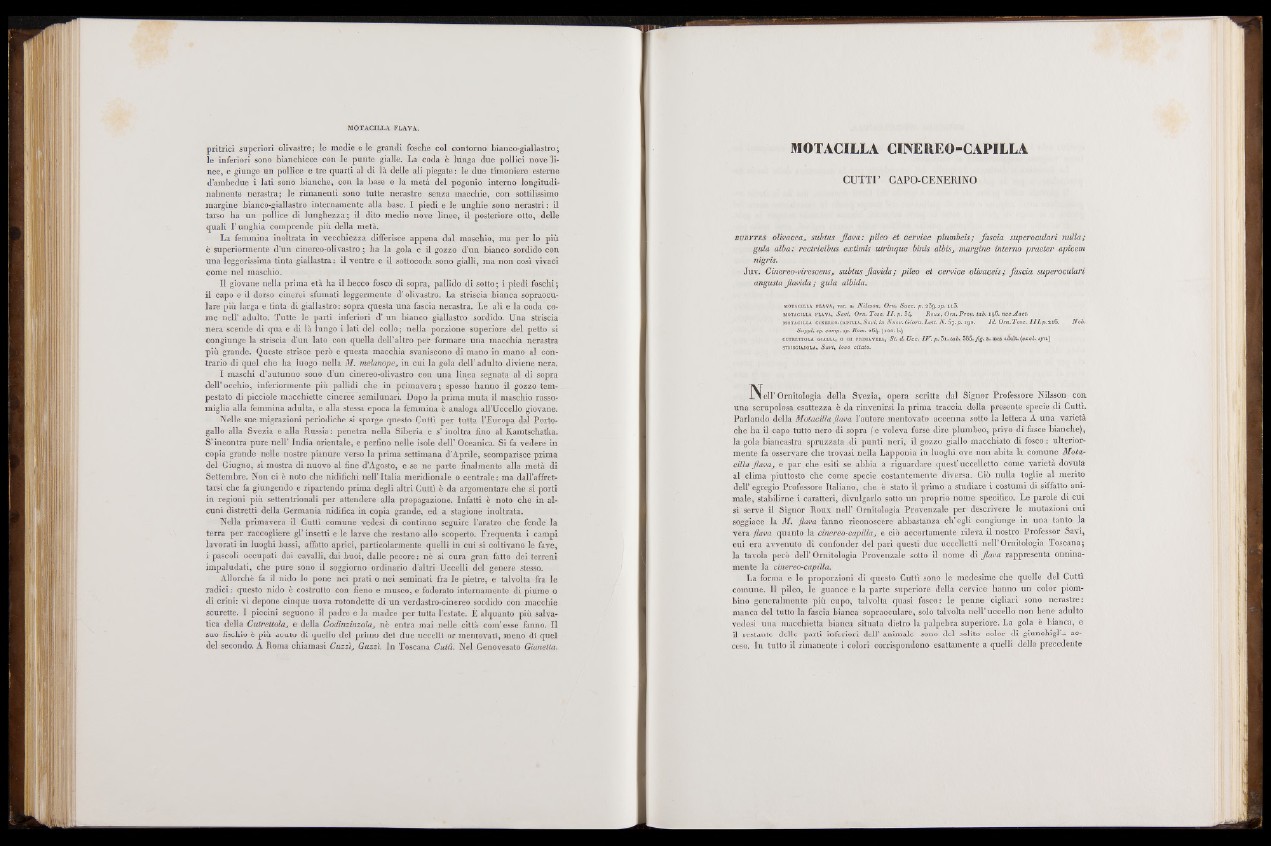
pritrici superiori olivastre; le medic e le grandi fosche col contorno bianco-giallastro;
le inferiori sono bianchicce con-le punte gialle. La coda e lunga due pollici noveli-
nee, e giunge un pollice e tre quarti al di la delle ali piegate: le due timoniere esterne
d’ambedue i lati sono bianche, con la base e la metä del pogonio interno longitudinalmente
nerastra; le rimanenti sono tutte nerastre senza macchie, con sottilissimo
margine bianco-giallastro internamente alia base. I piedi e le ungkie sono nerastri: il
tarso ha un pollice di lunghezza; il dito medio nove linee, il posteriore otto, delle
quali 1’ unghia comprende piu della metä.
La femmina inoltrata in vecchiezza differisce appena dal maschio, ma per lo piü
e superiormente d’un cinereo-olivastro; ha la gola e il gozzo d’un bianco sordido con
una leggerissima tinta giallastra: il ventre e il sottocoda sono gialli, ma non cosi vivaci
come nel maschio.
Il giovane nella prima etä ha il becco fosco di sopra, pallido di sotto; i piedi foschi;
il capo e il dorso cinerei sfumati leggermente d’ olivastro. La striscia bianca sopraocu-
lare piu larga e tinta di giallastro: sopra questa una fascia nerastra. Le ali e la coda come
nelT adulto. Tutte le parti inferiori d’ un bianco giallastro sordido. Una striscia
nera scende di qua e di la lungo i lati del collo; nella porzione superiore del petto si
congiunge la striscia d’un lato con quella dell’altro per formare una macchia nerastra
piü grande. Queste strisce perö e questa macchia svaniscono di mano in mano al contrario
di quel che ha luogo nella M. melanopein cui la gola dell’ adulto diviene nera.
I maschi d ’autunno sono d’un cinereo-olivastro con una linea segnata al di sopra
dell’ occhio, inferiormente piu pallidi ehe in primavera j spesso hanno il gozzo tem-
pestato di picciole macchiette cineree semilunari. Dopo la prima muta il maschio rasso-
miglia alia femmina adulta, e alia stessa epaca la femmina e analoga aU’Uccello giovane.
Nelle sue migrazioni periodiche si sparge questo Cutti per tutta l’Europa dal Porto-
gallo alia Svezia e alia Russia: penetra nella Siberia e s’ inoltra lino al Kamtschatka.
S’incontra pure nell’ India orientale, e perfino nelle isole dell’ Oceanica. Si fa vedere in
copia grande nelle nostre pianure verso la prima settimana d’Aprile, scomparisce prima
del Giugno, si mostra di nuovo al fine d’Agosto, e se ne parte finalmente alia metä di
Settembre. Non ci e noto ehe nidifichi nell’ Italia meridionale o centrale: ma dall’affret-
tarsi ehe fa giungendo e ripartendo prima degli altri Cutti e da argomentare ehe si porti
in regioni piu settentrionali per attendere alia propagazione. Infatti b noto ehe in al-
cuni distretti della Germania nidifica in copia grande, ed a stagione inoltrata.
Nella primavera il Cutti comune vedesi di continuo seguire l’aratro ehe fende la
terra per raccogliere gl’ insetti e le larve ehe restano alio scoperto. Frequenta i campi
lavorati in luoghi bassi, affatto aprici, particolarmente quelli in cui si coltivano le fave,
i pascoli occupati dai cavalli, dai buoi, dalle pecore: ne si cura gran fatto dei terreni
impaludati, ehe pure sono il soggiorno ordinario d’altri Uccelli del genere stesso.
Allorche fa il nido lo pone nei prati o nei seminati fra le pietre, e talvolta fra le
radici: questo nido e costrutto con fieno e musco, e foderato internamente di piume o
di crini: vi depone cinque uova rotondette di un verdastro-cinereo sordido con macchie
scurette. I piccini seguono il padre e la madre per tutta Testate. E alquanto piü salva-
tica della Cutrettoldj e della Codinzinzola_, ne entra mai nelle cittä com’esse fanno. Il
suo fischio e piu acuto di quello del primo dei due uccelli or mentovati, meno di quel
del secondo. A Roma chiamasi Cuzzij Guzzl. In Toscana Cutti. Nel Genovesato Gianetta.
CUTTI’ CAPO-CENERINO
b u d y t e s olivacea, subtus flava: pileo et cervice plumbeis; fascia superoculari nulla;
gula alba: rectricibus extimis utrinque binis albis3 margine interno praeter apicem
■nigris.
Juv. Cinereo-virescenSj subtus flavida; pileo et cervice olivaceis; fascia superoculari
angusta flavida; gula albida.
motacilla flava, Tar. a. Nilsson. Orn. Suec. p. 23g. sp. I i 3.
MOTACILLA flava, Savi, Orn. Tose. II. p. 3 4 . Roux, Orn. Prop. tab. 19.6. nec Auct.
MOTACILLA cinereo-capilla, Savi, in Nuov. Giorn. Leit. N. S'], p. 190. Id. Orn.Tosc. l ll.p . 216. Nob.
Suppl. sp. comp. sp. Rom. 264. (100. b.)
Cdtrettola 6 1Alla, o di primavera, St. d. Ucc. IV. p. 5 i. tab. 385. fig. 2. mas adult, (excl. syn.)
strisciajola, Savi, loco citato.
N e l l ’ Ornitologia della Svezia, opera scritta dal Signor Professore Nilsson con
una scrupolosa esattezza e da rinvenirsi la prima traccia della presente specie di Cutti.
Parlando della Motacilla flava l’autore mentovato accenna sotto la lettera A una varietä
che ha ,il capo tutto nero di sopra (e voleva forse dire plumbeo, privo di fasce bianche),
la gola biancastra spruzzata di punti neri, il gozzo giallo macchiato di fosco: ulterior-
mente fa osseryare ehe trovasi nella Lapponia in luoghi ove non abita la comune Motor
cilia flavaj e par ehe esiti se abbia a riguardare quest’ uccelletto come varietä dovuta
al clima piuttosto ehe come specie costantemente diversa. Cio nulla toglie al merit©
dell’ egregio Professore Italiano, ehe e stato il primo a studiare i costumi di siffatto animale,
stabilirne i caratteri, divulgarlo sotto un proprio nome specifico. Le parole di cui
si serve il Signor Roux' nell’ Ornitologia Provenzale per descrivere le mutazioni cui
soggiace la M. flava fanno riconoscere abbastanza ch’egli congiunge in una tanto la
vera flava quanto la cinereo-capillaj. e cio accortamente rileva il nostro Professor Savi,
cui era awenuto di confonder del pari questi due uccelletti nell’Ornitologia Toscana;
la tavola perö dell’ Ornitologia Provenzale sotto il nome di flava rappresenta onnina-
mente la cinereo-capilla.
La forma e le proporzioni di questo Cutti sono le medesime ehe quelle del Cutti
comune. Il pileo, le guance e la parte superiore della cervice hanno un color piom-
bino generalmente piu cupo, talvolta quasi fosco: le penne cigliari sono nerastre:
manca del tutto la fascia bianca sopraoculare, solo talvolta nelTuccello non bene adulto
vedesi una macchietta bianca situata dietro la palpebra superiore. La gola b bianca, e
il restante delle parti inferiori dell’ animale sono del solito color di giunchigT.u ac-
ceso. In tutto il rimanente i colori corrispondono esattamente a quelli della precedente