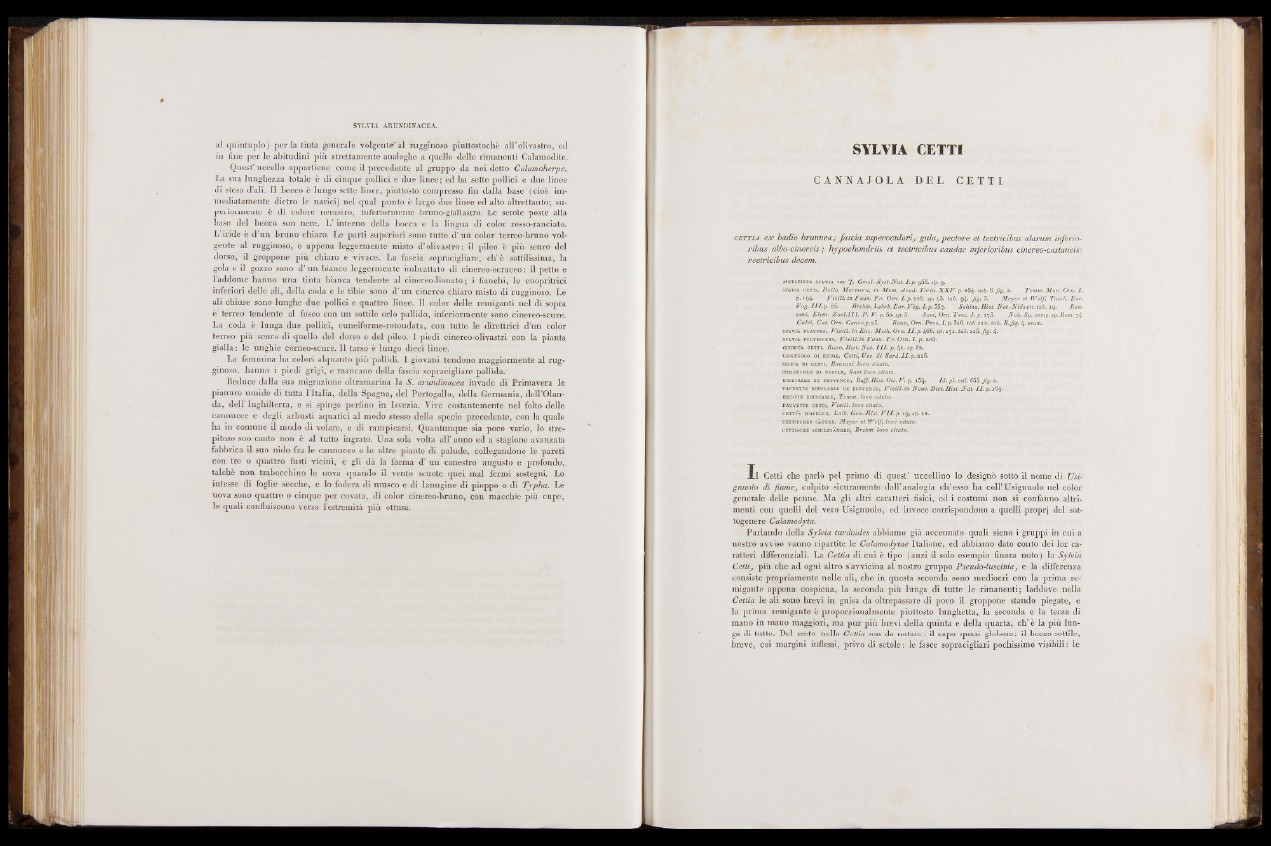
al quintuplo) per la tinta generale volgentcT al rugginoso piultostoche all’ olivastro, ed
in line per le abitudini piu strettamente analoghe a quelle delle rimanenti Calamodite.
Quest’ uccello appartiene come il precedente al gruppo da noi detto Calamoherpe.
La sua lunghezza totale & di cinque pollici e due linee; ed ha sette pollici e due linee
di stesa d’ali. II becco b lungo sette linee, piuttosto compresso fin dalla base‘(cio6 im-
mediatamente dietro le narici) nel qual pun to e largo due linee ed alto altrettanto; su-
periormente e di colore nerastro, inferiormente bruno-giallastro. Le setole poste alia
base del becco son nere. L’ interno della bocca e la lingua di color rosso-ranciato.
L’iri de e d’ un bruno chiaro. Le parti superiori sono tutte d’ un color terreo-bruno vol-
gente al rugginoso, e appena leggermente misto d’olivastro: il pileo b piu scuro del
dorso, il groppone piu chiaro e vivace. La fascia sopracigliare, ch’& sottilissima, la
gola e il gozzo sono d’ un bianco leggermente imbrattato di cinereo-ocraceo: il petto e
l’addome hanno una tinta bianca tendente al cinereo-lionato; i fianchi, le cuopritrici
inferior! delle ali, della coda e le tibie sono d’ un cinereo chiaro misto di rugginoso. Le
ali chiuse sono lunghe due pollici e quattro linee. Il color delle remiganti nel di sopra
b terreo tendente al fosco con un sottile orlo pallido, inferiormente sono cinereo-scure.
La coda e lunga due pollici, cuneiforme-rotondata, con tutte le direttrici d’un color
terreo piu scuro di quello del dorso e del pileo. I piedi cinereo-olivastri con la pianta
gialla: le unghie corneo-scure. Il tarso e lungo dieci linee.
La femmina ha colori alquanto piu pallidi. I giovani tendono maggiormente al rugginoso,
hanno i piedi grigi, e mancano della fascia sopracigliare pallida.
Reduce dalla sua migrazione oltramarina la S. arundinacea invade di Primavera le
pianure umide di tutta l’ltalia, delk Spagna, del Portogallo, della Germania, dell’Olan-
da, dell’lnghilterra, e si spinge perfino in Isvezia. Vive costantemente nel folto delle
cannucce e degli arbusti aquatici al modo stesso della specie precedente, con la quale
ha in comune il modo di volare, e di rampicarsi. Quantunque sia poco vario, lo stre-
pitoso suo canto non e al tutto ingrato. Una sola volta all’ anno ed a stagione avanzata
fabbrica il suo nido fra le cannucce e le altre piante di palude, collegandone le pareti
con tre o quattro fasti vicini, e gli da la forma d’ un canestro angusto e profondo,
talche non trabocchino le uova quando il vento scuote quei mal fermi sostegni. Lo
intesse di foglie secche, e lo fodera di musco e di lanugine di pioppo o di Typha. Le
uova sono quattro o cinque per covata, di color cinereo-bruno,- con macchie piu cupe,
le quali confluiscono verso 1’estremita piu ottusa.
CANNAJOLA DEL CE TT I
CETTI A e x badio brunnea; fascia superocularij gula^ pectore et tectricibus alarum inferio-
ribus albo-cinereis ; hypochondriis et tectricibus caudae inferioribus einereo-castaneis:
rectricibus decem.
motacilea SYLVIA var.fif, Gmel. Syst.Nal. I.p. g56, sp. g.
SYLVIA CETTI, Bella Marmora, in Mem. Acad. Torin. X X V p. a54. tab. 6.fig. 2. Temm. Man. Orn. I.
P-19 4 - Vieill. in Faun. Fr. Ôrn. I. p. 208. sp. i 5. tab. 94* fig. 3. ’ Meyer et Wolf, Tasch. Ear.
Vog.III.p. 85. Brekm, Lehrb.Ear. Vog. I.p. 55-]. Schinz, Hist. Nat. Nids etc.tab. 19'. Ranzani,
Elem. Zool.Ill. P. V- p. 5o. sp. 5. Savi, Orn. Tose. I. p. 275. Nob. Sp. comp. sp. Rom. 74’
Cdlvi, Cat. Orn. Genov.p.oS. Roux, Orn.Prov. I.p .3a6. tat.212. tab. R.fig. 4• ovum.
SYLVIA platora, Vieill. in Enc. Meth. Orn. II. p. 466. sp. 171. tab. n 5. fig. 4*
Sylvia fdlvescens, Vieill. in Faun. Fr. Orn. I. p. 208.
cubroca cetti, Riiso, Hist. Nat. III. p. 41- sp. 82.
usignuolo di FiOME, Cetti, Ucc. di Sard. II. p. 216.
Silvia di cetti, Ranzani loco citato.
RUS1GNUOLO Dl PADDLE, Savi loco citato.
bodscarlb de Provence, Buff. Hist. Ois. V. p. i 34. Id. pi. enl. 655. fig. 2.
fauvette bods carle de provence, Vieill. in Nouv. Diet. Hist. Nat. II. p. 169.
bec-fin bodscarle, Temm. loco citato.
fauvette cetti, Vieill. loco citato.
cetti’s warbler, Latli. Gen. Hist. VII. p. 19. sp. 12.
cettischer Sanger, Meyer et Wolf, loco citato.
cettische schilfsänger, Brehm. loco citato.
I l Cetti che parlo pel primo di quest’ uccellino lo designo sotto il nome di Usi-
gnuolo di fiumej colpito sicuramente dall’analogia ch’esso ha coll’Usignuolo nel color
generale delle penne. Ma gli altri caratteri fisici, ed i costumi non si confanno altri-
menti con quelli del vero Usignuolo, ed invece corrispondono a quelli proprj del sot-
togenere Calamodjta.
Parlando della Sylvia turdoides abbiamo gia accennato quali sieno i gruppi in cui a
nostro avviso vanno ripartite le Calamodytae Italiane, ed abbiamo dato conto dei lor caratteri
differenziali. La Cettia di cui e tipo (anzi il solo esempio finora iloto ) la Sylvia
Cettij piu che ad ogni altro s’avvicina al nostro gruppo Pseudo-lusciniaj e la differenza
consiste propriamente nelle ali, che in questa seconda sono mediocri con la prima re-
migante appena cospicua, la seconda piu lunga di tutte le rimanenti; laddove nella
Cettia le ali sono brevi in guisa da oltrepassare di poco il groppone stando piegate, e
la prima remigante b proporzionalmente piuttosto lunghetta, la seconda e la terza di
mano in mano maggiori, ma pur piu brevi della quinta e della quarta, ch’ e la piu lunga
di tutte. Del resto nella Cettia son da notare: il capo quasi globoso: il becco sottile,
breve, coi margini inflessi, privo di setole: le fasce sopracigliari pochissimo visibili: le