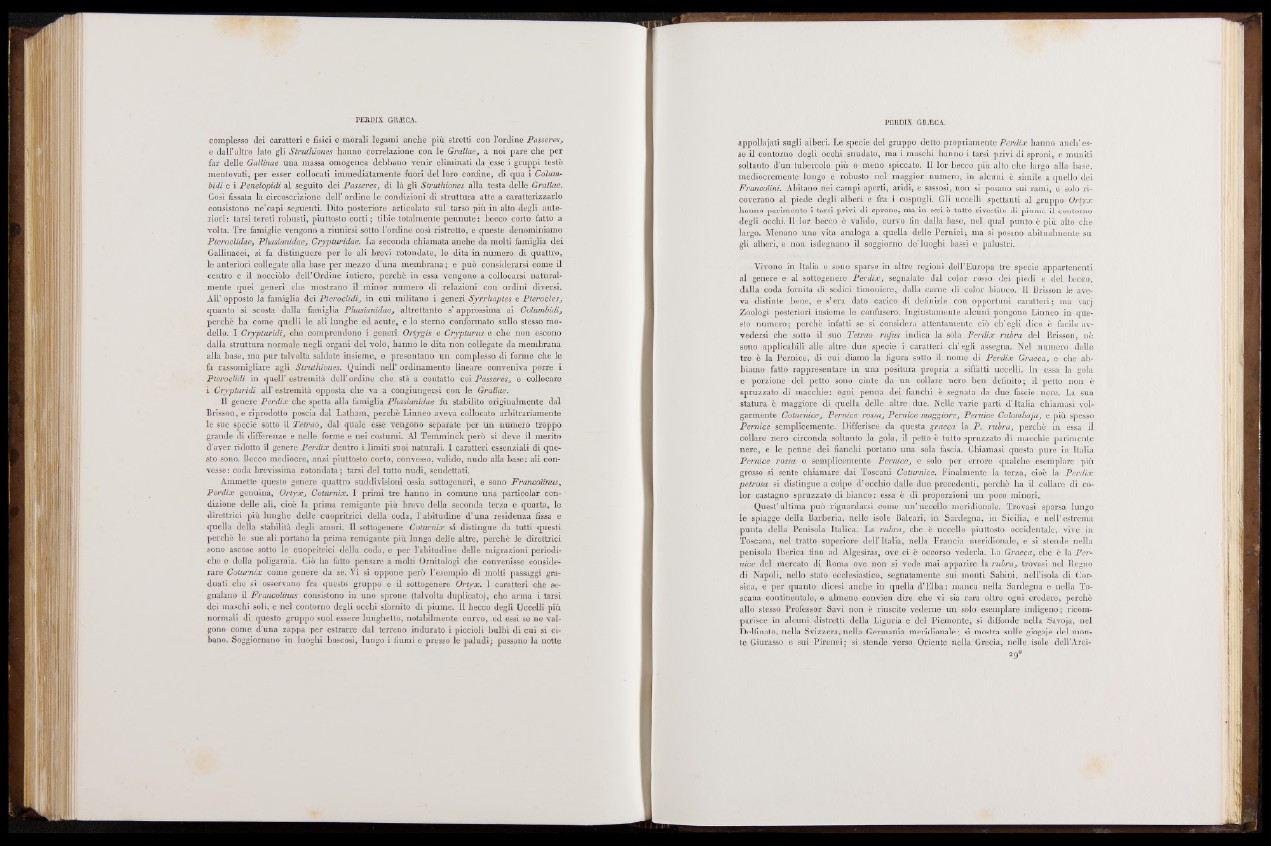
complesso dei caratteri e fisici e morali legami anche più stretti con 1’ordine Passeresj
e dall’altro lato gli Struthiones hanno correlazione con le Grallae, a noi pare che per
far delle Gallinae una massa omogenea dehbano venir eliminati da jesse i gruppi testé
mentovati, per esser collocati immediatamente fuori del loro confine, di qua i Colum-
bidi e i Penelopidi al seguito dei Passer e s di là gli Struthiones alla testa delle Grallae.
Cosi fissata la circoscrizione delT ordine le condizioni di struttura atte a caratterizzarlo
consistono ne’capi seguenti. Dito posteriore articolato sul tarso più in alto degli ante-
riori: tarsi tereti robusti, piuttosto corti ; tibie totalmente pennute : becco corto fatto a
volta. Tre famiglie vengono a riunirsi sotto 1’ordine cosi ristretto, e queste denominiamo
Pteroclidae, PhasianidaeCrypturidae. La seconda chiamata anohe da molti famiglia dei
Gallinacei, si fa distinguere per Ie ali brevi rotondate, Ie dita in numero di quattro,
Ie anteriori collegate alla base per mezzo d’una membrana ; e puö considerarsi corne il
centro e il nocciölo dell’Ordine intiero, perché in essa vengono a collooarsi natural-
mente quei generi ehe mostrano il minor numero di relazioni con ordini diversi.
AIT opposto la famiglia dei Pteroclidij in cui militano i generi Syrrhaptes e PterocleSj
quanto si scosta dalla famiglia Phasianidae, altrettanto s’ approssima ai Columbidi
perché ha come quelli Ie ali lunghe ed acute» e lo sterno conformato sullo stesso mo-
dello. I Crypturidij ehe comprendono i generi Ortygis e Crypturus e ehe non escono
dalla struttura normale negli organi del volo, hanno Ie dita non collegate da membrana
alla base, ma pu r talvolta saldate insieme, e presentano un complesso di forme che le
fa rassomigliare agli Struthiones. Quindi nell’ ordinamento lineare conveniva porre i
Pteroclidi in quell’ estremità dell’ordine che stà a contatto coi Passeres* e collocare
i Crypturidi ail’ estremità opposta ehe va a congiungersi con le Grallae.
Il genere Perdix ehe spetta alla famiglia Phasianidae fu stabilito originalmente dal
Brisson, e riprodotto poscia dal Latham, perché Linneo aveva collocato arbitrariamente
le sue specie sotto il Tetrao_, dal quale esse vengono separate per un numero troppo
grande di differenze e nelle forme e nei costumi. Al Temminck pero si deve il merito
d’aver ridotto il genere Perdix dentro i limiti suoi naturali. I caratteri essenziali di que-
sto sono. Becco mediocre, anzi piuttosto corto, convesso, valido, nudo alla base: ali con-
vesse : coda brevissima rotondata ; tarsi del tutto nudi, scudettati.
Ammette questo genere quattro suddivisioni ossia sottogeneri, e sono Francolinus,
Perdix genuina, Ortyxj Coturnix. I primi tre hanno in comune una particolar con-
dizione delle ali, cioè la prima remigante più breve della seconda terza e quarta, le
direttrici più lunghe delle cuopritrici della coda, l’abitudine d’una residenza fissa e
quell a della stabilità degli amori. Il sottogenere Coturnix si distingue da tutti questi
perché le sue ali portano la prima remigante più lunga delle altre, perché le direttrici
sono ascose sotto le cuopritrici della coda, e per l’abitudine delle migrazioni përiodi-
che e della poligamia. Cio ha fatto pensare a molti Ornitologi ehe convenisse conside-
rare Coturnix corne genere da se. Vi si oppone pero l ’esempio di molti passaggi gra-
duati ehe si osservano fra questo gruppo e il sottogenere Ortyx. I caratteri ehe se-
gnalano il Francolinus consistono in uno sprone (talvolta duplicato), ehe arma i tarsi
dei maschi soli, e nel contorno degli occhi sfornito di piume. Il becco degli Uccelli più
normali di questo gruppo suol esseré lunghetto, notabilmente curvo, ed essi se ne val-
gono corne d’una zappa per estrarre dal terreno indurato i piccioli bulbi di cui si ci-
bano. Soggiomano in luoghi boscosi, lungo i fiurni e presso le paludi; passano la notte
appollajati sugli aîberi. Le specie del gruppo detto propriamente Perdix hanno anch’esse
il contorno degli occhi snudato, ma i maschi hanno i tarsi privi di sproni, e muniti
soltanto d’un tubercolo più o meno spiccato. Il lor becco più alto ehe largo alla base,
mediocremente lungo e robusto nel maggior numero, in alcuni è simile a quello dei
Francolini. Abitano nei campi aperti, aridi, e sassosi, non si posano sui rami, e solo ri-
coverano al piede degli alberi e fra i cespugli. Gli uccelli spettanti al gruppo Ortyx
hanno parimente i tarsi privi di sprone, ma in essi è tutto rivestito di piume il contorno
degli occhi. Il lor becco è valido, curvo fin dalla base, nel quai punto è più alto ehe
largo. Menano una vita analoga a quella delle Perniei; ma si posano abitualmente su
gli alberi, e non isdegnano il soggiorno de’luoghi bassi e palustri.
Vivono in Italia e sono sparse in altre regioni dell’ Europa tre specie appartenenti
al genere e al sottogenere Perdix^ segnalate dal color rosso dei piedi e del becco,
dalla coda fornita di sedici timoniere, dalla carne di color bianco. Il Brisson le aveva
distinte bene, e s’era dato carico di definirle con opportuni caratteri; ma varj
Zoologi posteriori insieme le confusero. Ingiustamente alcuni pongono Linneo in que-
slo numéro; perché infatti se si considéra attentamenle cio ch’egli dice è facile av-
vedersi che sotto il suo Tetrao rufus indica la sola Perdix rubra del Brisson, né
sono applicabili aile altre due specie i caratteri ch’egli assegna. Nel numero delle
tre è la Pernice, di cui diamo la figura sotto il nome di Perdix Graeca_, e ehe ab-
biamo fatto rappresentare in una positura propria a siffatti uccelli. In essa la gola
e porzione del petto sono einte da un collare nero ben definito; il petto non è
spruzzato di macchie: ogni penna dei fianchi è segnata da due fascie nere. La sua
statura è maggiore di quella delle altre due. Nelle varie parti d’Italia chiamasi vol-
garmente CoturnicePernice rossa_, Pernice maggiorej Pernice Colombajaj e più spesso
Pernice semplicemente. Differisce da questa graeca la P. r u b r a perché in essa il
collare nero circonda soltanto la gola, il petto è tutto spruzzato di macchie parimente
nere, e le penne dei fianchi portano una sola fascia. Chiamasi questa pure in Italia
Pernice rossa o semplicemente P e r n i c e e solo per errore qualche esemplare più
grosso si sente chiamare dai Toscani Coturnice. Finalmente la terza, cioé la Perdix
petrosa si distingue a colpo d’occhio dalle due precedenti, perché ha il collare di color
castagno spruzzato di bianco : essa è di proporzioni un poco minori.
Quest’ultima puo riguardarsi corne un’uccello meridionale. Trovasi sparsa lungo
le spiagge della Barberia, nelle isole Baleari, in. Sardegna, in Sicilia, e nell’ estrema
punta della Penisola Italica. La rubraj ehe è uccello piuttosto occidentale, vive in
Toscana, nel tratto superiore dell’ Italia, nella Francia meridionale, e si stende nella
penisola Iberica fino ad Algesiras, ove ci è occorso vederla. La Graeca^ che 'è la Pernice
del nlercato di Roma ove non si vede mai apparire la rubra3 trovasi nel Regno
di Napoli, nello stato ecclesiastico, segnatamente sui monti Sabini, nell’isola di Corsica,
e per quanto dicesi anche in quella d’Elba: manca nella Sardegna e nella Toscana
continentale, o almeno convien dire ehe vi sia rara oltre ogni credere, perché
allo stesso Professor Savi non è riuscito vederne un solo esemplare indigeno; ricom-
parisce in alcuni distretti della Liguria e del Piemonte, si diffonde nella Savoja, nel
Dellinato, nella Svizzera,nella Germania meridionale; si mostra sulle giogaje del monte
Giurasso e sui Pirenei; si stende verso Oriente nella Grecia, nelle isole dell’Arci-
29*