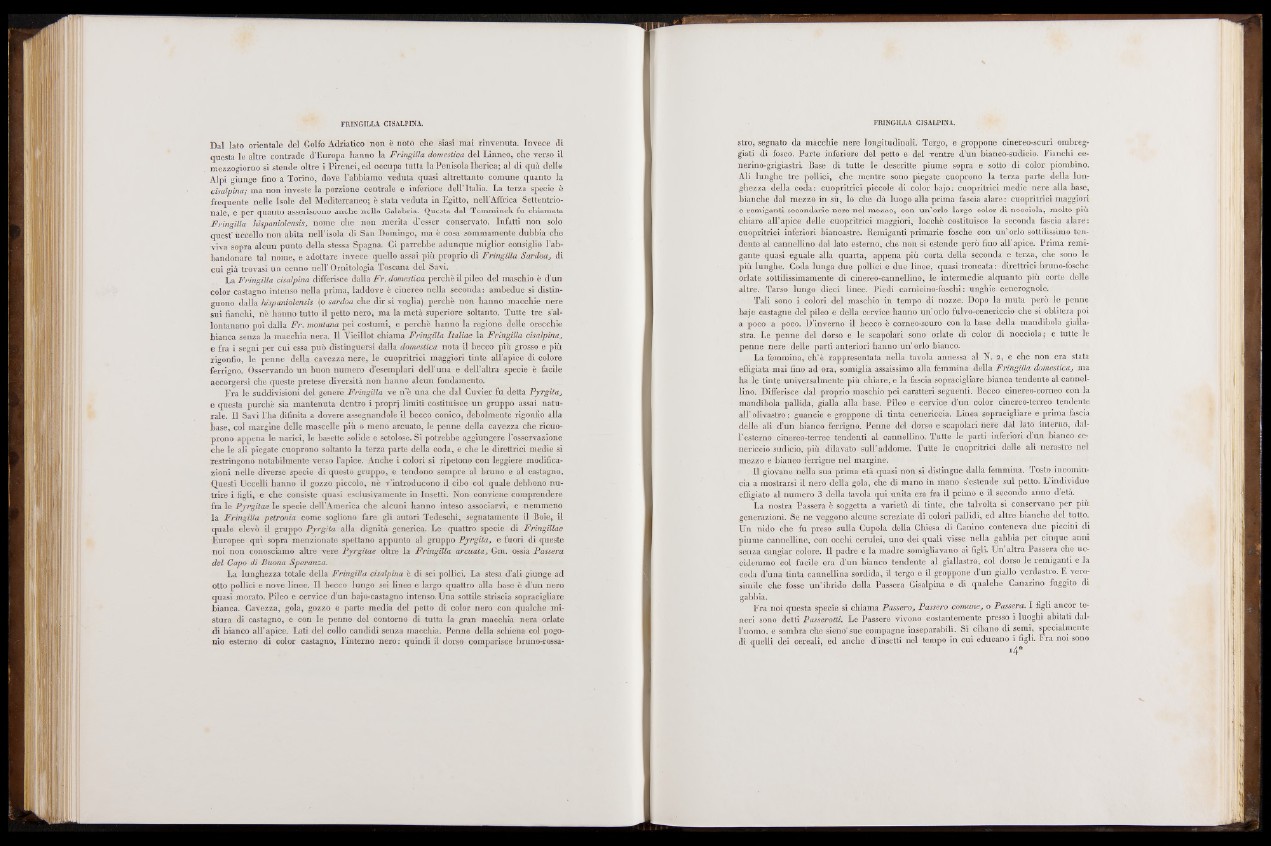
Dal lato orientale del Golfb Àdriatico non è noto ehe siasi mai rinvenuta. Invece di
questa le altre contrade d’Europa hanno la Fringilla domestica del Linneo, ehe verso il
mezzogiorno si stende oltre i Pirenei, ed occupa tutta la Penisola Iberica; al di qua delle
Alpi giunge fino a Torino, doye l’abbiamo yeduta quasi altrettanto comune quanto la
cisalpina; ma non inyeste la porzione centrale e inferiore dell’ Italia. La terza specie è
frequente nelle Isole del Mediterraneo; è stata yeduta in Egitto, nell’Affrica Settentrio-
nale, e per quanto asseriscono anche nella Calabria. Questa dal Temminck fu chiamata
Fringilla hispaniolensisj nome ehe non mérita d’esser conservato. Infatti non solo
quest’ ùccelio non àbita nell’isola di San Domingo, ma è cosa sommamente dubbia ehe
yiya sopra alcun punto della stessa Spagna. Ci parrebbe adunque miglior consiglio l ’ab-
bandonare tal nome, e adottare invece quello assai più proprio di Fringilla Sardoa, di
cui già trovasi un cenno nell Ornitologia Toscana del Sayi.
La Fringilla cisalpina differisce dalla Fr. domestica perché il pileo del maschio è d’un
color castagno intenso nella prima, laddove è cinereo nella seconda: ambedue si distin-
guono dalla hispaniolensis (o sardoa che dir si voglia) perche non hanno macchie nere
sui fianchi, nè hanno tutto il petto nero, ma la metà superiore soltanto. Tutte tre s’al-
lontanano poi dalla Fr. montana pei costumi, e perché hanno la regione delle orecchie
bianca senza la macchia nera. Il Vieillot chiama Fringilla Italiae la Fringilla cisalpina,
e fra i segni per cui essa pué distinguersi dalla domestica nota il becco più grosso e più
rigonfio, le penne della çayezza nere, le cuopritrici maggiori tinte all’apice di colore
ferrigno. Osseryando un buon numéro d’esemplari dell’una e dell’altra specie è facile
accorgersi ehe queste pretese diyersità non hanno alcun fondamento.
Fra le suddivisioni del genere Fringilla ve n’è una che dal Cuvier fu detta Pyrgita,
e questa purchè sia mantenuta dentro i proprj limiti costituisce un gruppo assai naturale.
Il Savi l’ha difinita a dovere assegnandole il becco conico, debolmente rigonfio alla
base, col margine delle mascelle più o meno arcuato, le penne della cavezza ehe ricuo-
prono appena le narici, le basette solide e setolose. Si potrebbe aggiungere l’osservazione
ehe le ali piegate cuoprono soltanto la terza parte della coda, e ehe le direttrici medie si
testringono notabilmente verso l’apice. Anche i colori si ripetono con leggiere modifica-
zioni nelle diverse specie di questo gruppo, e tendono sempre al bruno e al castagno.
Questi Uccelli hanno il gozzo piccolo, nè v’introducono il cibo col quale debbono nu-
trire i figli, e ehe consiste quasi esciusivamente in Insetti. Non conviene comprendere
fra le Pyrgitae le specie dell’America che aleuni hanno inteso associarvi, e nemmeno
la Fringilla petronia come sogliono fare gli autori Tedeschi, segnatamente il Boie, il
quale eleyo il gruppo Pyrgita alla dignité generica. Le quattro specie di Fringillae
Europee qui sopra menzionate spettano appunto al gruppo Pyrgita, e fuori di queste
noi non conosciamo altre vere Pyrgitae oltre la Fringilla arcuata, Gm. ossia Passera
del Capo di Buona Speranza.
La lunghezza totale della Fringilla cisalpina è di sei pollici. La stesa d’ali giunge ad
otto pollici e noyé linee. Il becco lungo sei linee e largo quattro alla base è d’un nero
quasi morato. Pileo e cervice d’un bajo-castagno intenso. Una sottile striscia sopracigliare
bianca. Cavezza, gola, gozzo e parte media del petto di color nero con qualche mi-
stura di castagno, e con le penne del contomo di tutta la gran macchia nera orlate
di bianco all’apice. Lati del collo candidi senza macchia. Penne della schiena col pogo-
nio estemo di color castagno, l’interno nero: quindi il dorso comparisce bruno-rossastro,
segnato da macchie nere longitudinali. Tergo, e groppone cinereo-scuri ombreg-
giati di fosco. Parte inferiore del petto e del ventre d’un bianco-sudicio. Fianchi ce-
nerino-grigiastri. Base di tutte le descritte piume sopra e sotto di color piombino.
Ali lunghe tre pollici, che inentre sono piegate cuoprono la terza parte della lunghezza
della coda: cuopritrici piccole di color bajo; cuopritriei medie nere alia base,
bianche dal mezzo in su, lo che da luogo alia prima fascia alare: cuopritrici maggiori
e remiganti secondarie nere nel mezzo, con un’orlo largo color di nocciola, molto piu
chiaro all’apice delle cuopritrici maggiori, locche costituisce la seconda fascia alare:
cuopritrici inferiori biancastre. Bemiganti primarie fosche con un’ orlo sottilissimo ten-
dente al cannellino dal lato esterno, che non si estende pero fino all’apice. Prima remi-
gante quasi eguale alia quarta, appena piu corta della seconda e terza, che sono le
piu lunghe. Coda lunga due pollici e due linee, quasi troncata: direttrici firuno-fosche
orlate sottilissimamente di cinereo-cannellino, le intermedie alquanto piu corte delle
altre. Tarso lungo dieci linee. Piedi camicino-foschi: unghie cenerognole.
Tali sono i colori del maschio in tempo di nozze. Dopo la muta pero le penne
baje castagne del pileo e della cervice hanno un’orlo fulvo-cenericcio che si oblitera poi
a poco a poco. D’invemo il becco b corneo-scuro con la base della mandibola gialla-
stra. Le penne del dorso e le scapolari sono orlate di color di nocciola; e tutte le
penne nere delle parti anteriori hanno un’ orlo bianco.
La femmina, ch’e rappresentata nella tavola annessa al N. 2, e che non era stata
effigiata mai fino ad ora, somiglia assaissimo alia femmina della Fringilla domestica, ma
ha le tinte universalmente piu chiare, e la fascia sopracigliare bianca tendente al cannellino.
Differisce dal proprio maschio pei caratteri seguenti. Becco cinereo-comeo con la
mandibola pallida, gialla alia base. Pileo e cervice d’un color cinereo-terreo tendente
all’olivastro: guancie e groppone di tinta cenericcia. Linea sopracigliare e prima fascia
delle ali d’un bianco ferrigno. Penne del dorso e scapolari nere dal lato interim, dal-
1’esterno cinereo-terree tendenti al cannellino. Tutte le parti inferiori d’un bianco ce-
nericcio sudicio, piu dilavato sull’addome. Tutte le cuopritrici delle ali nerastre nel
mezzo e bianco ferrigne nel margine.
II giovane nella sua prima eta quasi non si distingue dalla femmina. Tosto incomin-
cia a mostrarsi il nero della gola, che di mano in mano s’estende sul petto. Lindiyiduo
effigiato al numero 3 della tavola qui unita era fra il primo e il secondo anno d eta.
La nostra Passera b soggetta a varieta di tinte, che talvolta si conservano per piu
generazioni. Se ne veggono alcune screziate di colori pallidi, ed altre bianche del tutto.
Un nido che fu preso sulla Cupola della Chiesa di Canino conteneva due piccini di
piume cannelline, con occhi cerulei, uno dei quali visse nella gabbia per cinque anni
senza cangiar colore. Il padre e la madre somigliavano ai figli* Un altra Passera che uc-
cidemmo col fucile era d’un bianco tendente al giallastro, col dorso le remiganti e la
coda d’una tinta cannellina sordida, il tergo e il groppone d’un giallo verdastro. E vero-
simile che fosse un’ibrido della Passera Cisalpina e di qualche Canarino fuggito di
gabbia.
Fra noi questa specie si chiama Passero, Passero comune, o Passera. I figli ancor te-
neri sono detti Passerotti. Le Passere vivono costantemente presso i luoghi abitati dal-
l’uomo, e sembra che sieno'sue compagne inseparabili. Si cibano di semi, specialmente
di cruelli dei cereali, ed anche d’insetti nel tempo in cui educano i figli* Fra noi sono
14*