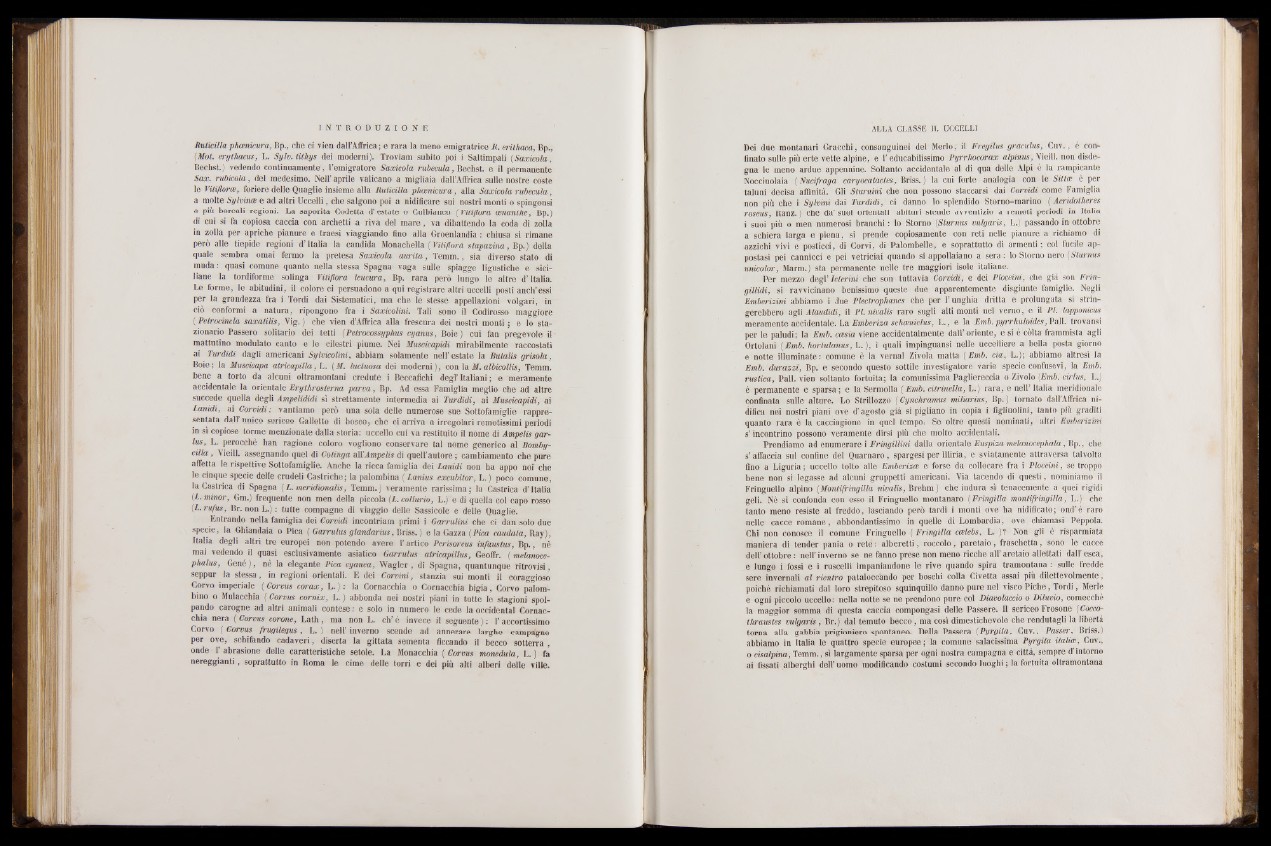
Ruticilla phoenicura. Bp., che ci vieil dall’Affirica ; e rara la meno emigratrice R. erithaca, Bp.,
(Mot. erythacus, L. Sylv. tithys dei modérai). Troviam subito poi i Saltimpali (Saxicola,
Bechst.) vedendo continuamente , l’emigratore Saxicola rubeeula, Bechst. e il permanente
Sax. rubicola, del medesimo. Nell’ aprile valicano a migliaia dall’Affrica sulle nostre coste
le Vitifloroe, foriere delle Quaglie insieme alla Rutidlla phoenicura, alla Saxicola rubeeula,
a moite Sylvinoe e ad altri Uccelli, che salgono poi a nidificare sui nostri monti o spingonsi
a più boreali regioni. La saporita Codetta d’estate o Culbianco ( Vitiflora oenanthe, Bp.)
di cni si fa copiosa caccia con archetti a riva del ma re, va dibattendo la coda di zolla
in zolla per apriche pianure e traesi viaggiando fino alla Groenlandia : chiusa si rimane
Per6 aile tiepide regioni d’ltalia la Candida Monachella (Vitiflora slapazina, Bp.) délia
quale sembra ornai fermo la pretesa Saxicola aurita, Temm., sia diverso state di
muda : quasi comune quanto nella stessa Spagna vaga sulle spiagge ligustiche e sici-
liane la tordiforme solinga Vitiflora leucura, Bp. rara perù lungo le altre d’ ltalia.
Le forme, le abitudini, il colore ci persuadono a qui registrare altri uccelli posti anch’essi
per la grandezza fra i Tordi dai Sistematici, ma che le stesse appellazioni volgari, in
cio conformi a natura, ripongono fra i Saxicolini. Tali sono il Codirosso maggiore
( Petrocincla saxatilis, Vig. ) che vien d’ABrica alla frescura dei nostri monti ; e lo sta-
zionario Passera solitario dei tetti (Petrocossyphus cyanus, Boie) cui fan pregevole il
mattutino modulato canto e le cilestri piume. Nei Musdcapidi mirabilmente raccostati
ai Turdidi dagli americani Sylvicolini, abbiam solamente nelT estate la Butalis grisola,
Boie; la Musdcapa alricapilla, L. ( il. lucluosa dei modérai), con la M.albicollis, Temm.
bene a torto da alcuni oltramontani credute i Beceafichi degT Italiani ; e meramente
accidental la oriental e Erythrostema jiarva. Bp. Ad essa Famiglia meglio che ad altre
succédé quella degli Ampelididi si strettamente intermedia ai Turdidi, ai Musdcapidi, ai
Lanidi, ai Conndi : vantiamo perù una sola delle numerose sue Sottofamiglie rappre-
sentata dall unico sericeo Galletto di bosco, che ci arriva a irregoïari remotissimi periodi
in si copiose torme menzionate dalla storia: uccello cui va restituito il nome di Ampelis parlas,
L. perocchè han ragione colora vogliono conservare tal nome generico al Bomby-
cilla, Vieill. assegnando quel di Cotinga all’Ampelis di quell’autore ; cambiamento che pure
affetta le rispettive Sottofamiglie. Ancbe la ricca famiglia dei Lanidi non ha appo noi che
le cinque specie delle crudeli Castriche: la palombina ( Lanius excubitor, L. ) poco comune,
laCastrica di Spagna ( L. meridimalis, Temm.) veramente rarissima; la Castrica d’ltalia
(L. minor, Gm.) frequente non men della piccola (L. collurio, L.) e di quella col capo rosso
(L.rufus, Br.non L.); tutte compagne di viaggio delle Sassicole e delle Quaglie.
Entrando nella famiglia dei Corvidi incontriam primi i Garrulini che ci dan solo due
specie, la Ghiandaia o Pica ( Garrulus glandarius, Briss. ) e la Gazza (Pica caudala, Ray),
ltalia degli altri tre europei non potendo avéré T artico Perisoreus infaustus, Bp., nè
mai vedendo il quasi esclusivamente asiatico Garrulus alrwapillus, Geoffr. ( melanoce-
phalus, Gêné), nè ia elegante Pica cyanea, Wagler, di Spagna, quantunque ritrovisi,
seppur la stessa, in regioni orientali. E dei Corvini, stanzia sui monti il coraggioso
Corvo impériale ( Corvus corax, L. ) : la Cornacchia o Cornacchia bigia, Corvo palom-
bino o Mulacchia ( Corvus cornix, L. ) abbonda nei nostri piani in tutte le stagioni spol-
pando carogne ad altri animali contese : e solo in numéro le cede la occidental Cornac-
chia nera ( Corvus corom, La th, ma non L. ch’ è invece il seguente ) : T accortissimo
Corvo ( Corvus frugilegus, L. ) nell’ inverno scende ad annerare larghe campdgne
per ove, schifando cadaveri, diserta la gittata sementa ficcando il becco sotterra ,
onde T abrasione delle caratteristiche setole. La Monacchia ( Corvus monedula, L. ) fa
nereggianti, soprattutto in Borna le cime delle torri e dei più alti alberi delle ville.
Dei due montanari Gracchi, consanguinei del Merlo, il Fregilus graculus, Cuv., è con-
finato sulle più erte vette alpine, e T educabilissimo Pyrrhocorax alpinus, Vieill. non disde-
gna le meno ardue appennine. Soltanto accidentale al di qua delle AIpi è la rampicante
Nocciuolaia ( Nudfraga caryocatactes, Briss. ) la cui forte analogia con le Sittoe è per
taluni decisa affinité. Gli Sturnini che non possono staccarsi dai Corvidi corne Famiglia
non più che i Sylvini dai Turdidi, ei danno lo splendido Storno-marino ( Acridotheres
roseus, Ranz. ) ehe da’ suoi orientali abituri stende avventizio a rernoti periodi in ltalia
i suoi più o men numerosi branchi : lo Storno (Sturms vulgaris, L.) passando in ottobre
a schiera larga e piena, si prende copiosamente con reti nelle pianure a richiamo di
azzichi vivi e posticci, di Corvi, di Palombelle, e soprattutto di armenti ; col fucile ap-
postasi pei cannicci e pei vetriciai quando si appollaiano a sera : lo Storno nero (Slurnus
umcolor, Marm.) sta permanente nelle tre maggiori isole italiane.
Per mezzo degl’ Iclerini che son tuttavia Corvidi, e dei Ploceini, che già'son Frin-
gillidi, si ravvicinano benissimo queste due apparentemente disgiunte famiglie. Negli
Emberizini abbiamo i due Plectrophanes ehe per l’unghia dritta e prolungata si strin-
gerebbero agli Alaudidi, il PI. nivalis raro sugli alti monti nei verno, e il PI. lapponkus
meramente accidentale. La Emberiza schoeniclus, L., e la Emb. pyrrhuloides, Pu\\. trovansi
per le paludi ; la Emb. cæsia viene accidentalmente dall’ oriente, e si è cùlta frammista agli
Ortolani (Emb. hortulanus, L. ), i quali impinguansi nelle ucceiliere a bella posta giorno
e notte illuminate: comune è la vernal Zivola matta (Emb. cia, L.); abbiamo altresi la
Emb. durazzi, Bp. e secondo questo sottile investigatore varie specie confusevi, la Emb.
ruslica, Pali, vien soltanto fortuita; la comunissima Pagliereccia o Zivolo (Emb. cirlus, L.)
è permanente e sparsa; e la Sermolla (Emb. dtrinella, L.) rara, e nell’ ltalia méridionale
confinata sulle alture. Lo Strillozzo ( Cymhramus miliarius, Bp. ) tornato dalTAffrica nidifies
nei nostri piani ove d’agosto già si pigliano in copia i figliuolini, tanto piu graditi
quanto rara è la caceiagione in quel tempo. Se oltre questi nominati, altri Emberizini
s’ incontrino possono veramente dirsi più ehe molto accidental!'.
Prendiamo ad enumerare i Fringillini dalla orientale Euspiza melanocephala, Bp., che
s’ affaccia sui confine del Quarnaro, spargesi per llliria, e sviatamente attraversa talvolta
lino a Liguria ; uccello tolto aile Emberizoe e forse da collocare fra i Ploceini, se troppo
bene non si legasse ad alcuni gruppetti americani. Via tacendo di questi, nominiamo il
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis, Brehm ) che indura si tenacemente a quei rigidi
geli. Nè si confonds con esso il Fringuello montanaro (Fringilla montifringilla, L.)- che
tanto meno résisté al freddo, lasciando perù tardi i monti ove ha nidificato; ond’è raro
nelle cacce romane, abbondantissimo in quelle di Lombardia, ove chiamasi Peppola.
Chi non conosce il comune Fringuello (Fringilla coelebs, L. )? Non gli è' risparmiata
maniera di tender pania o rete : alberetti, roccolo, paretaio, fraschetta, sono le cacce
dell’ ottobre : nelT inverno se ne fanno prese non meno rieche all’ aretaio allettati dall’ esca,
e lungo i fossi e i ruscelli impaniandone le rive quando spira tramontana : sulle fredde
sere invernali al rientro pataloccândo per boschi colla Civetta assai più dilettevolmente,
poichè richiamati dal loro strepitoso squinquillo danno pure nei visco Piche, Tordi, Merle
e ogni piccolo uccello: nella notte se ne prendono pure col Diavolacdo o Diluvio, comecchè
la maggior somma di questa caccia compongasi delle Passere. Il sericeo Frosone ( Cocco-
thraustes vulgaris, Br.) dai temuto becco, ma cosl dimestichevole che rendutagli la liberté
torna alla gabbia prigioniero spontaneo. Della Passera (Pyrgita, Cuv., Passer, Briss.)
abbiamo in ltalia le quattro specie europee; la comune salacissima Pyrgita italien, Cuv.,
o dsalpina, Temm., si largamente sparsa per ogni nostra campagna e citté, sempre d’intorno
ai fissati alberghi dell’ uorao modificando costumi secondo luoghi ; la fortuita oltramontana