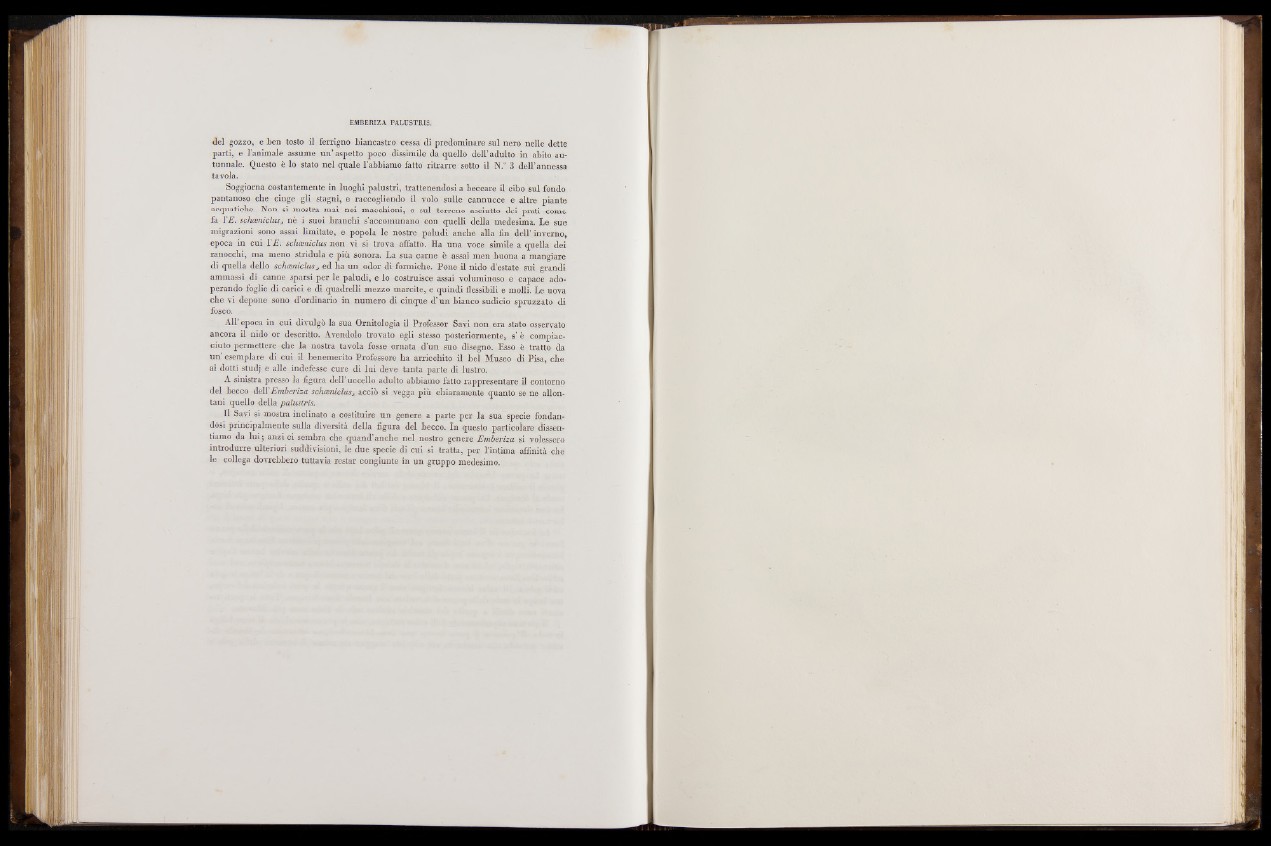
del gozzo, e ben tosto il ferrigno biancastro cessa di predominare sul nero nelle dette
parti, e l ’animale assume un’ aspetto poco dissimile da quello dell’ adulto in abito au-
tunnale. Questo è lo stato nel quale l’abbiamo fatto ritrarre sotto il N.° 3 dell’annessa
tavola.
Soggiorna costantemente in luoghi palustri, trattenendosi a beccare il cibo sul fondo
pantanoso che cinge gli stagni, e raccogliendo il volo sulle cannucce e altre piante
acquaticbe. Non si mostra mai nei macchioni, o sul terreno asciutto dei prati come
fa YE. schoeniclusj nè i suoi branchi s’accomunano con quelli della medesima. Le sue
migrazioni sono assai limitate, e popola le nostre paludi anche alla fin dell’ inverno,
epoca in cui YE. schceniclus non vi si trova affatto. Ha una voce simile a quell a dei
ranocchi, ma meno stridula e più sonora. La sua carne è assai men buona a mangiare
di quella dello schoeniclus ed ha un odor di formiche. Pone il nido d’estate sui grandi
ammassi di canne sparsi per le paludi, e lo costruisce assai voluminoso e capace ado-
perando foglie di carici e di quadrelli mezzo marcite, e quindi flessibili e molli. Le uova
che vi depone sono d’ordinario in numéro di cinque d’un bianco sudicio spruzzato di
fosco.
All’ epoca in cui divulgo la sua Ornitologia il Professor Savi non era stato osservato
ancora il nido or descritto. Avendolo trovato egli stesso posteriormente, s’ è compiac-
ciuto permettere che la nostra tavola fosse ornata d’un suo disegno. Esso è tratto da
un ’ esemplare di cui il benemerito Professore ha arricchito il bel Museo di Pisa, che
ai dotti studj e allé indefesse cure di lui deve tanta parte di lustro.
A sinistra presso la figura dell’uccello adulto abbiamo fatto rappresentare il contorno
del becco delY Emberiza schamichcsj acciô si vegga più chiaramente quanto se ne allon-
tani quello della paluslris.
II Savi si mostra inclinato a costituire u n genere a parte per la sua specie fondan-
dosi principalmente sulla diversité della figura del becco. In questo particolare dissen-
tiamo da lui ; anzi ci sembra che quand’ anche nel nostro genere Emberiza si volessero
introduire ulteriori suddivisioni, le due specie di cui si tratta, per l’intima affinité che
le collega doyrebbero tuttavia restar congiunte in un gruppo medesimo.