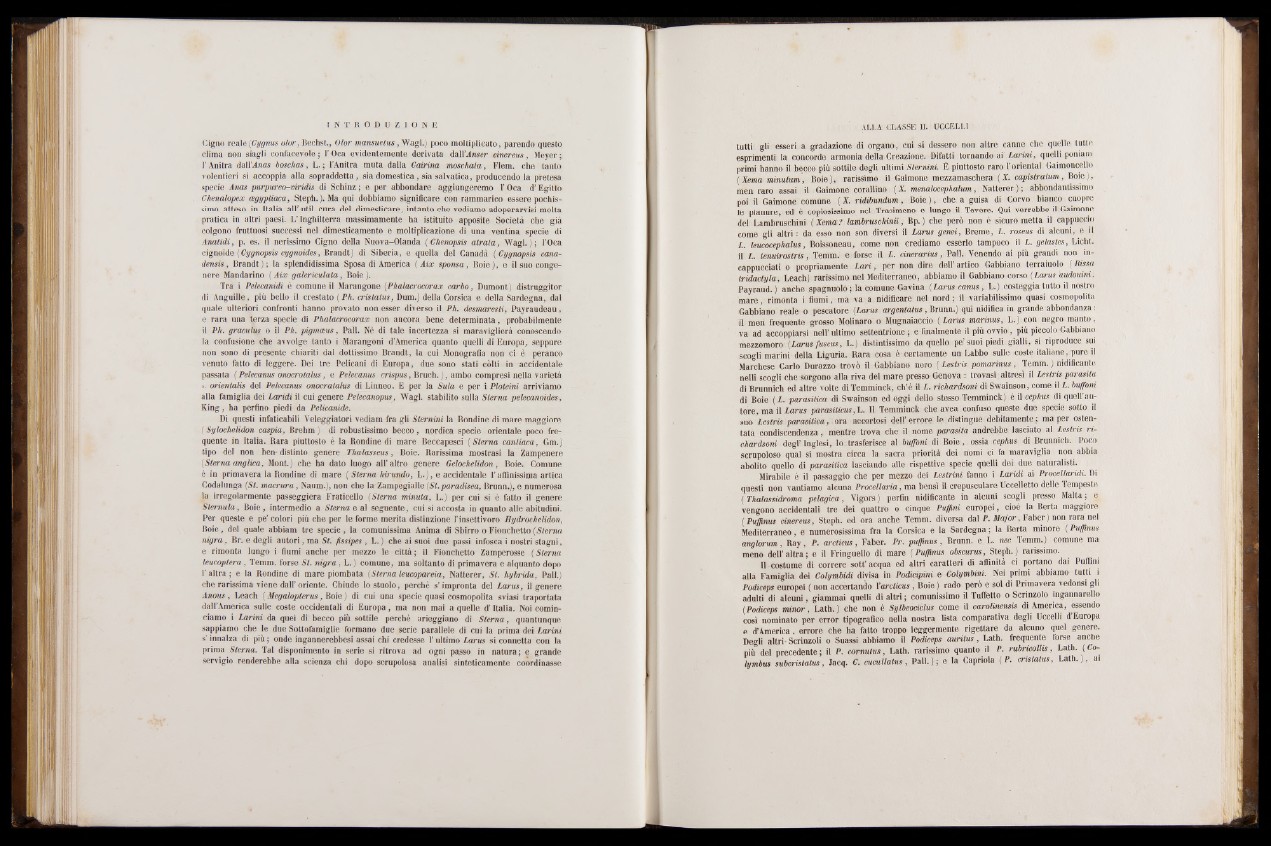
Cigno reale (Cygnus olor, Bechst., Olor mansuelus, Wagl.) poco moltiplicato, parendo questo
clima non siagli confacevole ; Y Oca evidentemente derivata dall’Anser cinereus, Meyer;
l’Anitra daH’Awas boschas, L. ; l’Anitra muta dalla Cairina moschata, Flem. che tanto
volentieri si accoppia alia sopraddetta, sia domestica, sia salvatica, producendo la pretesa
specie Anas purpureo-viridis di Schinz ; e per abbondâre aggiungeremo 1’ Oca d’ Egitto
Chenalopex oegypliaca, Steph. ). Ma qui dobbiamo significare con rammarico essere pochis-
simo atteso in Italia all’ util cura del dimesticare, intanto che vediamo adoperarvisi molta
pratica in altri paesi. L’ Inghilterra massimamente ha istituito apposite Società che già
colgono fruttuosi successi nel dimesticamento e moltiplicazione di una ventina specie di
Anatidi, p. es. il nerissimo Cigno della Nuova-Olanda ( Chenopsis atrata, Wagl.); l’Oca
cignoide (Cygnopsis cygnoides, Brandt) di Siberia, e quella del Canada ( Cygnopsis canadensis
, Brandt ) ; la splendidissima Sposa di America ( Aix sponsa, Boie ), e il suo conge-
nere Manda rino ( Aix galericulata, Boie ).
Tra i Pelecanidi è comune il Marangone (Phalacrocorax carbo, Dumont) distruggitor
di Anguille, più belio il crestato ( Ph. cristatus, Dum.) della Corsica e della Sardegna, dal
quale ulteriori confronti hanno provato non esser diverso il Ph. desmaresti, Payraudeau,
e rara una terza specie di Phalacrocorax non ancora bene determinata, probabilmente
il Ph. graculus o il Ph. pigmoeus, Pall. Nè di tale incertezza si maraviglierà conoscendo
la confusione che avvolge tanto i Marangoni d’America quanto quelli di Europa, seppure
non sono di presente chiariti dal dottissimo Brandt, la cui MonograGa non ci è peranco
venuto fatto di leggere. Dei tre Pelicani di Europa, due sono stati côlti in accidentale
passata ( Pelecanus onocrotalus, e Pelecanus crispus, Bruch.), ambo compresi nella varietà
». orientalis del Pelecanus onocratalus di Linneo. E per la Sula e per i Ploteini arriviamo
alla famiglia dei Laridi il cui genere Pelecanopus, Wagl. stabilité sulla Sterna pelecanoides,
King, ha perGno piedi da Pelicanide.
Di questi infaticabili Veleggiatori vediam fra gli Sternini la Rondine di mare maggiore
( Sylochelidon caspia, Brehm ) di robustissimo becco, nordica specie orientale poco frequente
in Italia. Rara piuttosto è la Rondine di mare Beccapesci ( Sterna cantiaca, Gm.)
tipo del non bem distinto genere Thalasseus, Boie. Rarissima mostrasi la Zampenere
[Sterna anglica, Mont.) che ha dato luogo all’ altro genere Gelochelidon, Boie. Comune
è in primavera la Rondine di mare ( Sterna hirundo, L.), e accidentale l’affinissima artica
Codalunga (St. macrura, Naum.), non che la Zampegialle (St.paradisea, Brunn.), e numerosa
la irregolarmente passeggiera Fraticello (Sterna minuta, L.) per cui si è fatto il genere
Sternula, Boie, intermedio a Sterna e al seguente, cui si accosta in quanto allé abitudini.
Per queste e pe’ colori più che per le forme mérita distinzione 1’insettivoro Hydrochelidon,
Boie, del quale abbiam tre specie, la comunissima Anima di Sbirro oFionchetto(Sterna
nigra, Br. e degli autori, ma St. fissipes, L. ) che ai suoi due passi infosca i nostri stagni,
e rimonta lungo i ûumi anche per mezzo le città; il Fionchetto Zamperosse (Sterna
leucoptera, Temm. forse St. nigra, L. ) comune, ma soltanto di primavera e alquanto dopo
1’ altra ; e la Rondine di mare piombata (Sterna leucopareia, Natterer, St. hybrida, Pall.)
che rarissima viene dal!’oriente. Chiude lostuolo, perché s’ impronta del Larus, il genere
Anous, Leach ( Megalopterus, Boie ) di cui una specie quasi cosmopolita sviasi traportata
dall’America sulle coste occidentali di Europa, ma non mai a quelle d’ Italia. Noi comin-
ciamo i Larini da quei di becco più sottile perché arieggiano di Sterna, quantunque
sappiamo che le due Sottofamiglie formano due sérié parallèle di cui la prima dei Larini
s’ innalza di più ; onde ingannerebbesi assai chi credesse 1’ ultimo Larus si connetta con la
prima Sterna. Tal disponimento in serie si ritrova ad ogni passo in natura ; e grande
servigio renderebbe alia scienza chi dopo scrupolosa analisi sinteticamente coordinasse
tutti gli esseri a gradazione di organo, cui si dessero non altre canne che quelle tutle
esprimenti la concorde armonia della Greazione. Difatti tornando ai Larini, quelli poniam
primi hanno il becco più sottile degli ultimi Sternini. È piuttosto raro l’oriental Gaimoncello
( Xema minutum, Boie), rarissimo il Gaimone mezzamaschera (X capistralum, Boie),
men raro assai il Gaimone corallino; ( X menalocephalum, Natterer); abbondantissimo
poi il Gaimone comune ( X ridibundum, Boie ). ,; che a guisa di Corvo bianco cuopre
le pianure, ed è copiosissimo nel Trasimeno e lungo il Tevere. Qui verrebbe il Gaimone
del Lambruschini (Xema'? lambruschinii, Bp.) che perô non è sicuro metta il cappuccio
come gli altri : da esso non son diversi il Larus genei, Breme, L. roseus di alcuni, e il
L. leucocephalus, Boissoneau, come non crediamo esserlo tampoco il L. gelastes, Licht.
il L. tenuirostris, Temm. e forse il L. cinerarius, Pall. Venendo ai più grandi non in-
cappucciati o propriamente L a ri, per non dire dell’ artico Gabbiano terraiuolo ( Rissa
tridactyla, Leach) rarissimo nel Mediterraneo, abbiamo il Gabbiano corso (Larus audouini,
Payraud. ) anche spagnuolo ; la comune Gavina (Larus cam s, L.) .costeggia tutto il nostro
mare, rimonta i Gumi, ma va a nidiûcare nel nord ; il variabilissimo quasi cosmopolita
Gabbiano reale o pescatore (Larus argentatus , Brunn.) qui nidiûca in grande abbondanza :
il men frequente grosso Molinaro o Mugnaiaccio (Larus marinus, L.) con negro manto,
va ad accoppiarsi nell’ ultimo settentrione ; e finalmente il più ovvio, più piccolo Gabbiano
mezzomoro (Larus fuscus, L.) distintissimo da quello pe’ suoi piedi gialli, si riproduce sui
scogli marini della Liguria. Rara cosa è certamente un Labbo sulle coste italiane, pure il
Marchese Carlo Durazzo trovo il Gabbiano nero ( Les tris pomarinus , Temm. ) nidiûcante
nelli scogli che sorgono alla riva del mare presso Genova : trovasi altresl il Leslris parasita
di Brunnich ed altre volte di Temminck, ch’è il L. richardsoni di Swainson, come il L. buffoni
di Boie ( L. parasitica di Swainson ed oggi dello stesso Temminck) è il cephus di quell’au-
tore, ma il Larus parasiticus, L. II Temminck che avea confuso queste due specie sotto il
suo Lestris parasitica, ora accortosi dell’ errore le distingue debitamente; ma per osten-
tata condiscendenza, mentre trova che il nome parasita andrebbe lasciato al Lestris richardsoni
degl’ Inglesi, lo trasferisce al buffoni di Boie, ossia cephus di Brunnich. Poco
scrupoloso qual si mostra circa la sacra priorité dei nomi ci fa maraviglia non abbia
abolito quello di parasitica iasciando allé rispettive specie quelli dei due naturalisti.
Mirabile è il passaggio che per mezzo dei Lestrini fanno i Laridi ai Procellaridi. Di
questi non vantiamo alcuna Procellaria, ma bensi il crepusculare Uccelletto delle Tempeste
( Thalassidroma pelagica, Vigors) perGn nidiûcante in alcuni scogli presso Malta; e
vengono accidentali tre dei quattro o cinque Puffini europei, cioè la Berta maggiore
( Puflnus cinereus, Steph. ed ora anche Temm. di versa dal P. Major, Faber) non rara nel
Mediterraneo, e numerosissima fra la Corsica e la Sardegna ; la Berta minore ( Puffinus
anglorum, Ray, P. arcticus, Faber. Pr. puffinus, Brunn. e L. nec Temm.) comune ma
meno dell’ altra; e il Fringuello di mare (Puffinus obscurus, Steph.) rarissimo.
II costume di correre sott’acqua ed altri caratteri di affinité ci portano dai Puffini
alia Famiglia dei Colymbidi divisa in Podicipini e Colymbini. Nei primi abbiamo tutti i
Podiceps europei ( non accertando Xarcticus, Boie ) rado per6 e sol di Primavera vedonsi gli
adulti di alcuni, giammai quelli di altri ; comunissimo il Tuffetto o Scrinzolo ingannarello
(Podiceps minor, Lath.) che non è SylbeociClus come il carolinensis di America, essendo
cosl nominato per error tipograûco nella nostra lista comparativa degli Uccelli d Europa
e d’America, errore che ha fatto troppo leggermente rigettare da alcuno quel genere.
Degli altri- Scrinzoli o Suassi abbiamo il Podiceps auritus, Lath, frequente forse anche
più del precedente; il P. cornutus, Lath, rarissimo quanto il P. rubricollis, Lath. (Co-
lytnbus subcri s tatus, Jacq. C. cucullatus, Pali.); e la Capriola (P. cristatus, Lath.), ai