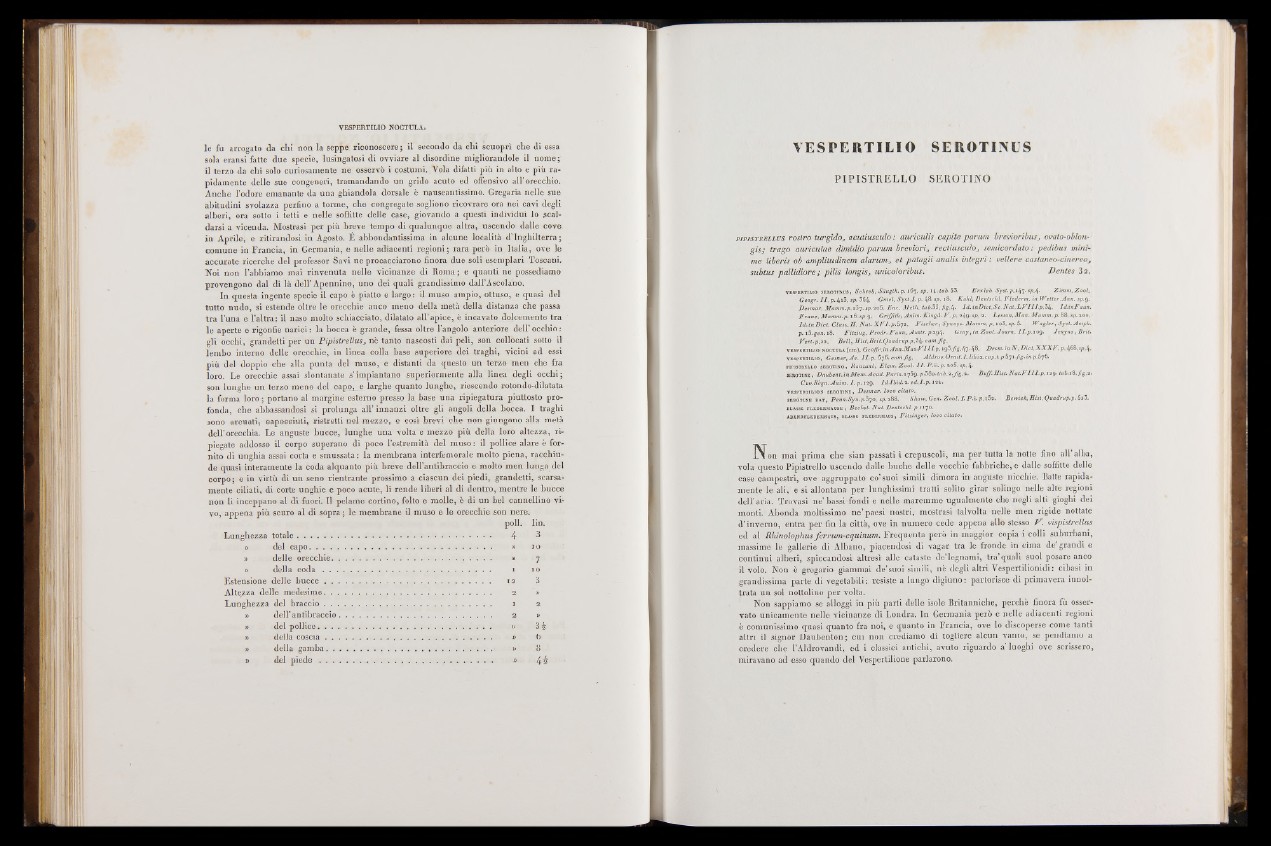
le fu arrogato da chi non la sepjpe riconoscere ; il secondo da chi scuopri che di essa
sola eransi fatte due specie, lusingatosi di oyyiare al disordine migliorandole il nome;
il terzo da chi solo curiosamente ne osservo i costumi. Vola difatti più in alto e più ra-
pidamente delle sue congeneri, tramandando un grido acuto ed offensivo all’orecchio.
Anche l’odore émanante da una ghiandola dorsale è nauseantissimo. Gregaria nelle sue
abitudini svolazza perfino a torme, che congregate sogliono ricovrare ora nei cayi degli
alberi, ora sotto i tetti e nelle soffitte delle case, giovando a questi individui lo scal-
darsi a vicenda. Mostrasi per più breve tempo di qualunque altra, uscendo dalle cove
in Aprilej e ritirandosi in Agosto. È abbondantissima in alcune località d’Inghilterra ;
comune in Francia, in Germania, e nelle adiacenti regioni; rara pero in Italia, ove le
accurate ricerche del professor Savi ne procacciarono finora due soli esemplari Toscani.
Noi non l ’abbiamo mai rinvenuta nelle vicinanze di Roma ; e quanti ne possediamo
provengono dal di là dellWpennino, uno dei quali grandissimo dall’Ascolano.
In questa ingente specie il capo è piatto e largo: il muso ampio, ottu.so, e quasi del
tutto nudo, si estende oltre le orecchie anco meno della metà della distanza che passa
tra l'una e l’altra: il naso molto schiacciato, dilatato all’apice, è incavato dolcemente tra
le aperte e rigonfie narici : la bocca è grande, fessa oltre l’angolo anteriore dell’ occhio :
gli occhi, grandetti per un Pipistrellusj nè tanto nascosti dai peli, son collocati sotto il
lenibo interno delle orecchie, in linea colla base superiore dei traghi, vicini ad essi
più del doppio che alia punta del muso, e distanti da questo un terzo men che fra
loro. Le orecchie assai slontanale s’impiantano superiormente alia linea degli occhi;
son lunghe un terzo meno del capo, e larghe quanto lunghe, riescendo rotondo-dilatata
la forma loro; portano al margine esterno presso la base una ripiegatura piuttosto pro-
fonda, che abbassandosi si prolunga all’ innanzi oltre gli angoli della bocca. I traghi
sono arcuati, capocciuli, ristretti nel mezzo, e cosi brevi che non giungono alla metà
dell’orecchia. Le anguste bucce, lunghe una volta e mezzo più della loro altezza, ri-
piegate addosso il corpo superano di poco l’estremità del muso : il pollice alare è for-
nito di unghia assai corta e smussata: la membrana interfemorale molto piena, racchiu-
de quasi interamente la coda alquanto più breve dell’antibraccio e molto men lunga del
corpo; e in virtù di un seno rientrante prossimo a ciascun dei piedi, grandetti, scarsa-
mente ciliati, di corte unghie e poco acute, li rende liberi al di dentxo, mentre le bucce
non li inceppano al di fuori. Il pelame cprtino, folto e molle, è di un bel cannellino vivo,
appena più scuro al di sopra ; le membrane il muso e le orecchie son nere:
poll. lin.
Lunghezza totale....................................................... 3
» delle orecchie........................................ 7
» della c o d a ........................................... ........................................ I 10
Estensione delle bucce . ........................................ 3
Altezza delle medesime........................................ ..
» del pollice. .................................. . . . 3 2
6
» della gamba........................................
» del p i e d e .................... .
Ö
PIPISTRELLO SEROTINO
p ip is t r e l l u s rostro turgidOj acutiusculo: auriculis capite parum brevioribuSj ovato-oblon-
sis; trago auriculae dimidio parum breviorirectiusculOj semicordato: pedibus mini-
me liberis ob amplitudinem alarumj et patagii analis integri ,* vellere castaneo-cinereo,
subtus pallidiore; pilis longiSj unicoloribus. Dentes 32.
VESPERTILIO SERQTINUS, Schrei. Säuglh.p. 167. sp. H. tab.55. Erxleh. Syst. p.il\-]. SPA- Zimm.Zool.
Geogr. II. p. 415. sp. 364. Gmel. Syst.I. p. 48. sp. 18, Kuhl, Deulschl, Flederm. in Wetter. Ann. sp.9.
Desmar. Mamm.p.iS’]. sp.ao5. Erie. Melh. tab.33. fig.l^. Id. inD ict.S c.N a t.LV Ill.p .34. Id.inFaun.
Franc. Mamm. p. 16. sp 9, Griffith, Anim. Kingd. V. p. 249. sp. 2. Lesson,Man. Mamm. p. 88. sp. 200.
Id. in Diet. Class. H. Nat. XFY. p.572, Fischer, Synops. Mamm. p .io 5.sp.5. Wagier, Syst. Amph.
p. 13.gen. 18. Fitting. Prodr. Faun. Austr. p.294, Gray, in Zool. Journ. ll.p .x 09. Jenyns, Brit.
Vert.p.nn. Bell, Hist.BriL.Quadrup.pM-cum Jig.
VESPERTILIO noctola (err.), Geoffr.in Ann.Mus.FIII.p.iQ?>.fig.l\’]. 48. Desm. in N, Dict.XXXF. p. 468.jp.4.
VESPERTILIO, Gosner,Av. II. p. 676. cum fig. Aldrov.Ornit.I. lib-ix.cap.i.p 5-]i./ig. in p.5-]6.
PIPISTRELLO serotino, Ranzani, Eiern. Zool. II. P.u.p.no5. sp. 4-
SEROTiNE, Daubent. in Mem. Acad. Paris. 1.759. pModab.i.Jig.i. Buff. Hist. Nat.FIII. p. 129. tab.tü./ig.i.
Cuv.Rcgn.Anim. I. p. 129. Id.lbid. 2. ed.I.p, 121.
vespert Ilion Serotine, He s mar. loco citato.
Serotine bat, Penn.Syn.p.5-jo. sp.288. Shaw, Gen. Zool. I. P.i. p, l32. Bewick, Hisl.Quadrup.p. 5i 3.
BLASSE FLEDERMÄUSE , Bechst. Nat. DcUtSChl. p II7O.
ABENDFLEDERMAUS, BLASSE FLEDERMAUS, Fitzinger, loco citato.
ISl on mai prima che sian passati i crepuscoli, ma per tutta la notte fino all alba,
vola questo Pipistrello uscendo dalle buche delle veechie fabbriche, e dalle soffitte delle
case càmpestri, ove aggruppato co’suoi simili dimora in anguste nicchie. Batte rapida-
mente le ali, e si allontana per lunghissimi tratti solito girar solingo nelle alte regioni
deU’aria. Trovasi ne bassi fondi e nelle maremme ugualmente che negli alti gioghi dei
monti. Abonda moltissimo ne’ paesi nostri, mostrasi talvolta nelle men rigide nottate
d’inverno, entra per fin la città, ove in numéro cede appena allô stesso y vispistrellus
ed al Rhinolophusferrum-equinum. Fréquenta pero in maggior copia i colli sùburbani,
raassime le gallerie di Albano, piacendosi di vagar tra le fronde in cima de* grandi e
continui alberi, spiccandosi altresi aile cataste de’legnami, tra’quali suol posare anco
il volo. Non è gregario giammai de’suoi simili, nè degli altri Vespertilionidi: cibasi in
grandissima parte di vegetabili: résisté a lungo digiuno: partorisce di primavera innol-
^rata un sol nottolino per volta.
Non sappiamo se alloggi in più parti delle isole Britanniche, perché finora fù osser-
vato unicamente nelle vicinanze di Londra. In Germania pero e nelle adiacenti regioni
è comunissimo quasi quanto fra noi, e quanto in Francia, ove lo discoperse corne tanti
altri il signor Daubenton; cui non crediamo di togliere alcun vanto, se pendiamo a
credere cbe l’Aldrovandi, ed i classici antichi, avuto riguardo a luoghi ove scrissero,
miravano ad esso quando del Vespertilione parlarono.