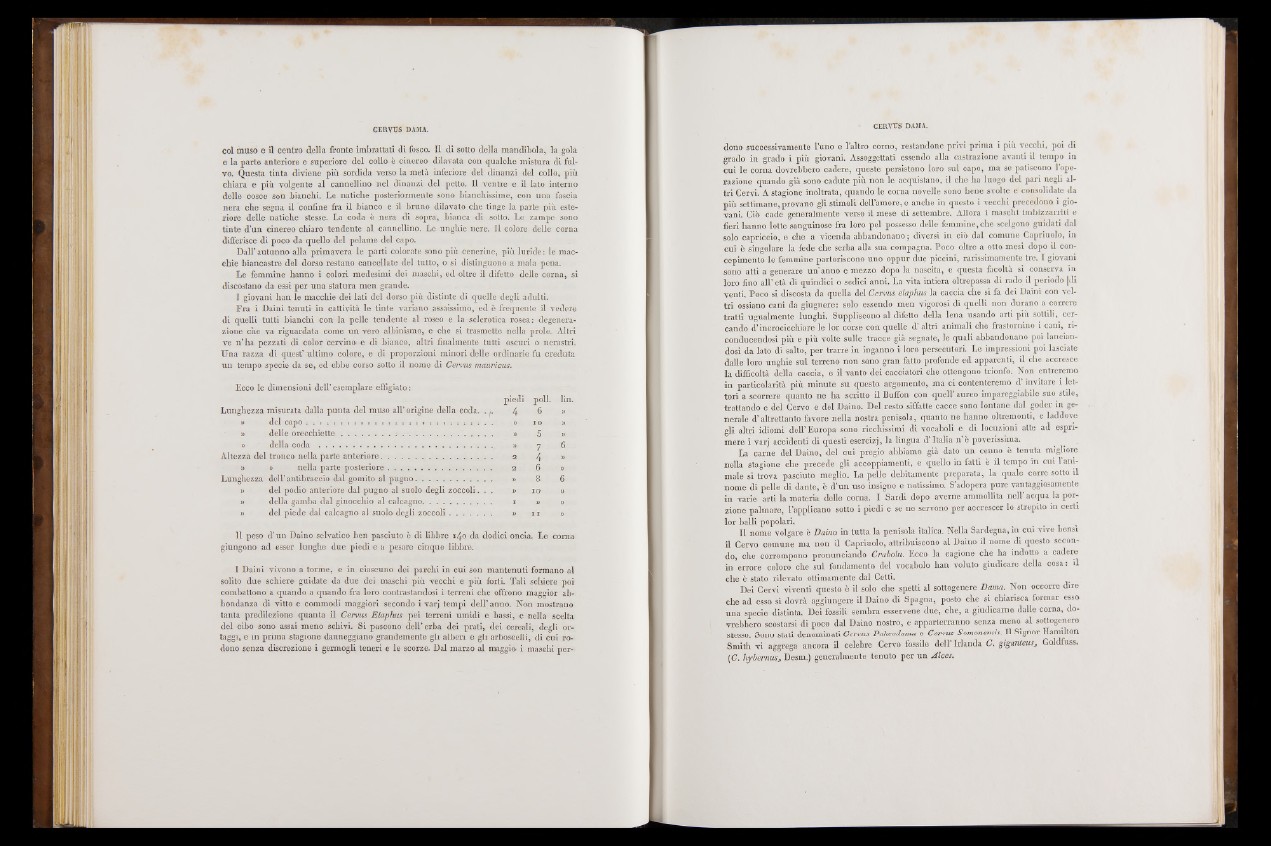
col muso e il centro della fronte imbrattati di fosco. II di sotto della raandibola, la gola
e la parte anteriore e superiore del collo e cinereo dilavata con qualche mistura di ful-
yo. Questa tinta diviene piü sordida verso la metä inferiore del dinanzi del collo, piü
chiara e piü yolgente al cannellino nel dinanzi del petto. II ventre e il lato interno
delle cosce son bianchi. Le natiche posteriormente sono bianchissime, con una fascia
nera ehe segna il confine fra il bianco e il bruno dilavato ehe tinge la parte piü este-
riore delle natiche stesse. La coda & nera di sopra, bianca di sotto. Le zampe sono
tinte d’un cinereo chiaro tendente al cannellino. Le unghie nere. Il colore delle corna
differisce di poco da quello del pelame del capo.
Dali’ autunno alia primavera le parti colorate sono piü cenerine, piü luride: le mac-
chie biancastre del dorso restano cancellate del tutto, o si distinguono a mala pena.
Le femmine hanno i colori medesimi dei maschi, ed oltre il difetto delle corna, si
discostano da essi per una statura men grande.
I giovani han le macchie dei lati del dorsö piü distinte di quelle degl.i adulti.
Fra i Daini tenuti in cattivitä le tinte yariano assaissimo, ed e frequente il vedere
di quelli tutti bianchi con la pelle tendente al roseo e la sclerotica rosea: degenera-
zione ehe va riguardata come un vero albinismo, e- ehe si trasmette nella prole. Altri
ve n’ ha pezzati di color cervino e di bianco, altri finalmente tutti oscuri o nerastri.
Una razza di quest’ ultimo colore, e di proporzioni minori delle ordinarie fu creduta
un tempo specie da se, ed ebbe corso sotto il norae di Cervus mauricus.
Ecco le dimensioni dell’ esemplare effigiato:
piedi poll. lin.
Lunghezza misurata dalla punta del muso all’origine della coda. . j. 4 6 »
» del cap o ..............................................: ................................. » 10 »
» delle orecchiette........................ . . . . . . . . . . . . . . » 5 »
» ' della coda ............ ................................... » 7 6
Altezza del tronco nella parte anteriore............................................ 2 4 »
» » nella parte posteriore ..... ....................................... 2 6 »
Lunghezza dell’ antibraccio dal gomito al pugno........................... » 8 6
» del podio anteriore dal pugno al suolo degli zoccoli. . . » 10 »
» della gamba dal ginocehio al calcagno........................ 1 » »
» del piede dal calcagno al suolo degli zoccoli . . . . . . . » 11 »
11 peso d’un Daino selvatico ben pasciuto è di libbre 140 da dodici oncia. Le corna
giungono ad esser lunghe due piedi e a pesare cinque libbre.
I Daini vivono a torme, e in ciascuno dei parehi in cui son mantenuti formano al
solito due schiere guidate da due dei maschi piü vecchi e piü forti. Tali schiere, poi
combatlono a quando a quando fra loro contrastandosi i terreni ehe offrono maggior ab-
bondanza di vitto e commodi maggiori secondo i varj tempi dell’ anno. Non mostrano
tanta predilezione quanta il Cervus Elaphus pei terreni umidi e bassi, e nella scella
del cibo sono assai meno schivi. Si pascono delTerba dei prati, dei cereali, degli or-
taggi, e in prima stagione danneggiano grandemente gli alberi e gli arboscelli, di cui ro-
dono senza discrezione i germogli teneri e le scorze. Dal marzo al maggio i maschi perdono
successiyamente l’uno e 1’altro corno, restandone privi prima i piu vecchi, poi di
grado in grado i piü gioyani. Assoggettati essendo alia castrazione avanti il tempo in
cui le corna dovrebbero cadere, queste persistono loro sul capo, ma se patiscono 1 ope-
razione quando giä sono cadute piü non le acquistano, il che ha luogo del pari negli altri
Cervi. A stagione inoltrata, quando le corna novelle sono bene svolte e consolidate da
piü settimane,provano gli stimoli dellamore,e anche in questo i vecchi precedona i gioyani.
Ciö cade generalmente verso il mese di settembre. Allora i maschi imhizzarriti e
fieri hanno lotte sanguinose fra loro pel possesso delle femmine, ehe scelgono guidati dal
solo Capriccio, e ehe a vicenda ahbandonano; diversi in ciö dal comune Capriuolo, in
cui e singolare la fede ehe serba alia sua compagna. Poco oltre a otto mesi dopo il con-
cepimento le femmine partoriscono uno oppur due piccini, rarissimamente tre. I giovani
sono atti a generare un’anno ©mezzo dopo la nascita, e questa facoltä si conserva in
loro fino all’ etä di quindici o sedici anni. La vita intiera oltrepassa di rado il periodo [di
venti. Poco si discosta da quella del Cervus elaphus la caccia ehe si fa dei Daini con vel-
tri ossiano cani da giugnere: solo essendo men vigorosi di quelli non durano a correre
tratti ugualmente lunghi. Suppliscono al difetto della lena usando arti piü sottili, cer-
cando d’incrocicchiare le lor corse con quelle d’ altri animali ehe frastornino i cani, ri-
conducendosi piü e piü volte sulle tracce giä segnate, le quali ahbandonano poi lancian-
dosi da lato di salto, per trarre in inganno i loro persecutori. Le impressioni poi lasciate
dalle loro unghie sul terreno non sono gran fatto profonde ed apparenti, il ehe accresce
la difficoltä della caccia, e il vanto dei cacciatori ehe ottengono trionfo. Non entreremo
in particolaritä piü minute su questa argomento, ma ci contenteremo d’ invitare i let-
tori a scorrere quanta ne ha scritto il Buffon con quell’aureo impareggiabile suo stile,
trattando e del Cervo e dei Daino. Del resto siffatte cacce sona lontane dal gader in generale
d’altrettanto favore nella nostra penisala, quanto ne hanno oltremonti, e laddove
gli altri idiomi dell’Europa sono ricchissimi di vocaboli e di locuzioni alte ad espri-
mere i varj accidenti di questi esercizj, la lingua d Italia n e poverissima.
La carne del Daino, del cui pregio abbiamo giä dato un cenno e tenuta migliore
nella stagione ehe precede gli accoppiamenti, e quella in fatti e il tempo in cui 1 animale
si trova pasciuto meglio. La pelle debitamente preparata, la quale corre sotta il
nome di pelle di dante, e d’un uso insigne e natissimo. S’adopera pure vantaggiosamente
in yarie arti la materia delle corna. I Sardi dopo averne ammollita nell’ acqua la por-
zione palmare, l’applicano sotta i piedi e se ne servono per accrescer lo strepita in certi
lor balli popolari.
Il nome volgare h Daino in tutta la penisola italica. Nella Sardegna, in cni vive bensi
il Cervo comune ma non il Capriuolo, attriluiscono al Daino il nome di questo secondo,
ehe corrompono pronunciando Crabolu. Ecco la, cagione che ha indotto a cadere
in errore coloro ehe sul fondamento del vocabolo han voluto giudicare della cosa: il
ehe b stato rilevato ottimamente dal Cetti.
Dei Cervi viventi questo 6 il solo ehe spetti al sottogenere Damn. Non occorre dire
che ad esso si dovra aggiungere il Daino di Spagna, posto ehe si chiarisca formar esso
una specie distinta. Dei fossili sembra esservene due, ehe, a giudicarne dalle corna, do-
vrebhero scostarsi di poco dal Daino nostro, e apparterranno senza meno al sottogenere
stesso. Sono st'ati denoininati Cervus Palceodama e Cervus Somonensis. Il Signor Hamilton
Smith vi aggrega ancora il celebre Cervo fossile dell’ Irlanda C. giganleuSj GoldXuss.
[C. hybernuSj Desm.) generalmente tenuto per un Aloes.