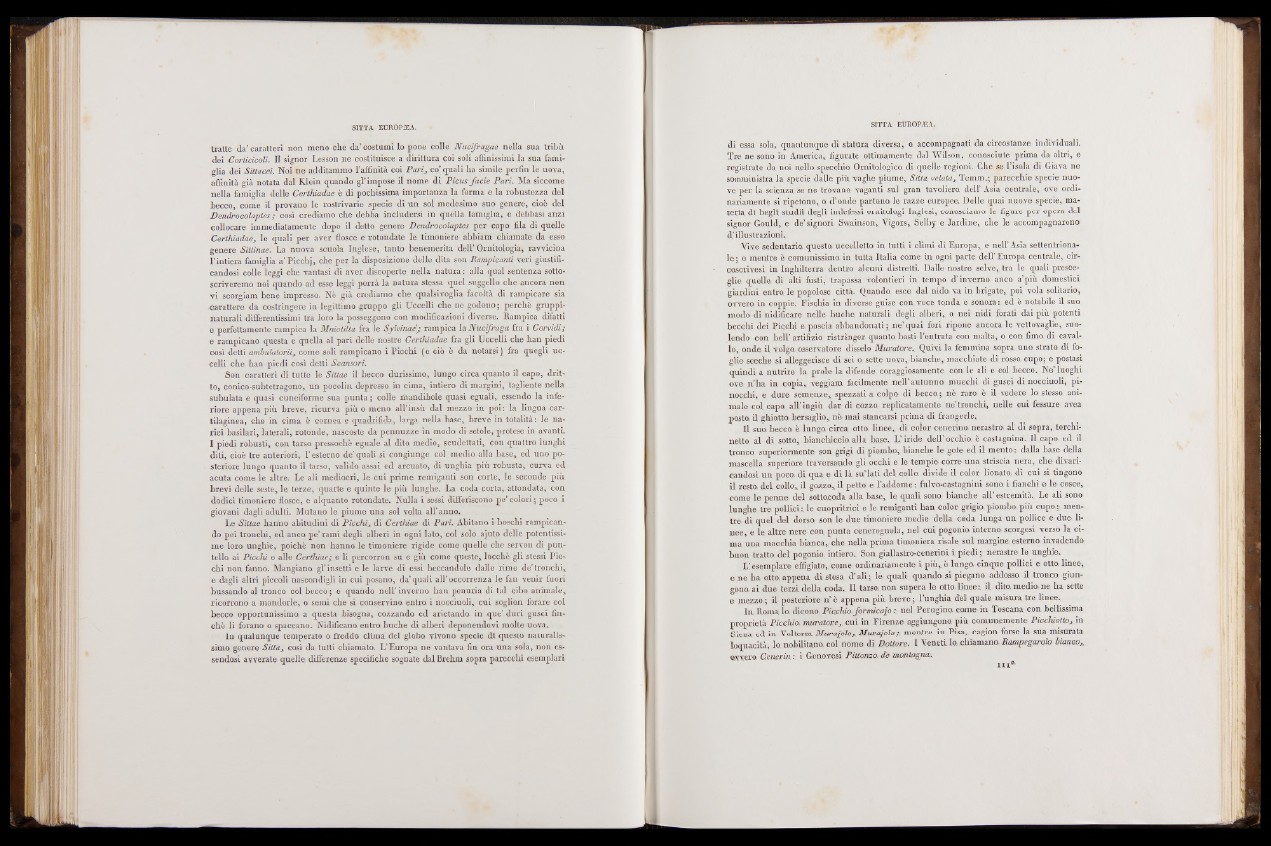
tratte da’ caratteri non meno che da’ costumi lo pone colle Nucifragae nella sua tribu
dei Corticicoli. II signor Lesson ne costituisce a dirittura coi soli affinissimi la sua fami-
glia dei Sittacei. Noi ne additammo l’affinità coi Parij co’ quali ha simile perfin le uova,
affînità già notata dal Klein quando gl* impose il nome di Picus facie Pari. Ma siccome
nella famiglia delle Certhiadae b di pochissima importanza la forma e la robustezza del
becco, come il proyano le rostriyarie specie di un sol medesimo suo genere, cioè del
Dendrocolaptes ; cosi crediamo ehe debba includersi in quella famiglia, e debbasi anzi
collocare immediatamente dopo il detto genere Dendrocolaptes per capo fila di quelle
Certhiadaele quali per ayer floscé e rotondate le timoniere abbiam chiamate da esso
genere Sittinde. La nuoya scuola Inglese, tanto benemerita dell’ Ornitologia, rayyicina
l’intiera famiglia a’ Picchj, ehe per la disposizione delle dita son Rampicanti yeri giustifi-
candosi colie leggi ehe vantasi di ayer discoperte nella natura : alla quai sentenza sotto-
scriyeremo noi quando ad esse leggi porrà la natura stessa quel suggello ehe ancora non
yi scorgiam bene impresso. Ne già crediamo che qualsiyoglia facolta di rampicare sia
-carattere da costringere in legittimo gruppo gli Uccelli che ne godono; perché gruppi-
naturali differèntissimi tra loro la posseggono con raodificazioni diverse. Rampica difatti
e perfettamente rampica la Mniotilta fra le Sylvinae•; rampica la Nucifraga fra i Corvidi;
e rampicano questa e quella al pari delle nostre Certhiadae fra gli Uccelli ehe han piedi
cosi detti ambulatoriiA come soli rampicano i Picchi (e cio è da notarsi) fra quegli uccelli
ehe han piedi cosi detti Scansori.
Son caratteri di tutte le Sittae il becco durissimo, lungo circa quanto il capo, drit-
to, conico-subtetragono, un pocolin depresso in cima, intiero di margini, tagliente nella
subulata e quasi cunéiforme sua punta ; colle mandibole quasi eguali, essendo la inferiore
appena più breve, ricurva.più o mena ail’insù dal mezzo in poi: la lingua -car»
tilaginea, che in cima è cornea e quadrifida, larga nella base, breve in totalità: le na-
rici basilari, laterali, rotonde, nascoste da pennuzze in modo di setole, protese in avanti.
I piedi robusti, con tarso pressochè eguale al dito, medio, scudettati, con quattro lünghi
diti, cioè tre anteriori, l’esterno de’quali si congiunge col medio alla base, ed uno posteriore
lungo quanta il tarso, valida assai ed arcuato, di unghia più robusta, curva ed
acuta corne le altre. Le ali mediacri, le cui prime remiganti son corte, le seconde più
brevi delle seste, le terze, quarte e quinte le più lunghe. La coda, corta, attondata, con
dodici timoniere flosce, e alquanto rotondate. Nulla i sessi differiscono pe’ colori ; poco i
gioyani dagli adulti. Mutano le piume una sol vol ta all’anno.
Le Sittae hanno abitudini di Picchi> di Certhiae di Pari. Abitana i boschi rampîcan-
do pei tronchi, ed anca pe’rami degli alberi in ogni lato, col solo ajuto. delle potentissi-
me loro unghie, poichè non hanno le timoniere rigide come quelle ehe servon di pun-
tello ai Picchj. e aile Certhiaei e li percorron su e giù come queste, locchè gli stessi Picchi
non fanna. Mangiana gl’insetti e le larve di essi beccandole dalle rime de’tronchi,
e dagli altri piccali nascandigli in cui posano, da’quali all’occorrenza le fan venir fuori
bussando al tronco col becco; e quando nell’inyerno han penuria di tal cibo animale,
ricorrono a mandorle, o semi ehe si conseryina entra i nocciuoli, cui soglian forare col
becco opportunissima a questa bisogna, cozzando ed arietanda in que’ duri gusci fin-
chè li forano o. spaccano. Nidificano entra buche di alberi deponendavi moite uava..
In qualunque temperate o, fredda dim a del globe vivono. specie di questo. naturalis-
simo genere Sittax cosi da tutti chiamato. L’Europa ne yantava fin ora una sola, non es.-
sendosi ayyerate quelle differenze specifiche sognate dal Brehm sopra parecchi esemplari
di essa sola, quantunque di statura diversa, a accampagnati da circostanze individuali.
Tre ne sono in America,, figurate. ottimamente dal Wilson, conosciute prima da altri, e
registrale da no,i nello. specchio. Ornitolagico. di quelle regiani. Ghe se l’isola di Giava ne
somministra la specie dalle più vaghe piume, Sitta velatax Temm,; parecehie specie nuo-
ve per la scienza se ne trovano. vaganti sul gran tavoliero. dell’ Asia centrale, ove ordi-
nariamente si ripetono, o. d’onde partano, le razz.e europee. Delle quai nueye specie, materia
di begli studii degli indefèssi ornitolagi Inglesi, conosciamo. le figure per opera del
signor Gould, e de’signori Swainson, Vigors, Selby e Jardine, che le. accompagnarono
d’illustrazionh
Vive sedentaxia questa uceelletto in tutti i climi di Europa, e nell’ Asia settentriona-
le ; e mentre è comunissimo. in tutta Italia come in ogn.i parte dell’Europa centrale, cir-
cascrivesi in Inghilterra dentro alcuni distretti. Dalle nostre selve, tra le quali presCe-
glie quelle di alti fusti, trapassa yolontieri in tempo d’invemo. anco. a’più domestici
giardini entro, le popolose città. Quando esce dal nido. va in brigate, poi vola solitario,
owero in coppie. Eischia. in diverse guise con voce tonda e sonora:: ed è notabile il suo
modo di nidifiçare nelle huche naturali degli alberi, o nei nidi forati dai più potenti
becchi dei Picchi e posçia abbandonatî ; ne’quai fori ripone ancoxa le vettovaglie, suo-
lendo con bell’ artifizio ristringer quanto basti l’entrata con malta,, o eon fimo di caval-
lo, onde il volgo, osservatore disselo Muratore.. Quivi la femmina sopra uno. strata di fo-
glie secche si alleggerisce di sei o, sette uo.va, bianche, macchiate di rossa cupo; e postasi
quindi a nutrire la proie la difende coxaggiosamente con le ali e col becco.. Ne’ luoghi
ove n ’ha in copia, veggiam facilmente neirautunno. muechi di gusci di nocciuoli, pi-
nocchi, e dure semenze, spezzati a colpo- di becco,; né raro. è il vedere lo. stesso animale
col capo, all’ingiù dar di eozzo. replicatamente ne’tronchi, nelle cui fessure avea
posta il ghiatto. bersaglio, n é mai stancarsi prima di frangerle..
U suo. becco. è lungo, circa otto, linee, di color cenerino; nerastro.. al di supra, torchi-
netto. al di sotto, bianchiccîo alla base.. L’iride dell’ occhia è castagnina. Il capo, ed il
tronco superiormente son grigi di piombo, bianche le gpte ed il mentor: dalla, base della
mascella superioxe traversando, gli occhi e le tempie corre una striscia nera, che divari-
candosi un poco, di qua. e di là su’lati del collo. divide il color lionata di cui si tingono
il resta de! collo, il gozza, il petto e l’addome: fulvo-castagnini sono, i fianchi e le cosce,
corne le penne del sottocoda alla base, le quali sono, bianche ail’ estremità.. Le ali sono
lunghe tre pollici le cuopritrici e le remiganti han color grigio, piombo. più cupo.;- mentre
di quel del dorsa son le due timoniere medîe della coda lunga un pollice e due li-
nee, e le altre nere con punta cenerognola, nel cui pogonio. interna scorgesi verso la cima
una macchia bianca, che nella prima timoniera risale sul margine esterno. invadendo
b.uon tratto, de! pogonio. intiero.. Son giallastro-çen.erini i. piedi; nexastre- le- unghie..
L! esemplare effigiato, corne ordinariamente i piu, è lungo, cinque pollici- e- otto, linee,,
e n e ha otto, appena distesa d’ali; le quali quando si piegano. addosso, il tronco giun-
gono, ai due terzi della, coda.. Il tarso non supera le otto, linee:. il dito, medio, ne ha sette
e- mezzo.; il p.osteriore- n’ è appena più breve ; l’ungbia del quale misura tre linee-..
In Roma lo. dicono. PiccHo formcajo nel Perugino, e.ome in Toscana con bellissima
propriété Picchio, muratorex cui in Firenze aggïungono. più comunemente Picchiottox in
Siena ed in Volterra Murajolox Murajola;; mentre in Pisa,. cagion forse la sua misurata
loquac.ità, lo nobilitano. col nome di Dotlore. I Veneti lo chiamano, Rampegarolo biancox
owero. Censrin.:. i Genovesi Pittonzo. de montagna:..
m '