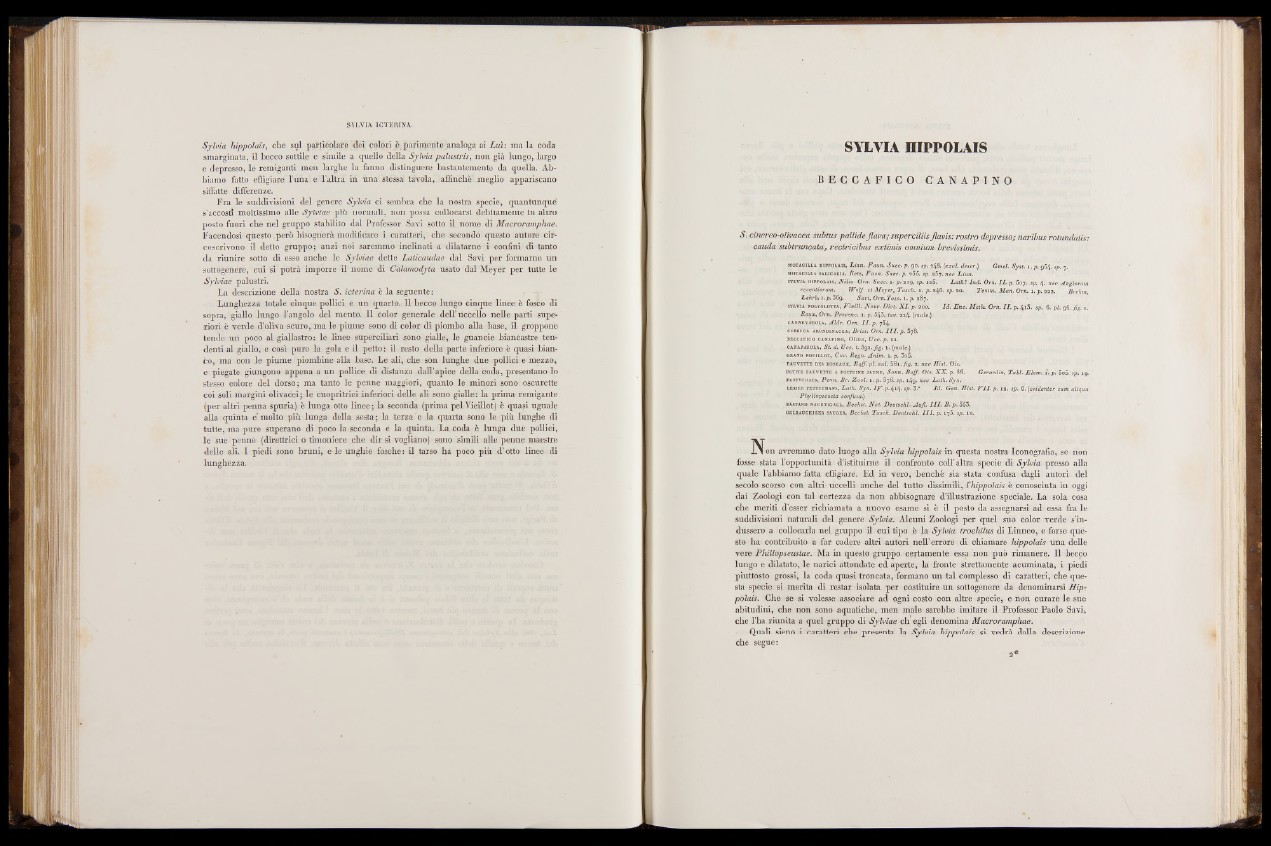
Sylvia hippolais, clie sul particolaredei colori &,parimente analoga ai Lui: m a la coda
smarginala, il becco sottile e simile a quell o della Sylvia palustris, non gia lungo, largo
e depresso, le remiganti men larghe la fanno distinguere bastantemente da quella. Ab-
biamo fatto efhgiare l’una e T.altra in una stessa tayola, affinchA. meglio appariscano
siffatte differenze.
Fra le suddivisioni del genere Sylvia ci sembra che la nostra specie, quantunque
s’accosti moltissimo alle Sylviae piu normali, non possa collocarsi debitamente in altro
posto fuori che nel gruppo stabilito dal Professor Sayi sotto il nome di Macroramphae.
Facendosi questo pero bisogriera inodificare i caratteri, che secondo questo autore cir-
coscriyono il detto gruppo; anzi noi saremmo inclinati a dilatarne i confini di fanto
da riunire sotto di esso anche le Sylviae dette Laticaudae dal Sayi per formarne un
sottogenere, cui si potra imporre il nome di Calamodyta usato dal Meyer per tutte le
Sylviae palustri.
La descrizione della nostra S. icterina e la seguente:
Lunghezza totale cinque pollici e un quarto. Il becco lungo cinque linee b fosco di
sopra, giallo lungo l’angolo del mento. Il color generale dell’uccello nelle parti supe-
riori e yerde d’oliya scuro, ma le piume sono di color di piombo alia base, il groppone
tende un poco al giallastro: le linee superc.iliari sono gialle, le guancie biancastre ten-
denti al giallo, e cosi pure la gola e il petto: il resto della parte inferiore e quasi bianco,
ma con le piume piombine alia base. Le ali, che son lunghe due pollici e mezzo,
e piegate giungono appena a un pollice di distanza dall’apice della coda, presentano lo
stesso colore del dorso; ma tanto le penne maggiori, quanto le minori sono oscurette
coi soli margini oliyacei; le cuopritrici inferiori delle ali sono gialle: la prima remigante
(per altri penna spuria) e lunga otto linee; la seconda (prima pel Vieillot) b quasi uguale
alia quinta e molto piu lunga della sesta; la terza e la quarta sono le piu lunghe di
tutte, ma pure superano di poco la seconda e la quinta. La coda b lunga due pollici,
le sue penne (direttrici o timoniere che dir si yogliano) sono simili alle penne maestre
delle ali. I piedi sono bruni, e le unghie fosche: il tarso ha poco piu d’ otto linee di
lunghezza.
B E C C A F I C O C A N A P I N O
S. cinereo-olivacea subtus pallide flava; superciliis flavis: rostro depresso; naribus rotundatis:
cauda subtruncataj rectricibus extimis omnium brevissimis.
MOTACILLA hippolais, Linn. Faun. Suec. p. 90. sp. 348. (excl. descr.) Gmel. Syst. 1. p. 9Ç4. sp. 7.
motacilla salicaria, Reiz, Faun. Suec. p. 355. sp. 337. nee L in n .
Sylvia hippolais, JYilss- Orn. Suec. 1. p. 219. sp. io5. L a th i Ind. Orn. I I . p. 607. sp. 4. nee Anglorum
recentiorum. W o lf et M eyer, Tasch. 1. p. 246. sp. 30. Temm. Man. Orn. 1. p. 332. Brehm,
Lehrb, 1. p. 369. Savi, Orn. Tose. 1. p. 387.
SYLVIA POLYGLOTTA, V ie ill. Nouv. D iet. X I . p. 20ol Id . E n c. Meth. Orn. I I . p. 4x3. sp. 6. p i. 96. fig. 1.
Roux, Orn. Provenc. 1. p .p lß . tav. 224. (male.)
CANNEVAROLA, A ld r . Orn. I I . p. 754.
.... CURROCA ARÖNDINACEA, Briss. Orn. I I I . p. 378.
BECCAFICO CANAPINO, O lin a, Ücc. p. 11.
CANAParola, S t. d. Ucc. t..5ÿ*.fig. l. (male)
grand podillot, Cuv. Regn. A n im . l. p. 3o5.
fauvette des roseaux, B u jf.p l. enl. 581. fig. 3. nee Hist. Ois.
petite fauvette a poitrine jaune, Sonn. Buff. Ois. X X . p. 86. Gerardin, T a ll. E lem . i. p. 3o5. sp. ig.
pettychaps, Penji. Br. Zool. 1. p. 376. sp. i 4g. nee Lath. Syn;
LESSER pettychaps, Lath. Syn. I F . p . ^ 1^ . sp. 3.* Id . Gen. Hist. V I I . p. 12. sp. 6. (evidenter cum aliqua-
Phyllopseusta confusa.)
BASTARD NACHTIGALL, Bechst. N a t. Deutschl. A u fl. I I I . B. p.553,
GELBAUCHIGER SAUGER, Bechst. Tasch. Deutschl. I I I . p. 173. sp. 10.
3N[on ayremmo dato luogo alia Sylvia hippolais in questa nostra Iconografia, se non
fosse stata l’opportunità d’istituime il confronto coll’altra specie di Sylvia presso alia
quale 1’abbiamo fatta effigiare. Ed in yero, benchè sia stata confusa dagli autori del
secolo scorso con altri uccelli anche del tutto dissimili, Vhippolais b conosciuta in oggi
dai Zoologi con tal certezza da non abbisognare d’iliustrazione speciale. La sola cosa
che meriti d’esser richiamata a nuoyo esame si è il posto da assegnarsi ad essa fra le
suddiyisioni naturali del genere Sylvia. Alcuni Zoologi per quel suo color yerde s’in-
dussero a collocarla nel gruppo il cui tipo è la Sylvia troehilus. di Linneo, e forse questo
ha contribuito a far cadere altri autori nell’errore di chiamare hippolais una delle
vere Phillopseustae. Ma in questo gruppo. certamente essa non puo rimanere. Il becco
lungo e dilatato, le narici attondate ed aperte, la fronte strettamente acuminata, i piedi
piuttosto grossi, la coda quasi troncata, formano un tal complesso di caratteri, che questa
specie si mérita di restar isolata per costituire un sottogenere da denominarsi Hippolais.
Che se si yolesse associare ad ogni costo con altre specie, e non curare le sue
abitudini, che non sono aquatiche, men male sarebbe imitare il Professor Paolo Sayi,
che 1’ha riunita a quel gruppo di Sylviae ch egli denomina Macroramphae.
Quali sieno i caratteri che présenta la Sylvia hippolais si yedrà dalla descrizione
ehe segue: