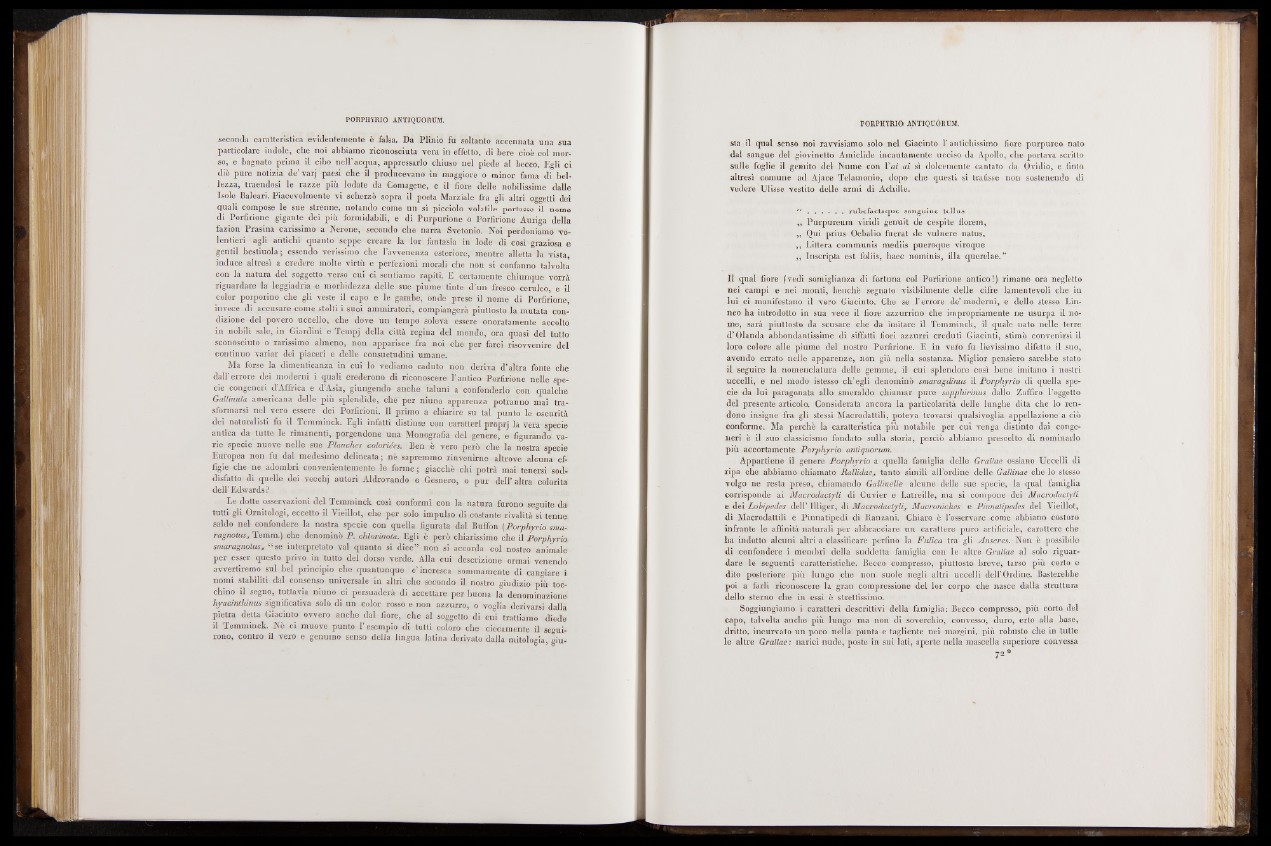
seconda caratteristica eyidentemente è falsa. Da Plinio fu soltanto accennata nna sua
particolare indole, elle noi abbiamo riconosciuta yera in effetto, di bere cioè col mor-
so, e bagnato prima il cibo nell’actjua, appressarlo chiuso nel piede al becco. Egli ci
diè pure noti/.ia de'yarj-paesi che il producevano in roaggiore o minor fama di bel-
lezza, traendosi le razze più lodate da Comagene, e il fiore delle nobilissime dalle
Isole Baleari. Piacevolmente yi scherzo sopra il poeta Marziale fra gli altri oggetti dei
quali compose le sue strenne, notando corne un si picciolo yolatile portasse il nome
di Porfirione gigante dei più formidabili, e di Purpurione o Porfirione Auriga della
fazion Prasina carissimo a Nerone, secondo che narra Syetonio. Noi perdoniamo yo-
lentieri agli antichi quanto seppe creare la lor fantasia in Iode di cosi graziosa e
gentil bestiuola ; essendo yerissimo che l’ayyenenza esteriore, mentre aliéna la yista
induce altresl a credere moite yirtù e perfezioni morali che non si confanno talvolta
con la natura del soggetto yerso cui ci sentiamo rapiti. E certamente chiunque yorrà
riguardare la leggiadria e morbidezza delle sue piume tinte d’un fresco ceruleo, e il
color porporino che gli yeste il capo e le gambe, onde prese il nome di Porfirione,
inyece di accusare come stolti i suoi ammiratori, compiangerà piultosto la mutata con-
dizione del poyero uccello, che doye un tempo soleya essere onoratamente accolto
in nobili sale, in Giardini e Tempj della città regina del mondo, ora quasi del tutto
sconosciuto o rarissimo almeno, non apparisce fra noi che per farci risoyyenire del
continuo yariar dei piaceri e delle consuetudini umane.
Ma forse la dimenticanza in cui lo yediamo caduto non deriya d’altra fonte che
dair errore dei moderni i quali crederono di riconoscere l ’antico Porfirione nelle specie
congeneri d’Affrica e d’Asiapgiungendo anche taluni a confonderlo con qualche
Galünula americana delle più splendide, che per niuna apparenza potranno mai tra-
sformarsi nel yero essere dei Porfirioni. 11 primo a chiarire su tal punto le oscurità
dei naturalist; fu il Temminck. Egli infatti distinse con caratteri proprj la yera specie
antica d a tu tte le rimanenti, porgendone una Monografia del genere, e figurando ya-
rie specie nuoye nelle sue Planches coloriées. Ben è yero pero che la nostra specie
Europea non fu dal medesimo delineata; nè sapremmo rinyenirne altroye alcuna effigie
che ne adombri conyenientemente le forme; giacchè chi potrà mai tenersi sod-
disfatto di quelle dei yecchj autori Aldroyando e Gesnero, o pur defl’ altra colorita
dell’Edwards ?
Le dotte osseryazioni del Temminck cosi conformi con la natura furono seguite da
tutti gli Ornitologi, eccetto il Vieillot, che per solo impulso di costante riyalità si tenne.
saldo nel confondere la nostra specie con quella figurata dal Buffon ( Porphyrio sma-
ragnotuSj Temrn.) che dénommé P. chlorinota. Egli è pero chiarissimo che il Porphyrio.
smaragnotus, “ se interpretato yal quanto si dice” non si accorda col nostro animale
per esser questo privo in tutto del dorso yerde. Alla cui descrizione ■ ormai yenendo
ayyertiremo sul bel principio che quantunque c’incresca sommamente di eangiare i
nomi stabiliti dal consenso uniyersale in altri che secondo il nostro giudizio più toc-
chino il segno, tuttavia niuno ci persuaderà di accettare per buona la denominazione
hyacinthinus significatiya solo di un color rosso e non azzurro, o yodia deriyarsi dalla
pietra detta Giacinto oyyero anche dal fiore, che al soggetto di cui trattiamo diede
il Temminck. Nè ci muoye punto l’esempio di tutti coloro che ciecamente il segui-
rono, contro il yero e genuino senso della lingua latina deriyato dalla mitologia, giusta
il quai senso noi ravvisiamo solo nel Giacinto l’anlicliissîmo fiore purpureo nato
dal sangue dei giovinetto Amiclide incautamente ueciso da Apollo, che porta va scrillo
sulle foglie il gemito dei Nu me con l’ai ai si dolceinente cantato da Ovidio, e finlo
altresi comune ad Ajace Telamouio, dopo che quesli si trafisse non sostenendo di
vedere Ulisse Testito delle armi di Achille.
u ................rubefactaque sanguine tellus
„ Purpureum viridi genuit de cespite florem,
„ Qui prius Oebalio fuerat de yulnere natus.
,, Littera communis mediis pueroque viroque
,, Inscripta est foliis, haec nominis, ilia querelae, ”
Il quai fiore (vedi somiglianza di fortuna col Porfirione antico!) rimane ora negletto
nei campi e nei monti, benchè segnalo visibilmente delle cifre lamenteToli che in
lui ci manifestano il Yero Giacinto. Che se l’errore de’moderni, e dello stesso Lin.-
neo ha introdotto in sua vece il fiore azzurrino che irnpropriamente ne usurpa il nome,
sarà piuttosto da scusare che da imitare il Temminck, il quale nato nelle terre
d’Olanda abbondanlissime di siffatti fiori azzurri creduti Giacinti, stimo conyenirsi il
loro colore aile piume dei nostro Porfirione. E in vefo fu lieyissimo difetto il suo,
ayendo errato nelle apparenze, non già nella sostanza. Miglior pensiero sarebbe stato
i l seguire la nomenclatura delle gemme, il cui splendore cosi bene imitano i nostri
uccelli, e nel modo istesso ch’egli denomino smaragdinus il Porphyrio di quella specie
da lui paragonata allo smeraldo chiamar pure sapphirinus dallo Zaffiro l’oggetto
del presente articolo. Considerata ancora la particolarità delle lunghe dita che lo ren-
dono insigne fra gli stessi Macrodattili, poteya trovarsi qualsivoglia appellazione a cio
conforme. Ma perché la caratteristica più notabile per cui yenga distinto dai conge-
neri è il suo classicismo fondato sulla storia, percio abbiamo prescelto di nominarlo
più accortamente Porphyrio antiquorum.
Appartiene il genere Porphyrio a quella famiglia delle Graîlae ossiano Uccelli di
ripa che abbiamo chiamato Rallidae| tanto simili all’ordine delle Gallinae che lo stesso
volgo ne resta preso, chiamando Gallinelle alcune delle sue specie, la quai famiglia
corrisponde ai Macrodactyli di Cuvier e Latreille, ma si compone dei Macrodactyli
e dei Lobipedes dell* Uliger, di Macrodaclylij Macroniches e Pinnatipedes dei Vieillot,
di Macrodattili e Pinnatipedi di Ranzani. Chiaro è l’osservare corne abbiano costoro
infrante le affinità naturali per abbracciare un carattere puro artificiale, carattere che
ha indotto alcuni altri a classificare perfino la Fulica tra gli insérés. Non è possibile
di confondere i membri délia suddetta famiglia con le altre Grallae al solo rigùar-
dare le seguenti caralteristiche. Becco compresso, piuttosto breve, tarse più corto e
dito posteriore più lungo che non suole negli altri uccelli delTOrdine. Basterebbe
poi a farli riconoscere la gran compressione dei lor corpo che nasce dalla struttura
dello sterno che in essi è strettissimo.
Soggiungiamo i caratteri descrittivi délia famiglia : Becco compresso, più corto dei
capo, talvolta anche più lungo ma non di soverchio, convesso, duro, erto alla base.,
dritto, incurvato un poco nella punta e tagliente nei margini, più robusto che in tutte
le altre Grallae; narici nude, poste in sui lati, aperte nella mascella superiore convessa
7a»