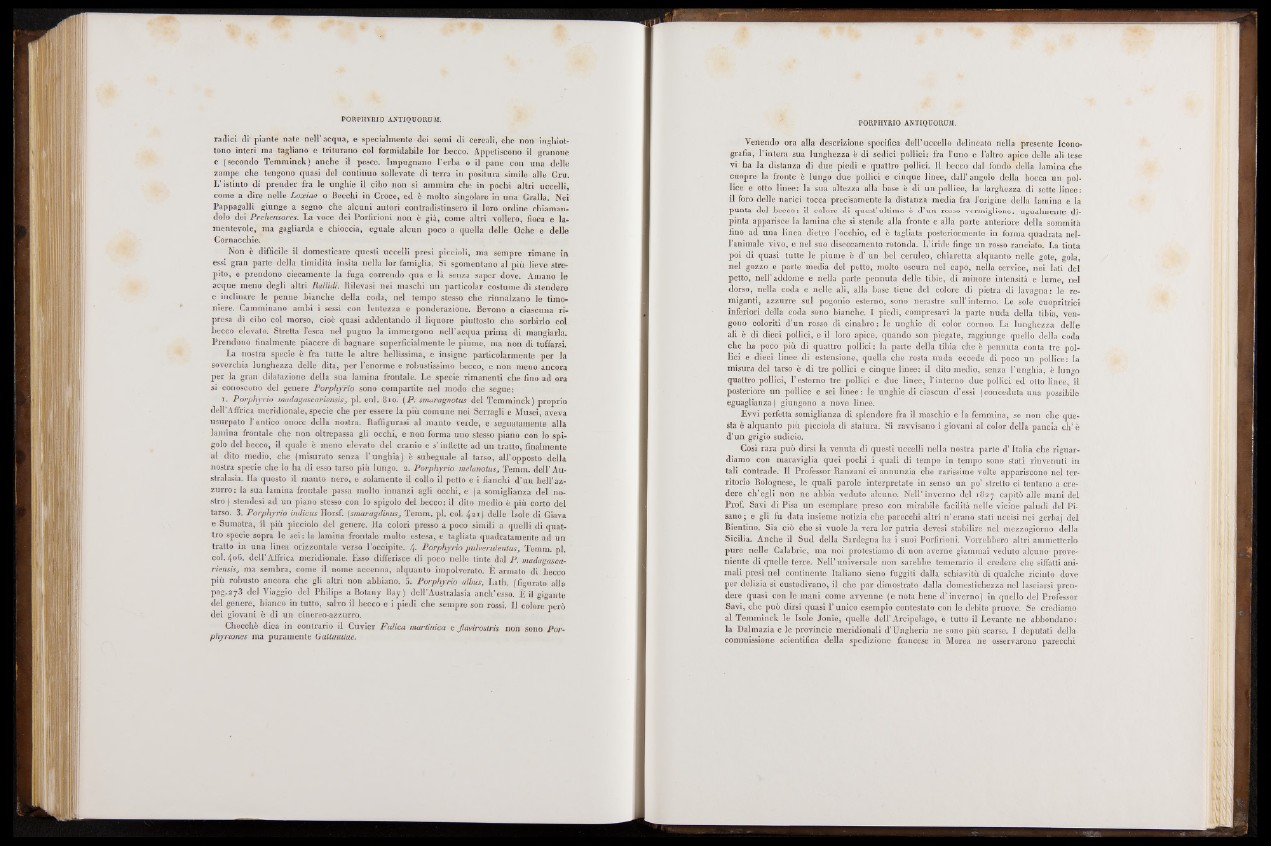
radici di'plante nate nell’acqua, e specialmente dei semi di cereali, che non imdiiot-
tono interi ina tagliano e triturano col formidabile lor becco. Appetiscono il granone
e (secondo Temminck) anche il pesce. Impugnano l’erba o il pane con una delle
zampe che tengono quasi del continuo sollevate di terra in positura simile alle Gru.
L’istinto di prender fra le unghie il cibo non si ammira che in pochi altri uccelli,
come a dire nelle Loxiae o Becchi in Croce, ed e molto singolare in una Gralla. Nei
Pappagalli giunge a segno che alcuni autori contradistinsero il loro ordine chiaman-
dolo dei Prehensores. La voce dei Porfirioni non e giä, come altri vollero, fioca e la-
mentevole, ma gagliarda e chioccia, eguale alcun poco a quella delle Oche e delle
Cornacchie.
Non e difficile il domesticare questi uccelli presi piccioli, ma sempre rimane in
essi gran parte della timiditä insita nella lor famiglia. Si sgomentano al piü lieve stre-
pito, e prendono ciecamente la fuga correndo qua e lä senza saper dove. Amano le
acque meno degli altri Rallidi. Rilevasi nei maschi un particolar costume di stendere
e inclinare le penne bianche della coda, nei tempo stesso che rinnalzano le timo-
niere. Camminano ambi i sessi con lentezza e ponderazione. Bevono a ciascuna ri-
presa di cibo col morso, cioe quasi addentando il liquore piuttosto che sorbirlo col
becco elevato. Stretta l’esca nei pugno la immergono nell'acqua prima di mangiarla.
Prendono finalmente piacere di bagnare superficialmente le piume, ma non di tuffarsi.
La nostra specie e fra tutte le altre bellissima, e insigne particolarmente per la
soverchia lunghezza delle dita, per l’enorme e robustissiino becco, e non meno ancora
per la gran dilatazione della sua lamina frontale. Le specie rimanenti che fino ad ora
si conoscono del genere Porphjrio sono compartite nei modo che segue:
i. Porphjrio madagascariensiSj pl. enl. 81 o. {P:smaragnotus del Temminck) proprio
dell’Affrica meridionale, specie che per essere la piü comune nei Serragli e Musei, aveva
usurpato l’antico onore della nostra. Raffigurasi al raanto verde, e segnatamente alia
lamina frontale che non oltrepassa gli occhi, e non forma uno stesso piano con lo spi-
golo del becco, il quale e meno elevato del cranio e s’inflette ad un tratto, finalmente
al dito medio, che (misurato senza l’unghia) e subeguale al tarso, all’opposto della
nostra specie che lo ha di esso tarso piü lungo. 2. Porphjrio melanotus^ Temm. dell’ Australasia.
Ha questo il manto nero, e solamente il collo il petto e i fianchi d’un bell’az-
zurro: la sua lamina frontale passa molto innanzi agli occhi, e (a somiglianza del nostro
) stendesi ad un piano stesso con lo spigolo del becco: il dito medio e piü corto del
tarso. 3 . Porphjrio indicus Horsf. (smaragdinuSj Temm. pl. col. 421) delle lsole di Giava
e Sumatra, il piü picciolo del genere. Ha colori presso a poco simili a quelli di quat-
tro specie sopra le sei: la lamina frontale molto estesa, e tagliata quadrataraente ad un
tratto in una linea orizzontale verso l’occipite. 4 - Porphjrio pulverulenluSj Temm. pl.
col. 406. dell’ Affrica meridionale. Esso differisce di poco nelle tinte dal P. madagasca-
riensisj ma sembra, come il nome accenna, alquanto impolverato. E armato di becco
piü robusto ancora- che gli altri non abbiano. 5 . Porphjrio albus, Lath, (figurato alia
pag.273 del Viaggio del Philips a Botany Bay) dell’Australasia anch’esso. E il gigante
del genere, bianco in tutto, salvo il becco e i piedi che sempre son rossi. Il colore perö
dei giovani e di un cinereo-azzurro.
Checche dica in contrario il Cuvier Fulica martinica e ßavirostris non sono Por-
phjriones ma puramente Gallinulae.
PORPHYRIO ANTIQUORUM.
Venendo ora alia descrizione specifica dell’uccello delineato nella presente Icono-
grafia, l’intera sua lunghezza b di s'edici pollici: fra 1’uno e l’altro apice delle ali tese
vi ha la distanza di due piedi e quattro pollici. II becco dal fondo della lamina che
cuopre la fronte b lungo due pollici e cinque linee, dull’ angolo della bocca un pollice
e otto linee: la sua altezza alia base e di un poll ice, la larghezza di sette linee:
il foro delle narici tocca precisamente la distanza media fra 1’origihe della lamina e la
punta del becco: il colore di quest’ultimo e d’un rosso vermiglione:.ugualmente di-
pinta apparisce la lamina che si stende alia fronte e alia parte anteriore della sommitk
fino ad una linea dietro l’occhio, ed e tagliata posteriormente in forma quadrata nel-
l ’animale vivo, e nei suo diseccamento rotonda. L’ iride finge un rosso ranciato. La tinta
poi di quasi tutte le piume e d* un bel ceruleo, chiaretta alquanto nelle gote, gola,
nei gozzo e parte media del petto, molto oscura nei capo, nella cervice, nei lati del
petto, nell’addome e nella parte pennuta delle tibie, di minore intensita e lume, nei
dorso, nella coda e nelle ali, alia base tiene del colore di pietra di lavagna: le re-
miganti, azzurre sul pogonio esterno, sono nerastre sull’interno. Le sole cuopritrici
inferior! della coda sono bianche. I piedi, compresavi la parte nuda della tibia, ven-
gono coloriti d’un rosso di cinabro : le unghie di color corneo. La lunghezza delle
ali e di dieci pollici, e il loro apice, quando son piegate, raggiunge quello della coda
che ha poco piu di quattro pollici: la parte della tibia che b pennuta conta tre pollici
e dieci linee di estensione, quella che resta nuda eccede di poco un pollice: la
misura del tarso e di tre pollici e cinque linee: il dito medio, senza l’unghia, e lungo
quattro pollici, 1’esterno tre pollici e due linee, l’interno due pollici ed otto linee, il
posteriore un pollice e sei linee: le unghie di ciascun d’essi (conceduta una possibile
eguaglianza) giungono a nove linee.
Ew i perfetta somiglianza di splendore fra il maschio e la femmina, se non che que-
sta b alquanto piu picciola di statura. Si ravvisano i giovani al color della pancia ch’ e
d’un grigio sudicio.
Cosi rara puo dirsi la venuta di questi uccelli nella nostra parte d’ Italia che riguar-
diamo con maraviglia quei pochi i quali di tempo in tempo sono stati rinvenuti in
tali contrade. Il Professor Ranzani ci annunzia che rarissime volte appariscono nei ter-
ritorio Bolognese, le quali parole interpretate in senso un po’ stretto ci tentano a credere
ch’egli non ne abbia veduto alcuno. Nell’inverno del 1827 capito alle mani del
Prof. Savi di Pisa un esemplare preso con mirabile facilita nelle vicine paludi del Pisano
; e gli fu data insieme notizia che parecchi altri n’ erano stati uccisi nei gerbai del
Bientino. Sia cio che si vuole la vera lor patria devesi stabilire nei mezzogiorno della
Sicilia. Anche il Sud della Sardegna ha i suoi Porfirioni. Vorrebbero altri ammetterlo
pure nelle Calabrie, ma noi protestiamo di non averne giammai veduto alcuno prove-’
niente di quelle terre. Nell’ universale non sarebbe temerario il credere che siffatti ani-
mali presi nei continente Italiano sieno fuggiti dalla schiavitu di qualche ricinto dove
per delizia si custodivano, il che par dimostrato dalla domestichezza nei lasciarsi pren-
dere quasi con le mani come awenne (e nota bene d’inverno) in quello del Professor
Savi, che pub dirsi quasi 1’ unico esempio contestato con le debite pruove. Se crediamo
al Temminck le Isole Jonie, quelle dell’Arcipelago, 'b tutto il Levante ne abbondano:
la Dalmazia e le provincie meridionali d’Ungheria ne sono piu scarse. I deputati della
commissione scientifica della spedizione francese in Morea ne osseryarono parecchi