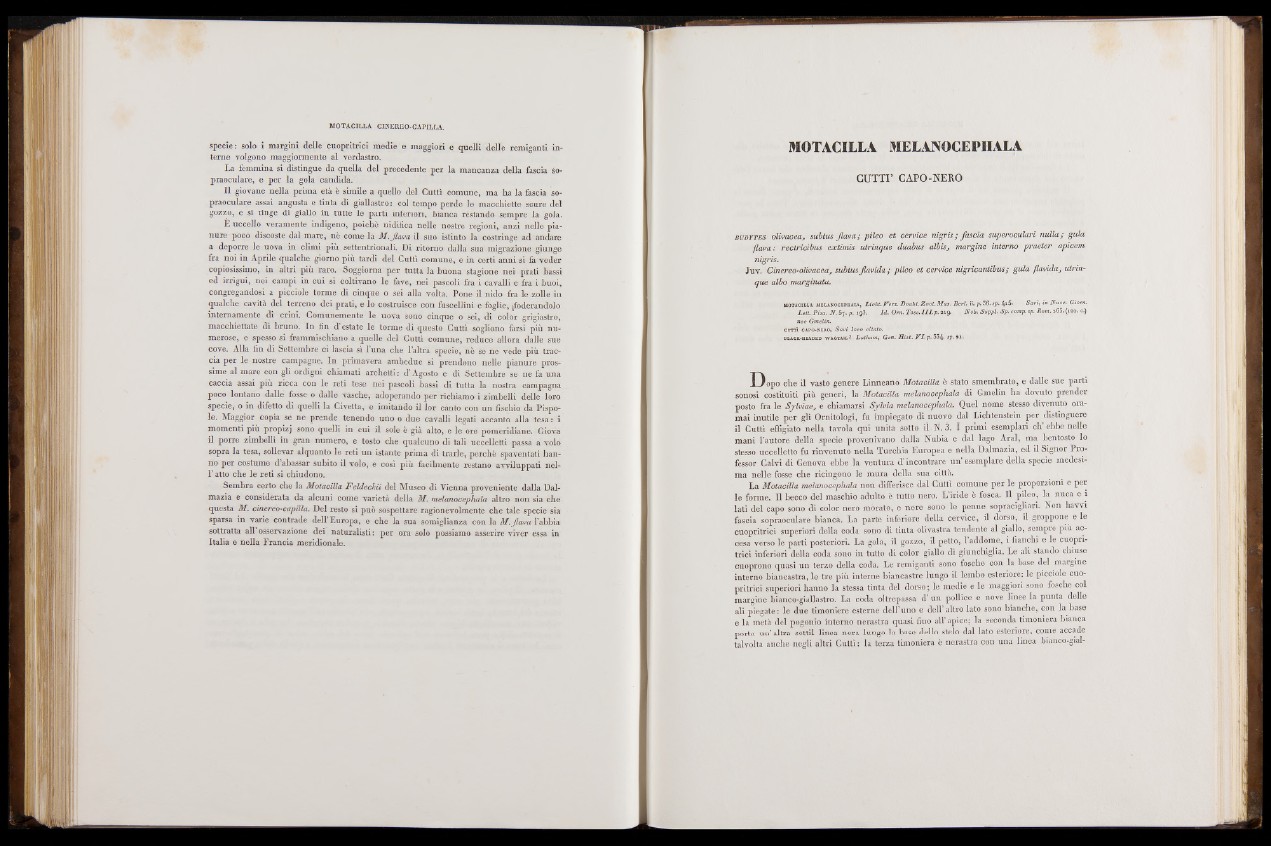
specie: solo i margin! delle cuopritrici medie e maggiori e quelli delle remiganti interne
yolgono maggiormente al yerdastro.
La femmina si distingue da quella del precedente per la mancanza della fascia éo-
praoculare, e per la gola Candida.
Il giovane nella prima età è simile a quello del Cutti comune, ma lia la fascia so-
praoculare assai angusta e tinta di giallastro: col tempo perde le macchiette scure del
gozzo, e si tinge di giallo in tutte le parti inferiori, bianca restando sempre la gola.
L uccello yeramente indigeno, poichè nidifica nelle nostre regioni, anzi nolle pia-
nure poco discoste dal mare, nè come la M.Jlava il suo istinto la costringe ad andare
a deporre le uoya in climi più settentrionali. Di ritorno dalla sua migrazione giunge
fra noi in Aprile qualche giorno più tardi del Cutti comune, e in certi anni si fa yeder
copiosissimo, in altri più raro. Soggiorna per tutta la buona stagione nei prati bassi
ed irrigui, nei campi in cui si coltiyano le fave, nei pascoli fra i cayalli e fra i buoi,
congregandosi a picciole tonne di cinque o sei alia yolta. Pone il nido fra le zolle in
qualche cayità del terreno dei prati, e lo costruisce con fusceliini e foglie, jfoderandolo
internamente di cnni, Comunemente le uoya sono cinque o sei, di color grigiastro,
macchiettate di bruno. In fin d estate le tonne di questo Cutti sogliono farsi più nu-
merose, e spesso si frammischiano a quelle del Cutti comune, reduce allora dalle sue
coye. Alla fin di Settembre ci lascia si lu n a cbe l ’altra specie, nè se ne vede più trac-
cia per le nostre campagne. In primavera ambedue si prendono nelle pianure pros-
sime al mare con gli ordigni chiamati archetti: d’Agosto e di Settembre se ne fa una
caccia assai più ricca con le reti tese nei pascoli bassi di tutta la nostra campagna
poco lontano dalle fosse o dalle vasehe, adoperando per richiamo i zimbelli delle loro
specie, o in difetto di quelli la Civetta, e imitando il lor canto con un fis chie da Pispo-
le. Maggior copia se ne prende tenendo uno o due cavalii legati accanto alla tesa : i
momenti piu propizj sono quelli in cui il sole è già alto, e le ore pomeridiane. Giova
il porre zimbelli in gran numéro, e tosto cbe qualcuno di tali uccelletti passa a volo
sopra la tesa, sollevar alquanto le reti un istante prima di trarle, perché spaventati han-
no per costume d’abassar subito il volo, e cosi più facilmente restano awiluppati nel-
l ’atto che le reti si chiudono.
Sembra certo che la Motacilla Feldeckii del Museo di Vienna proveniente dalla Dal-
mazia e considerata da alcuni corne varietà della M. melanocephala altro non sia che
questa M. cinereo-capïlla. Del resto si puô sospettare ragionevolmente che tale specie sia
sparsa in varie contrade dell’Europa, e che la sua somiglianza con la M. Jlava l’abbia
sottratta all osservazione dei naturalisti: per ora solo possiamo asserire viver essa in
Italia e nella Francia méridionale.
CUTTI’ CAPO-NERO
BUDYTES olivaceaj subtus Java; pïleo et cervice nigris; fascia superocülari nulla; gula
flava: rectricibus extimis utrinque duabus albisj margine interm praeter apicem
nigris.
Juv. Cinereo-olivaceaj subtusJlavida; pileo et cervice nigricanUbus; gula flavida,, utrinque
albo marginata.
motacilla melanocephala, Licht. Verz. Doubl. Zool. Mus. Berl. ii. p.36. sp. 4*5. Savi, in Nuov. Giorn.
Lett. Pisa. N. 5y. p. ig 3. Id. Orn. T osc.III.p. aig* Nob, Suppl. Sp. comp. sp. Rom. a65. (100. c.)
nee Gmelin.
c o n i CAPO-NERO, Savi loco citato.
BLACK-HEADED WAGTAIL? Latham, Gen. Hist. F"!, p. 334- sp.zi.
D o p o che il vasto genere Linneano Motacilla e stato smembrato, e dalle sue parti
sonosi costituiti piu generi, la Motacilla melanocephala di Gmelin ha dovuto prender
posto fra le Sylviaej e chiamarsi Sylvia melanocephala. Quel nome stesso divenuto ora-
mai inutile per gli Ornitologi, fu impiegato di nuovo dal Lichtenstein per distinguere
il Cutti effigiato nella tavola qui unita sotto il.N. 3. I primi esemplari ch’ ebbe nelle
mani l’autore della specie proveniyano dalla Nubia e dal lago Aral, ma bentosto lo
stesso uccelletto fu rinvenuto nella Turchia Europea e nella Dalmazia, ed il Signor Professor
Calvi di Genova ebbe la yentura d’incontrare un’esemplare della specie inedesi-
ma nelle fosse che ricingono le mura della sua citta.
La MotaciUa melanocephala non differisce dal Cutti comune per le proporzioni e per
le forme. Il becco del maschio adulto e tutto nero. L’iride e fosca. Il pileo, la nuca e i
lati del capo sono di color nero morato, e nere sono le penne sopracigliari. Non hayyi
fascia sopraoculare bianca. La parte inferiore della cervice, il dorso, il groppone e le
cuopritrici superiori della coda sono di tinta olivastra tendente al giallo, sempre piu ac-
cesa verso le parti posteriori. La gola, il gozzo, il petto, I’addome, i fianchi e le cuopritrici
inferiori della coda sono in tutto di color giallo di giunchiglia. Le ali stando chiuse
cuoprono quasi un terzo della coda. Le remiganti sono fosche con la base del margine
interno biancastra, le tre piu interne biancastre lungo il lembo esteriore: le picciole cuopritrici
superiori hanno la stessa tinta del dorso; le medie e le maggiori sono fosche col
margine bianco-giallastro. La coda oltrepassa d’ un pollice e nove linee la punta delle
ali piegate: le due timoniere esterne dell’uno e dell’ altro lato sono bianche, con la base
e la meta del pogonio interno nerastra quasi fino all’apice; la seconda timoniera bianca
porta un’altra sottil linea nera lungo la base dello stelo dal lato esteriore, come accade
talvolta anche negli altri Cutti: la terza timoniera b nerastra con una linea bianco-gial