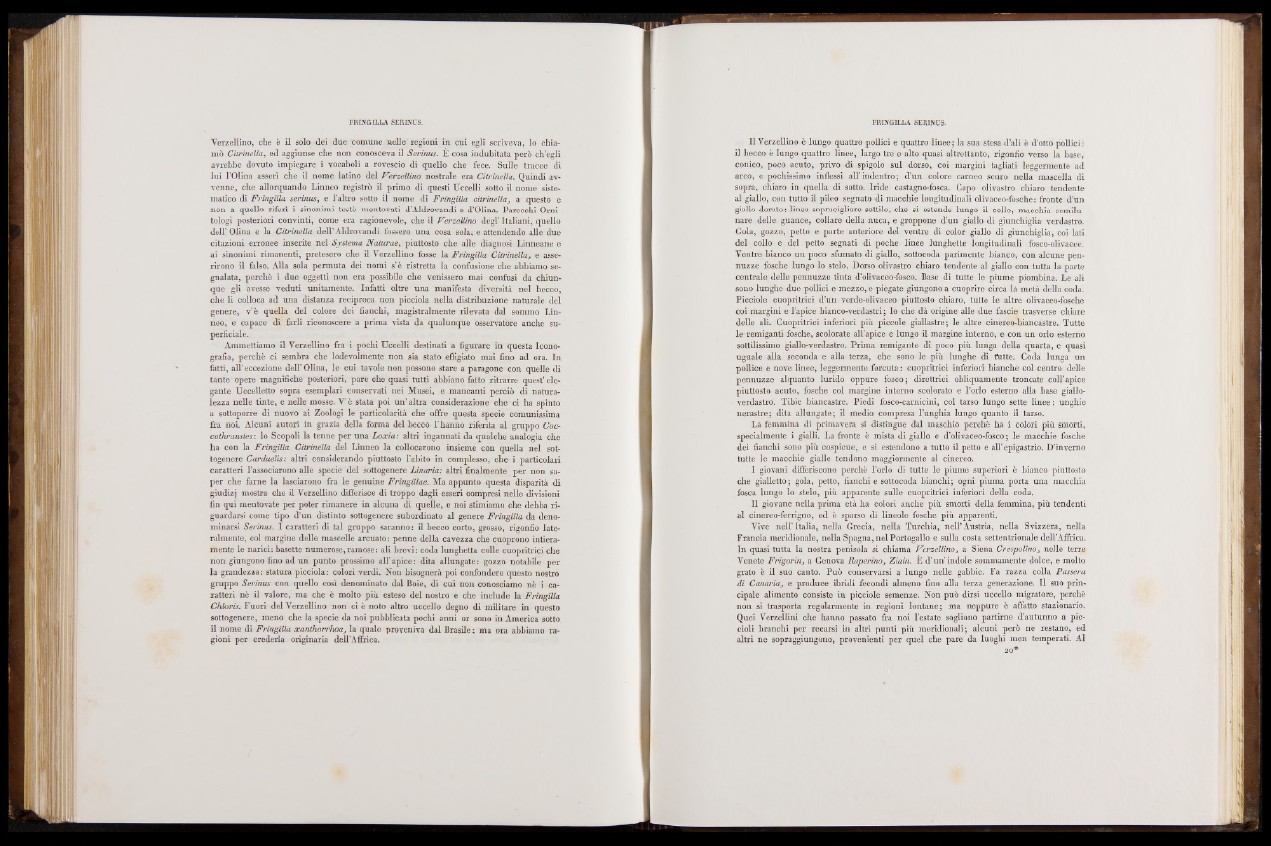
Verzellino, che è il solo dei due comune nelle regioni in cui egli scriveva, lo chia-
mö Citrinélla, ed aggiunse ehe non conosceva il Serinus. È cosa indubitata pero ch’egli
avrebbe doyuto impiegare i yocaboli a royescio di quello che fece. Sulle tracce di
lui l’Olina asseri ehe il nome latino del Verzellino nostrale era Citrinélla. Quindi av-
venne, ehe allorquando Linneo registro il primo di questi Uccelli sotto il nome siste-
matico di Fringilla serinus, e l ’altro sotto il nome di FringiUa citrinélla, a questo e
non a quello riferi i sinonimi testé mentoyati d’Aldrovandi e d’Olina. Parecchi Orni-
tologi posteriori conyinti, corne era ragionevole, ehe il Verzellino degl’ Italiani, quello
deir Olina e la Citrinélla delP Aldrovandi fossero una cosa sola, e attendendo aile due
citazioni erronee inserite nel Sjstema Naturae, piuttosto che alle diagnosi Linneane e
ai sinonimi rimanenti, pretesero ehe il Verzellino fosse la Fringilla Citrinélla, e asse-
rirono il falso. Alla sola permuta dei nomi s’è ristretta la confusione ehe abbiamo se-
gnalata, perché i due oggetti non era possibile ehe venissero mai confusi da chimique
gli avesse yeduti unitamente. Infatti oltre una manifesta diyersità nel becco,
ehe li colloca ad una distanza reciproca non picciola nella distribuzione naturale del
genere, y’è quella del colore dei fianchi, magistralmente rilevata dal sommo Linneo,
e capace di farli riconoscere a prima yista da qualunque osseryatore anche superficiale.
Ammettiamo il Verzellino fra i pochi Uccelli destinât! a figurare in questa Icono-
grafia, perché ci sembra ehe lodeyolmente non sia stato effigiato mai fino ad ora. In
fatti, alTeccezione dell’Olina, le cui ta vole non possono stare a paragone con quelle di
tante opéré magnifiche posteriori, pare ehe quasi tutti abbiano fatto ritrarre quest’ elegante
Uccelletto sopra esemplari conservati nei Musei, e mancanti percio di natura-
lezza nelle tinte, e nelle mosse. V’ è stata poi un’ altra considerazione ehe ci ha spinto
a sottoporre di nuoyo ai Zoologi le particolarità ehe offre questa specie comunissima
fra noi. Alcuni autori in grazia délia forma del becco l ’hanno riferita al gruppo Coc-
cothraustes: lo Scopoli la tenue per una Loxia: altri ingannati da qualche analogia ehe
ha con la Fringilla Citrinélla del Linneo la collocarono insieme con quella nel sot-
togenere Carduelis: altri considerando piuttosto l’abito in complesso, ehe i particolari
caratteri l’associarono aile specie del sottogenere Linaria: altri finalmente per non saper
ehe famé la lasciarono fra le genuine Fringillae. Ma appunto questa disparité di
giudizj mostra ehe il Verzellino differisce di troppo dagli esseri compresi nelle divisioni
fin qui mentovate per poter rimanere in alcuna di quelle, e noi stimiamo ehe debba ri-
guardarsi corne tipo d’un distinto sottogenere subordinato al genere Fringilla da deno-
minarsi Serinus. I caratteri di tal gruppo saranno: il becco corto, grosso, rigonfio late-
ralmente, col margine delle mascelle arcuato: penne délia cavezza ehe cuoprono intiera-
mente le narici; basette numerose,ramose: ali brevi: coda lunghetta colle cuopritrici ehe
non giungono fino ad un punto prossimo all’apice: dita allungate: gozzo notabile per
la grandezza: statura picciola: colori verdi. Non bisognerà poi confondere questo nostro
gruppo Serinus con quello cosi denominato dal Boie, di cui non conosciamo né i caratteri
né il valore, ma ehe è molto più esteso del nostro e ehe include la Fringilla
Chloris. Fuori del Verzellino non ci è noto altro uccello degno di militare in questo
sottogenere, ineno ehe la specie da noi pubblicata pochi anni or sono in America sotto
il nome di Fringilla xanthorrhoa, la quale proveniya dal Brasile ; ma ora abbiamo ra-
gioni per crederla originaria dell’Affrica.
Il Verzellino è lungo quattro pollici e quattro linee; la sua stesa d’ali è d’otto pollici:
il becco è lungo quattro linee, largo tre e alto quasi altrettanto, rigonfio verso la base,
conico, poco acuto, privo di spigolo sul dorso, coi margini tagliati leggermente ad
arcô, e pochissimo inflessi all’indentro; d’un colore carneo scuro nella mascella di
sopra, chiaro in quella di sotto. Iride castagno-fosca. Capo olivastro chiaro tendente
al giallo, con tutto il pileo segnato di macchie longitudinal! olivaceo-fosche : fronte d’un
giallo dorato: linea sopracigliare sottile, ehe si estende lungo il collo, macchia semilu-
nare delle guance, co'llare della nuca, e groppone d’un giallo di giunchiglia verdastro.
Gola, gozzo, petto e parte anteriore del ventre di color giallo di giunchiglia, coi lati
del collo e del petto segnati di poche linee lunghette longitudinali fosco-olivacee.
Ventre bianco un poco sfumato di giallo, sottocoda parimente bianco, con alcune pen-
nuzze fosche lungo lo stelo. Dorso olivastro chiaro tendente al giallo con tutta la parte
centrale delle pennuzze tinta d’olivaceo-fosco. Base di tutte le piume piombina. Le ali
sono lunghe due pollici e mezzo, e piegate giungono a cuoprire circa là metà della coda.
Picciole cuopritrici d’un verde-olivaceo piuttosto chiaro, tutte le altre olivaceo-fosche
coi margini e l’apice bianco-verdastri ; lo ehe dà origine aile due fascie trasverse chiare
delle ali. Cuopritrici inferiori più piccole giallastre; le altre cinereo-biancastre. Tutte
le remiganti fosche, scolorate all’apice e lungo il margine interno, e con un orlo esterno
sottilissimo giallo-verdastro. Prima remigante di poco più lunga della quarta, e quasi
uguale alla seconda e alla terza, ehe sono le più lunghe di futte. Coda lunga un
pollice e nove linee, leggermente forcuta: cuopritrici inferiori bianche col centro delle
pennuzze alquanto lurido oppure fosco; direttrici obliquamente troncate coll’apice
piuttosto acuto, fosche col margine interno scolorato e l ’orlo estemo alla base giallo-
verdastro. Tibie biancastre. Piedi fosco-carnicini, col tarso lungo sette linee : unghie
nerastre; dita allungate; il medio compresa l’unghia lungo quanto il tarso.
La femmina di primavera si distingue dal maschio perché ha i colori più smorti,
specialmente i gialli. La fronte è mista di giallo e d’olivaceo-fosco ; le macchie fosche
dei fianchi sono più cospicue, e si estendono a tutto il petto e ail’epigastrio. D’inverno
tutte le macchie gialle tendono maggiormente al cinereo.
I giovani differiscono perché l’orlo di tutte le piume superiori è bianco piuttosto
ehe gialletto; gola, petto, fianchi e sottocoda bianchi; ogni piuma porta una macchia
fosca lungo lo stelo, più apparente sulle cuopritrici inferiori della coda.
II giovane nella prima età ha colori anche più smorti della femmina, più tendenti
al cinereo-ferrigno, ed è sparso di lineole fosche più apparenti.
Vive neir Italia, nella Grecia, nella Turchia, nell’ Austria, nella Svizzera, nella
Francia méridionale, nella Spagna, nel Portogallo e sulla costa settentrionale dell’Affrica.
In quasi tutta la nostra penisola si chiama Verzellino, a S.iena Crespolino, nelle terre
Venete Frigorin, a Genova Raperino, Ziain. E d’un’indole sommamente dolce, e molto
grato è il suo canto. Puo conservarsi a lungo nelle gabbie. Fa razza colla Passera
di Canaria, e produce ibridi fecondi almeno fino alla terza generazione. Il suo principale
alimento consiste in picciole semenze. Non puo dirsi uccello migratore, perché
non si trasporta regolarmente in regioni lontane; ma neppure è affatto stazionario.
Quei Verzellini che hanno passato fra noi Testate sogliono partirne d’autunno a pic-
cioli branchi per recarsi in altri punti più meridionali; alcuni pero ne restano, ed
altri ne sopraggiungono, provenienti per quel ehe pare da luoghi men temperati. Ai
20#