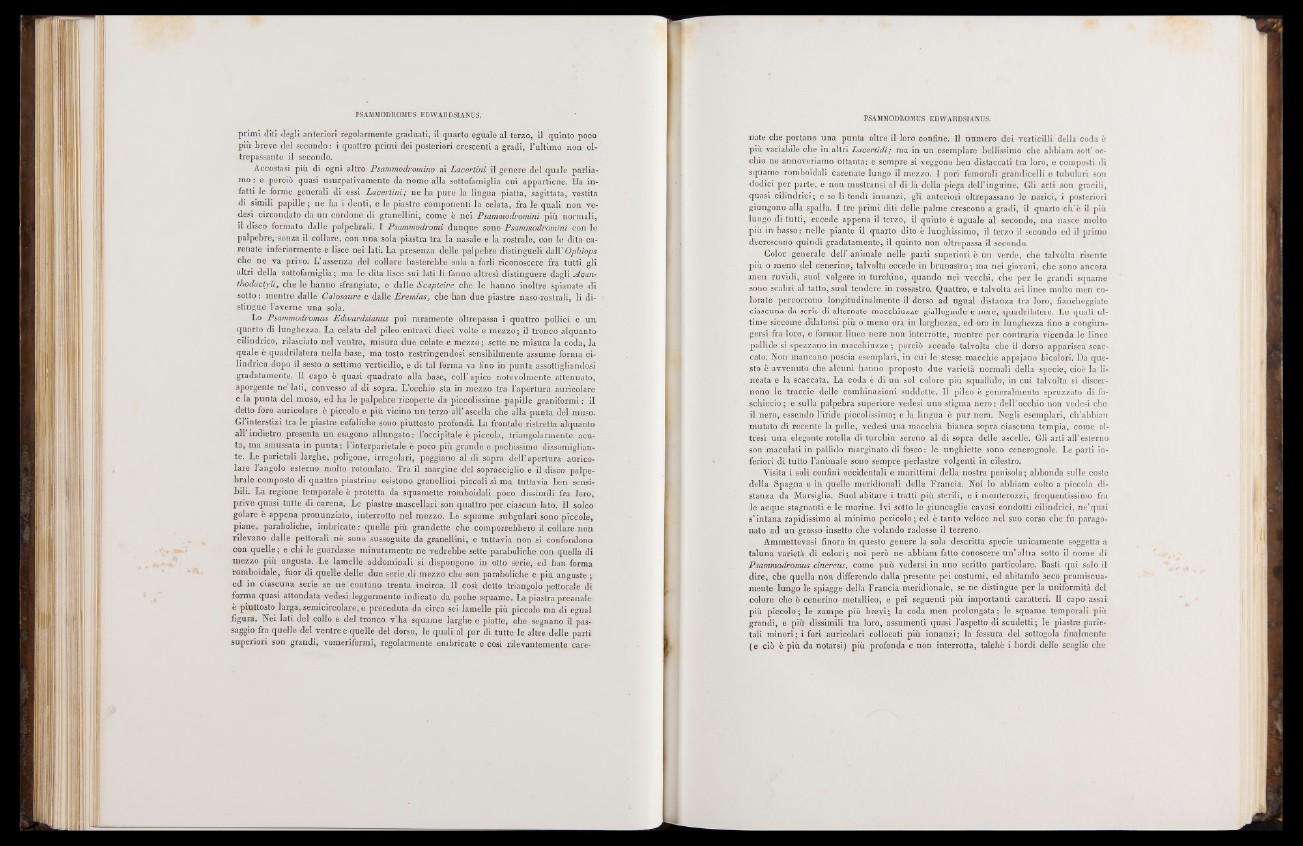
primi diti degli anteriori regolarmente graduati, il quarto eguale al terzo, il quinto poco
più breve del secondo: i quattro primi dei posteriori crescenti a gradi, Tultimo non ol-
trepassante il secondo.
Accostasi piu di ogni altro Psammodromino ai Lacertini il genere del quale parlia-
mo : e percio quasi usurpativamente da nome alla sottofamiglia cui appartiene. Ha in-
fatti le forme generali di essi Lacertini; ne ha pure la lingua piattar sagittata, vestita
di simili papille ; ne ha i denti, e le piastre componenti la celata, fra le quali non ve-
desi circondato da un cordone di granellini, corne è nei Psammodromini più normali,
il disco formato dalle palpehrali. I Psammodromi dunque sono Psammodromini con le
palpebre, senza il collare, con una sola piastra tra la nasale e la rostrale, con le dita ca-
renate inferiormente e lisce nei lati. La presenza delle palpebre distingueli dalT Ophiops
che ne va privo. L’assenza del collare basterebbe sola a farli riconoscere fra tutti gli
altri della sottofamiglia; ma le dita lisce sui lati li fanno altresi distinguere dagli Acan-
thodactylis che le hanno sfrangiate, e dalle Scapteire che le hanno inoltre spianate di
sotto : mentre dalle Calosaure e dalle EremiaSj che han due piastre naso-rostrali, li distingue
Taverne una sola.
Lo Psammodromus Edwardsianus poi raramente oltrépassa i quattro pollici e un
quarto di lunghezza. La celata del pileo entravi dieci volte e mèzzo; il tronco alquanto
cilindrico, rilasciato nei ventre, misura due celate e mezzo; sette ne misura la coda, la
quale è quadrilatera nella base, ma tosto restringendosi sensibilmente assume forma ci-
lindrica dopo il sesto o settimo verticillo, e di tal forma va fino in punta assottigliandosi
gradatamente. Il capo è quasi quadrato alla base, colTapice notevolmente attenuate,
sporgente ne’lati, convesso al di sopra. L’occhio sta in mezzo tra Tapertura auricolare
e la punta del muso, ed ha le palpebre ricoperte da piccolissime papille graniformi : il
detto foro auricolare è piccolo e più vicino un terzo ail’ ascella che alla punta del muso.
GTinterstizi tra le piastre cefaliche souo piuttosto profondi. La frontale ristretta alquanto
ail indietro présenta un esagono allungato : l’occipitale è picçola, triangolarmente acuta,
ma smussata in punta: l’interparietale è poco più grande e pochissimo dissomiglian-
te. Le parietali larghe, poligone, irregolari, poggiano al di sopra delPapertura auricolare
l’angolo esterno molto rotondato. Tra il margine del sopracciglio e il disco palpébrale
composto di quattro piastrine esistono granellini piccoli si ma tuttavia ben sensi-
bili. La region e temporale è protetta da squamette romboidali poco dissimili fra loro,
prive quasi tutte di caréna. Le piastre mascellari son quattro per ciascun lato. Il solco
golare è appena pronunziato, interrotto nel mezzo. Le squame subgulari sono piccole,
piane, paraboliche, imbricate : quelle più grandette che comporrebbero il collare non
rilevano dalle pettorali nè sono susseguite da granellini, e tuttavia non si confondono
con quelle; e chi le guardasse minutamente ne vedrebbe sette paraboliche con quella di
mezzo più angusta. Le lamelle addominali si dispongono in otto serie, ed han forma
romboidale, fuor di quelle delle due serie di mezzo che son paraboliche e più anguste ;
ed in ciascuna serie se ne contano trenta incirca. Il cosi detto triangolo peltorale di
forma quasi attondata vedesi leggermente indicato da poche squame. La piastra preanale
è piuttosto larga, semicircolare, e preceduta da circa sei lamelle più piccole ma di egual
figura. Nei lati del collo e del tronco v’ha squame larghe e piatte, che segnano il pas-
saggio fra quelle del ventre e quelle del dorso, le quali al par di tutte le altre delle parti
superiori son grandi, vomeriformi, regolarmente embricate e cosi rilevantemente carenate
che portano una punta oltre il loro confine. Il numero dei verticilli della coda è
più variabile ehe in altri Lacertidi; ma in un esemplare bellissimo ehe abbiam sott’ oc-
chio ne annoveriamo ottanta: e sempre si veggono ben distaccati tra loro, e composti di
squame romboidali carenate lungo il mezzo. I pori femorali grandicelli e tubulari son
dodici per parte, e non mostransi al di là della piega dell’inguine. Gli arti son gracili,
quasi cilindrici; e se li tendi innanzi, gli anteriori oltrepassano le narici, i posteriori
giungono alla spalla. I tre primi diti delle palme crescono a gradi, il quarto ch’è il più
lungo di tutti, eccede appena il terzo, il quinto è uguale al secondo, ma nasce molto
più in basso: nelle piante il quarto dito è lunghissimo, il terzo il secondo ed il primo
decrescono quindi gradatamente, il quinto non oltrepassa il secondo.
Color generale delT animale nelle parti superiori è un verde, che talvolta risen te
più o meno del cenerino, talvolta eccede in brunastro; ma nei giovani, che sono ancora
inen ruvidi, suol volgere in turchino, quando nei vecchi, ehe per le grandi squame
sono scabri al tatto, suol tendere in rossastro. Quattro, e talvolta sei linee molto men co-
lorate percorrono longitudinalmente il dorso ad ugual distanza tra loro, fiancheggiate
ciascuna da serie di alternate macchiuzze giallognole e nere, quadrilatère. Le quali ultime
siccome dilatansi più o meno ora in larghezza, ed ora in lunghezza fino a congiun-
gersi fra loro, e formar linee nere non interrotte, mentre per contraria vicenda le linee
pallide si spezzano in macchiuzze; percio accade talvolta ehe il dorso apparisca scac-
cato. Non mancano poscia esemplari, in. cui le stesse macchie appajano bicolori. Da que-
sto è avvenuto che alcuni hanno proposto due varietà normali della specie, cioè la li-
neata e la scaccata. La coda è di un sol colore più squallido, in cui talvolta si discer-
nono le traccie delle combinazioni suddette. Il pileo è generalmente spruzzato di fo-
schiccio; e sulla palpebra superiore vedesi uno stigma nero: dell’occhio non vedesi che
il nero, essendo Tiride piccolissima; e la lingua è pur nera. Negli esemplari, ch’abbian
nvutato di recente la pelle, vedesi una macchia bianca sopra ciascuna tempia, corne altresi
una elegante rotella di turchin sereno al di sopra delle ascelle. Gli arti ail’esterno
son maculati in pallido marginato di fosco: le unghiette sono cenerognole. Le parti in-
feriori di tutto l’animale sono sempre perlastre volgenti in cilestro.
Visita i soli confini occidentali e marittimi della nostra penisola; abbonda sulle coste
della Spagna e in quelle meridionali della Francia. Noi lo abbiam colto a piccola di-
slanza da Marsiglia. Suol abitare i tratti più sterili, e i monterozzi, frequentissimo fra
le acque stagnanti e le marine. Ivi sotto le giuncaglie cavasi condotti cilindrici, ne’quai
s’intana rapidissimo al minimo pericolo; ed è tanto veloce nei suo corso che fu parago-
nato ad un grosso insetto ehe volando radesse il terreno.
Ammettevasi finora in questo genere la sola descritta specie unicamente soggetta a
taluna varietà di colori; noi pero ne abbiam fatto conoscere un’ altra sotto il nome di
Psammodromus cinereus, come puo vedersi in uno scritto particolare. Basti qui solo il
dire, che quella non differendo dalla presente pei costumi, ed abitando seco promiscua-
mente lungo le spiagge della Francia meridionale, se ne distingue per la uniformità del
colore che è cenerino metallico, e pei seguenti più importanti caratteri. Il capo assai
più piccolo; le zampe più brevi; la coda men prolungata ; le squame temporal! più
grandi, e più dissimili tra loro, assumenti quasi Taspetto di scudetti; le piastre parietali
minori; i fori auricolari collocati più innanzi; la fessura del sottogola finalmente
(e cio è più da notarsi) più profonda e non interrotta, talchè i bordi delle scaglie che