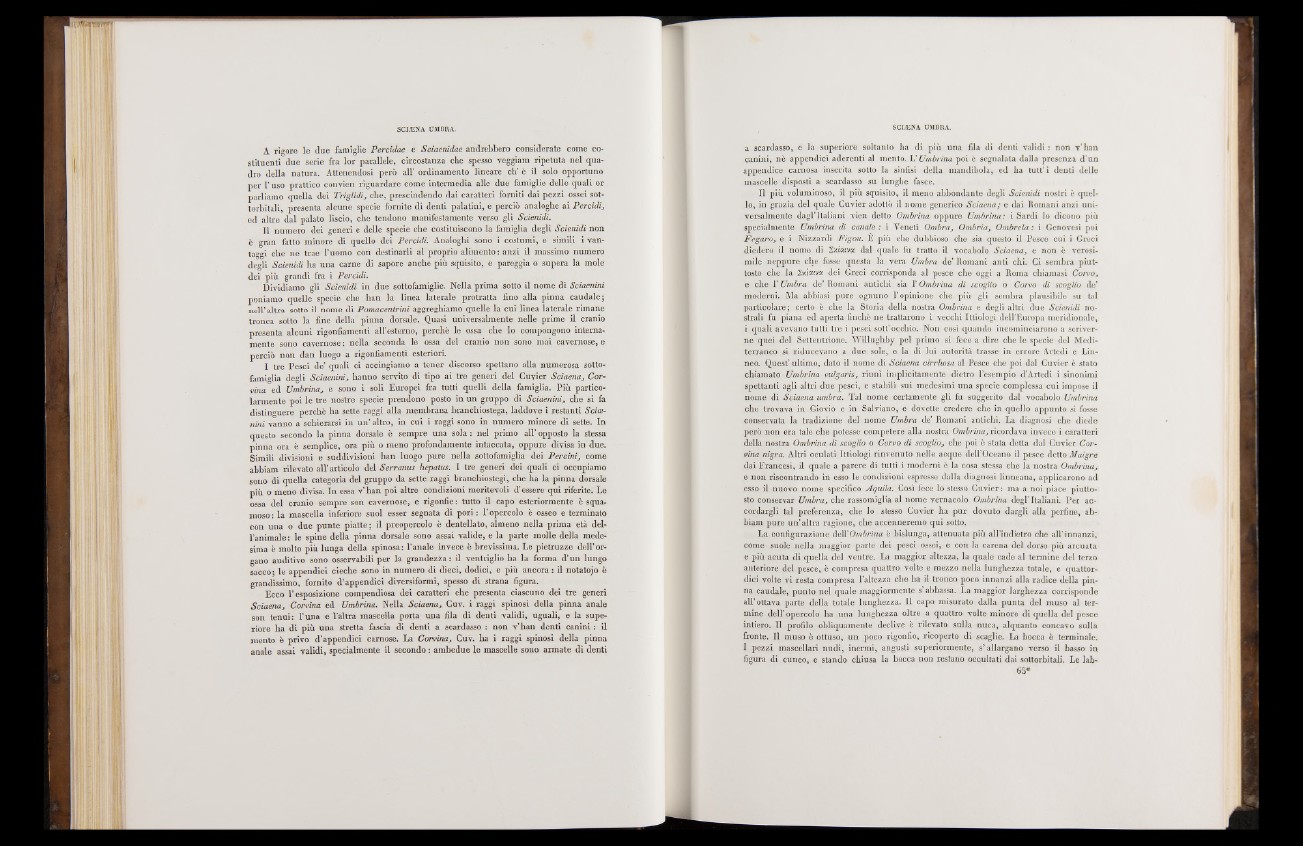
A rigore le due famiglie Percidae e Sciaenidae andrebbero considerate come co-
stituenti due serie fra lor parallele, circostanza ehe spesso yeggiam ripetuta nel qua-
dro della natura. Attenendosi perö all’ ordinamento lineare ch’ è il solo opportuno
per 1’ uso prattico conyien riguardare come intermedia alle due famiglie delle quali or
parliamo quella dei Triglidi, ehe, prescindendo dai caratteri forniti dai pezzi ossei sot-
torbitali, présenta alcune specie fornite di denti palatini, e percio analoghe ai Percidi,
ed altre dal palato liscio, ehe tendono manifestamente yerso gli Scienidi.
Il numero dei generi e delle specie ehe costituiscono la famiglia degli Scienidi non
è ;gran fatto minore di quello dei Percidi. Analoghi sono i costumi, e simili i yan-
tagffi ehe ne trae 1’uomo con destinarli al proprio alimento: anzi il massimo numero
degli Scienidi ha una carne di sapore anche più squisito, e pareggia o supera la mole
dei più grandi fra i Percidi.
Diyidiamo gli Scienidi in due sottofamiglie. Nella prima sotto il nome di Sciaenini
poniamo quelle specie che han la linea laterale protratta fino alla pinna caudale;
nell’altra sotto il nome di Pomacentrini aggreghiamo quelle la cui linea laterale rimane
tronca sotto la fine della pinna dorsale. Quasi uniyersalmente nelle prime il cranio
présenta alcuni rigonfiamenti all’esterno, perché le ossa ehe lo coinpongono interna-
mente sono cayernose : nella seconda le ossa del cranio non sono mai cayernose, e
percié non dan luogo a rigonfiamenti esteriori.
I tre Pesci de’ quali ci accingiamo a tener discorso spettano alla numerosa sotto-
famiglia degli Sciaenini, hanno servito di tipo ai tre generi del Cuyier Sciaena, Cor•
vina ed Umbrina, e sono i soli Europei fra tutti quelli della famiglia. Più partico-
larmente poi le tre nostre specie prendono posto in un gruppo di Sciaenini, ehe si fa
distinguere perché ha sette raggi alla membrana branchiostega, laddoye i restanti Scioe-
§ § g yanno a schierarsi in un’ altro, in cui i raggi sono in numero minore di sette. In
questo secondo la pinna dorsale è sempre una sola : nel primo all’ opposto la stessa
pinna ora è semplice, ora più o meno profondamente intaccata, oppure diyisa in due.
Simili diyisioni e suddivisioni han luogo pure nella sottofamiglia dei Percini, corne
abbiam rileyato all’ articolo del Serranus hepatus. I tre generi dei quali ci occupiamo
sono di quella categoria del gruppo da sette raggi branchiostegi, che ha la pinna dorsale
più o meno diyisa. In essa y ’han poi altre condizioni meriteyoli d’essere qui riferite. Le
ossa del cranio sempre son cayernose, e rigonfie: tutto il capo esteriormente è squa-
moso : la mascella inferiore suol esser segnata di pori : l ’ opercolo è osseo e terminate
con una o due punte pialte; il preopercolo è dentellato, almeno nella prima età del-
l ’animale: le spine della pinna dorsale sono assai yalide, e la parte molle della mede-
sima è molto più lunga della spinosa: l’anale inyece è brevissima. Le pietruzze dell’ or*
gano auditiyo sono osservabili per la grandezza : il yentriglio ha la forma d’un lungo
sacco; le appendici cieche sono in numero di dieci, dodici, e più ancora : il notatojo è
grandissimo, fornito d’appendici diyersiformi, spesso di strana figura.
Ecco l ’ esposizione compendiosa dei caratteri ehe présenta ciascuno dei tre generi
Sciaena, Corvina ed Umbrina. Nella Sciaena, Guy. i raggi spinosi della pinna anale
son tenui: l’una e l’altra mascella porta una fila di denti yalidi, uguali, e la supe-
xiore ha di più una stretta fascia di denti a scardasso : non y ’han denti canini : il
mento è privo d’appendici camose. La Corvina, Cuy. ha i raggi spinosi della pinna
anale assai yalidi, specialmente il secondo : ambedue le mascelle sono armate di denti
a scardasso, e la superiore soltanto ha di più una fila di denti yalidi : non y’ han
canini, né appendici aderenti al mento. L’Umbrina poi è segnalala dalla presenza d’un
appendice carnosa inserita sotto la sinfisi della mandibola, ed ha tutt’ i denti delle
mascelle disposti a scardasso su lunghe fasce.
Il più voluminoso, il più squisito, il meno abbondante degli Scienidi nostri è quelle,
in grazia del quale Cuyier adotto il nome generico Sciaena; e dai Romani anzi uniyersalmente
dagl’ Italiani yien dette Ombrina oppure Umbrina : i Sardi Jo dicono più
specialrnente Umbrina di candie: i Veneti Ombra, Ombria, Ombrela : i Genovesi poi
Fegaro, e i Nizzardi Figou. E più che dubbioso ehe sia questo il Pesce cui i Greci
diedero il nome di Zxiouvcc dai quale fu tratto il yocabolo Sciaenaj e non è verosi-
mile neppure ehe fossé questa la yera Umbra de’ Romani anti chi. Ci sembra piut-
tosto ehe la Ixiaivoc dei Greci corrisponda al pesce ehe oggi a Roma chiamasi Corvo,
e ehe 1’ Umbra de' Romani antichi sia l’ Ombrina di scoglio o Corvo di scoglio de’
moderni. Ma abbiasi pure ognuno l ’ opinione ehe più gli sembra plausibile su tal
particolare; certo è ehe la Storia della nostra Ombrina e degli altri due Scienidi no-
strali fu piana ed aperta finchè ne trattarono i yecchi Itliologi dell’Europa méridionale,
i quali ayeyano tutti tre i pesci sott’ occhio. Non cosi quando incominciarono a scriver-
ne quei del Settentrione. Willughby pel primo si fece a dire ehe le specie del Medi-
terraneo si riduceyano a due. sole, e la di lui autorité trasse in errore Artedi e Lin-
neo. Quest’ ultimo, dato il nome di Sciaena cirrhosa al Pesce che poi dai Cuyier è state
chiamato Umbrina vulgaris, riuni irnplicitamente dietro l’esempio d’Artedi i sinonimi
spettanti agli altri due pesci, e stabili sui medesimi una specie complessa cui impose il
nome di Sciaena umbra. Tal nome certamente gli fu suggerito dai yocabolo Umbrina
che troyaya in Gioyio e in Salyiano, e dovelte credere che in quello appunto si fosse
conseryata la tradizione del nome Umbra de’ Romani antichi. La diagnosi ehe diede
pero non era tale che potesse competere alla nostra Ombrina, ricordaya invece i caratteri
della nostra Ombrina di scoglio o Corvo di scoglio, ehe poi è stata detta dai Cuvier Corvina
nigra. Altri oculati Ittiologi rinvenuto nelle acque dell’Oceano il pesce detto Maigre
dai Francesi, il quale a parère di tutti i moderni è la cosa stessa ehe la nostra Ombrina,'
e non riscontrando in esso le condizioni espresse dalla diagnosi linneana, applicarono ad
esso il nuovo nome specifico Aquila. Cosi fece lo stesso Cuvier : ma a noi piace piutto-
sto conservar Umbra, che rassomiglia al nome vernacolo Ombrina degl’ Italiani. Per ac-
cordargli tal preferenza, ehe lo stesso Cuyier ha pur dovuto dargli alla perfine, abbiam
pure un’ altra ragione, ehe accenneremo qui sotto.
La configurazione deÏÏOmbrina è bislunga, attenuata più all’indietro ehe all’innanzi,
come suole nella maggior parte dei pesci ossei, e con la caréna del dorso più arcuata
e più acuta di quella del ventre. La maggior altezza, la quale cade al termine del terzo
anteriore del pesce, è compresa quattro volte e mezzo nella lunghezza totale, e quattor-
dici volte yi resta compresa l’altezza che ha il tronco poco innanzi alla radice della pinna
caudale, punto nel quale maggiormente s’ abbassa. La maggior larghezza corrisponde
all’ ottava parte della totale lunghezza. Il capo misurato dalla punta del muso al termine
dell’ opercolo ha una lunghezza oltre a quattro yolte minore di quella del pesce
intiero. Il profilo obliquamente decliye è rileyato sulla nuca, alquanto concavo sulla
fronte. Il muso è ottuso, un poco rigonfio, ricoperto di scaglie. La bocca è terminale.
I pezzi mascellari nudi, inerrai, angusti superiormente, s’ allargano verso il basso in
figura di cuneo, e stando chiusa la bocca non restano occultati dai sottorbitali. Le lab-
65*