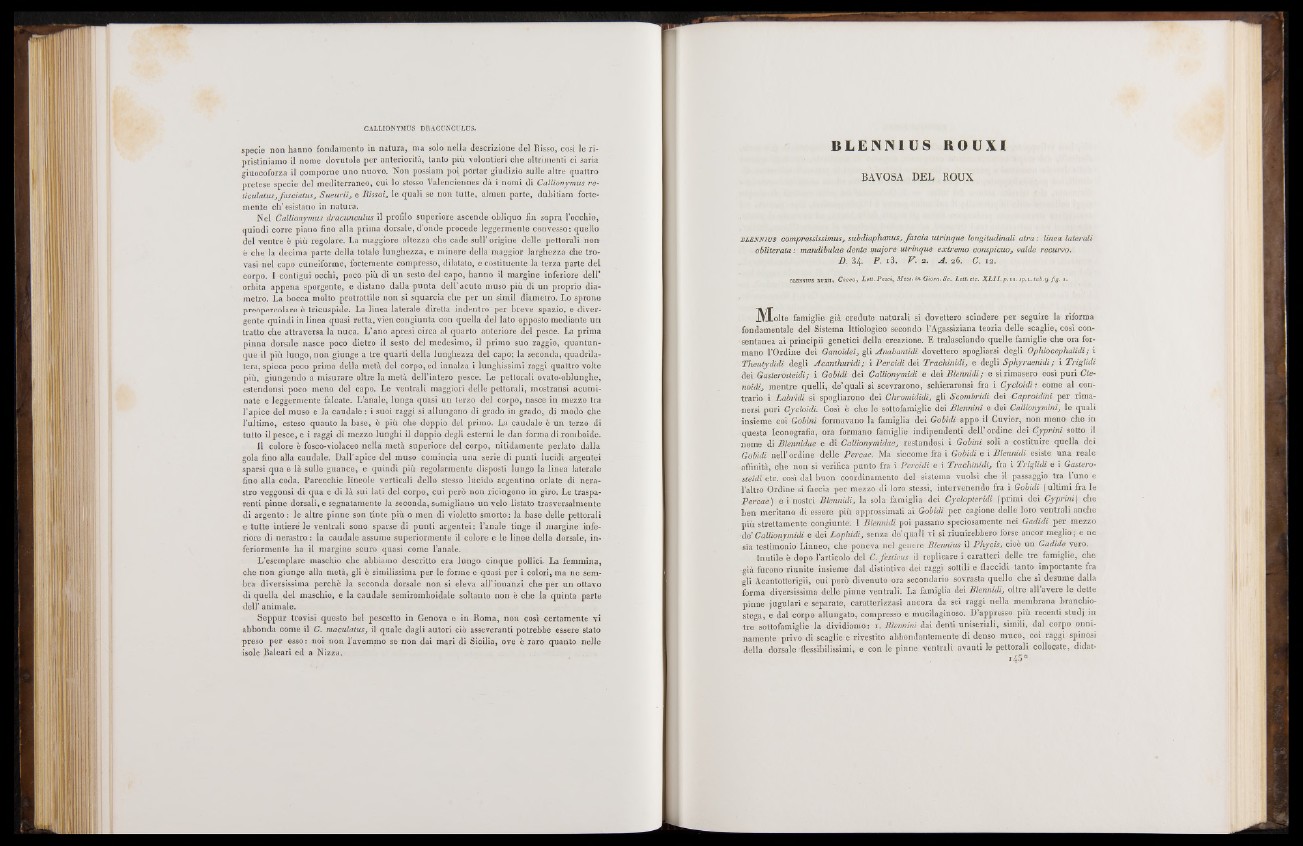
specie non hanno fondamento in natura, ma solo nella descrizione del Risso, cosi le ri-
pristiniamo il nome dovulole per antériorité, tanlo più volontieri ehe altrimenti ci saria
giuocoforza il comporne uno nuovo. Non possiam poi pdrtar giudizio sulle altre quattro
pretese specie del mediterraneo, cui lo stesso Valenciennes da i nomi di Callionymus re-
ticulatusjfasciatusj S u eu r iie Rissoij, le quali se non tutte, almen parte, dabitiam forte-
mente ch’ esistano in natura.
Nel Callionymus dracunculus il profita superiore ascende obliqua fin sapra l’occhio,
quindi corre piano fioo alla prima dorsale, d’onde procédé leggermente convesso: quello
del ventre è più regolare. La maggiore altezza che cade sull* origine delle pettorali non
è ehe la décima parte della totale lunghezza, e minore della maggior Jarghezza ehe tro-
vasi nel capo cunéiforme, fortemente compresso, dilatato, ecostituente la terza parte del
corpo. I contigui occhi, poco più di un sesto del capo, hanno il margine inferiore dell’
orbita appena sporgente, e distano dalla punta delPacuta muso più di un proprio dia-
metro. La bocca molto protrattile non si squarcia che per un simil diametro. Lo sprone
preopercolare è tricuspide. La linea laterale diretta indentro per breve spazio, e divergente
quindi in linea quasi retta, vien congiunta can quella del lato opposto mediante un
tratto ehe attraversa la nuca. L’ ano apresi circa al quarto anteriore del pesce. La prima
pinna dorsale nasce paco dietro il sesto del medesimo, il primo sua raggio, quantun-
que il più lungo, non giunge a tre quarti della lunghezza del capo: la seconda, quadrilatère,
spicca poco prima della metà del corpo, ed innalza i lunghissimi raggi quattro volte
più, giungendo a misurare oltre la metà dell’ intero pesce. Le pettorali ovato-oblunghe,
estendonsi poco meno del capo. Le ventrali maggiori delle pettorali, mostransi acuminate
e leggermente falcate. L’anale, lunga quasi un terzo del corpo, nasce in mezzo tra
l’apice del muso e la caudale : i suoi raggi si allungano di grado in grado, di modo ehe
l’ultimo, esteso quanto la base, è più ehe doppio del primo. La caudale è un terzo di
tutto il pesce, e i raggi di mezzo lunghi il doppio degli esterni Je dan forma di ramboide.
11 colore è fosco-violaceo nella metà superiore del corpo, nitidamente perlato dalla
gola fino alla caudale. Dall'apice del muso comincia una sérié di punli lucidi argentei
sparsi qua e là sulle guance, e quindi più regolarmente disposti lungo la linea laterale
fino alla coda. Parecchie lineole verticali dello stesso liicido argentino orlate di nera-
stro veggonsi di qua e di là sui lati del corpo, cui pero non ricingono in giro. Le traspa-
renti pinne dorsali, e segnatamente la seconda, sumigliano un vélo listato trasversalmente
di argento : le altre pinne son tinte più o men di violetto smorto: la base delle pettorali
e tutte intiere le ventrali sono sparse di punti argentei : l’anale tinge il margine inferiore
di nerastro : la caudale assume superiormente il colore e le linee della dorsale, in-
feriormente ha il margine scuro quasi corne l’anale.
L’esemplare maschio ehe abbiamo descritto era lungo cinque pollici. La femmina,
ehe non giunge alla metà, gli è similissima per le forme e quasi per i colori, ma ne sem-
bra diversissima perche la seconda dorsale non si eleva aU’ innanzi che per un ottavo
di quella del maschio, e la caudale semiromboidale sollanto non è ehe la quinta parle
dell’ animale.
Seppur trovisi questo bel pescetto in Genova e in Roma, non cosi certamente vi
abbonda corne il C. maculatuSj il quale dagli autori cio asseveranti potrebbe essere stato
pteso per esso: noi non l’avemmo se non dai mari di Sicilia, ove è raro quanto nelle
isole Raleari ed a Nizza.
BAVOSA DEL ROUX
ELENNius compressissimusj subdiaphanusj fascia utrinque longitudinali atra : linea laterali
obliterata : mandibulae dente majore utrinque extremo conspicuoj valde recurvo.
D. 34. P- *3. V. 2. A. 26. C. 12.
blbnniüs Ruxii, Cocca, Lett. P es ci, Meat, in Giorn.Se. Lett. etç. XLII.p.n. ap.i. tab.Q] fig. 1.
M o i t e famiglie già credute naturali si dovettero scindere per seguire la riforma
fondamentale del Sistema Ittiologico secondo l’Agassiziana teoria delle scaglie, cosi con-
sentanea ai principii genetici della creazione. E tralasciando quelle famiglie che ora for-
mano l ’Ordine dei Ganoideij gli Anabantidi dovettero spogliarsi degli Ophiocephalidi; i
Theutydidi degli Acanthuridi; i Percidi dei Trachinidi, e degli Sphyraenidi ; i Triglidi
dei Gasterosteidi; i Gobidi dei Callionymidi e dei Blennidi; e sirimasero cosi puri Cte-
noidij mentre quelli, de’ quali si scevrarono, schieraronsi fra i Cycloidi: corne al Gon-
trario i Labridi si spogliarono dei Chromididij gli Scombridi dei Caproidini per rima-
nersi puri Cycloidi. Cosi è che le sottofamiglie dei Blennini e dei Callionyminij le quali
insieme coi Gobini formavano la famiglia dei Gobidi appo il Cuvier, non meno che in
questa Iconografia, ora formano famiglie indipendenti dell’ ordine dei Cyprini sotto il
nome di Blennidae e di Callionymidaej restandosi i Gobini soli a costituire quella dei
Gobidi neli’ ordine delle Percae. Ma siccome fra i Gobidi e i Blennidi esiste una reale
affinità, che non si verifica punto fra i Percidi e i Trachinidij fra i Triglidi e i Gasterosteidi
etc. cosi dal buon coordinaniento del sistema vuolsi che il passaggio tra luno e
l ’altro Ordine si faccia per mezzo di loro stessi, intervenendo fra i Gobidi (ultimi fra le
Percae) e i nostri Blennidi, la sola famiglia dei Cyclopteridi (primi dei Cyprini) che
ben meritano di essere più approssimati ai Gobidi per cagione delle loro ventrali anche
più strettamente congiunte. 1 Blennidi poi passano speciosamente nei Gadidi per mezzo
-dé Callionymidi e dei Lophidi,, senza de’ quali vi si riunirebbero forse ancor meglio; e ne
sia testimonio Linneo, che poneva nel généré Blennius il PhyciSj cioè un Gadide vëro.
Inutile è dopo l’articolo del C. festivus il replicare i caratteri delle tre famiglie, che
-già furono riunite insieme dal distintivo dei raggi sottili e flaccidi tanto importante fra
gli Acantotterigii, cui perô divenuto ora secondario sovrasta quello che si desume dalla
forma diversissima delle pinne ventrali. La famiglia dei Blennidij oltre ail avéré le dette
pinne jugulari e separate, caratterizzasi ancora da sei raggi nella membrana branchio-
stega, e dal corpo allungato, compresso e mucilaginoso. D appresso più recenti studj in
tre sottofamiglie la dividiamo: i. Blennini dai denti uniseriali, simili, dal. corpo onni-
namente privo di scaglie e rivestito abbondantemente di denso muco, coi raggi spinosi
della dorsale flessibilissimi, e eon le pinne ventrali avanti le pettorali collocate, didatfil