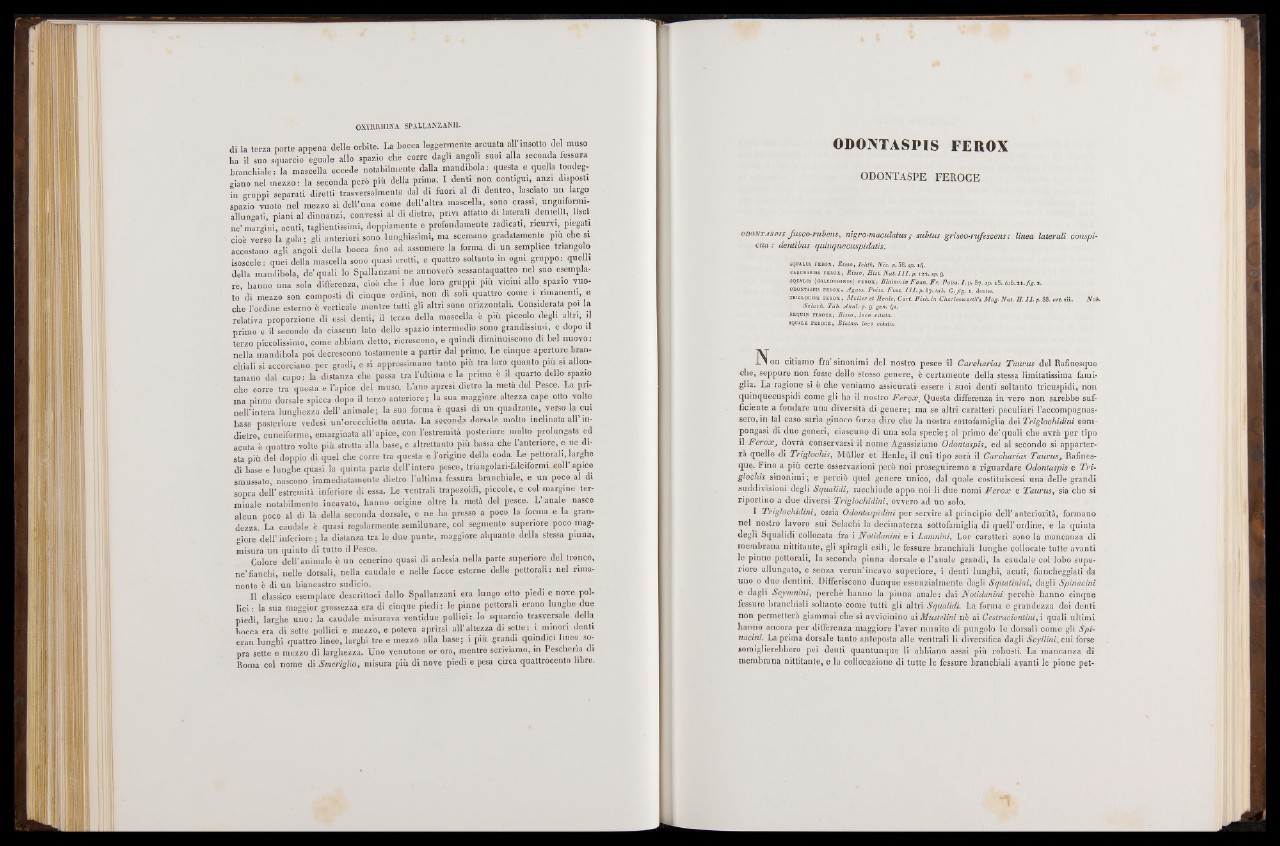
I Ia terza parte appena delle orbite. La bocca leggermente arcuata all insotto del muso
ha il suo squarcio eguale allo spazio ehe corre dagli angoli suoi alla seconda fessura
branchiale: la inascella eccede notabilmente dalla mandibola: questa e quella tondeg-
giano nel mezzo: la seconda perö più della prima. I denti non contigui, anzi d.sposti
in gruppi separati diretti trasversalmente dal di faori al di dentro, lasciato un largo
spazio Yuoto nel mezzo si dell'una come dell’ altra mascella, sono crassi, unguiformi-
allungati, piani al dinnanzi, convessi al di dietro, privi affatto di lateral! dentelh, lisci
ne’ margin!, acuti, taglientissimi, doppiamente e profondamente radical:, nourri, piegati
cioè verso la gola ; gli anterior! sono lunghissimi, ma scemano gradatamente più ehe si
accostano agli angoli della bocca fino ad assumere la forma di un semplice triangolo
isoscele: quel della mascella sono quasi eretti, e quattro soltanto in ogni gruppo: quelli
della mandibola, de’ quali lo Spallanzani ne annoverô sessantaquattro nel suo esempla-
re, hanno una sola differenza, cioè ehe i due loro gruppi più vicini allo spazio vuo-
to di mezzo son composti di cinque ordihi, non di soh quattro corne i nmanenti, e
ehe l'ordine esterno ë verticale mentre tutti gli altri sono orizzontali. Considerate poi la
relativa proporzione di essi denti,' il terzo della mascella è più piccolo degli altri, il
primo e il secondo da ciascun lato dello spazio intermedio.sono grandissimi, e dopo il
terzo piccolissimo, corne abbiam detlo, ricrescono, e quiudi diminuiscono di bel nuovo:
nella mandibola poi decrescono tostamente a partir dal primo. Le cinque aperture bran-
chiali si accorciano per gradi, e si approssimano tante più tra loro quanto più si allon-
tanano dal capo: la distanza ehe passa tra l’ultima e la prima è il quarto dello spazio
ehe corre tra quesla e l’apice del muso. L ’ano apresi dietro la meta del Pesce. La pn.
ma pinna dorsale spicca dopo il terzo anteriore; la sua maggiore altezza cape otto voile
nell’ intera lunghezza dell’ animale; Ta sua forma è quasi di un quadranle, verso la cui
base posteriore vedesi un’ orecchietta acuta. La seconda dorsale molto inclinata all’ in-
dietro, cunéiforme, emarginata all’ apice, con l’estremità posteriore molto prolungata ed
aeuta è quattro voile più stretta alla base, e altreltanto più bassa che 1 anteriore, e.ne di-
sta più del doppio di quel ehe corre tra questa e l’origine della coda. Le pettorah, larghe
di base e lunghe quasi la quinta parte dell’ intero pesce, triangolari-falciformweoll’ apice
smussato, nascono immediatamente dietro l ’ultima fessura branchiale, e un poco al di
sopra dell’ estreinità inferiore di essa. Le ventrali trapezoidi, piccole, e col margine terminale
notabilmente incavato, hanno origine oltre la metà del pesce. L anale nasce
alcun poco al di là della seconda dorsale, e ne ha presso a poco la forma e la grandezza.
La caudale è quasi regolarmente semilunare, col segmenta superiore poco maggiore
dell’ inferiore ; la distanza tra le due punte, maggiore alquanto della stessa pinna,
misura un quinto di tutto il Pesce.
Colore dell’ animale è un cenerino quasi di ardesia nella parte superiore del tronco,
ne’ fianchi, nelle dorsali, nella caudale e nelle facce esterne delle pettorali: nel rima-
nente è di un biancastro sudicio.
Il classico esemplare descrittoci dallo Spallanzani era lungo otto piedi e nove pol-
lic i: la sua maggior grossezza era di cinque piedi: le pinne pettorali erano lunghe due
piedi, larghe uno: la caudale misurava ventidue pollici: lo squarcio trasversale della
bocca era di sette pollici e mezzo, e poteva aprirsi ail’ altezza di sette: i minori denti
eran lunghi quattro linee, larghi tre e mezzo alla base; i più grandi quindici linee sopra
sette e mezzo di larghezza. Uno venutone or ora, mentre scriïiamo, in Pescherla di
Borna col nome di Smeriglio, misura più di nove piedi e pesa çirca quattrocento libre.
ODONTASPIS FEROX
ODONTASPE FEROCE
obontaspis fusco-rubens, nigro-maculatus ƒ subtus griseo-rufescens: linea laterali conspi-
c u a : dentibus quinquecuspidatis.
SQÜALUS FE BOX I Risso, Icltth, Nie. p.38. «ƒ). 14.
CARCHARIAS FEROX, RitSO , Hist. N(lt. 111. p. 12a. sp. 9.
sqoalus (galeorhinus) ferox, Blainv.in Faun. F r . Poiss. I. p. 87. sp. j 8. t a l . i l . fig .i.
odontaspis FEROX, Agass. Poiss. Foss. I I I . p. 87. tab. G.ßg. 1. dentes.
TRIGLOCHIS fe r o x , Müller et Heule, Cart. FM - in Cliarlesworth\ Mag. Nat. H- U - p- 88. art. ▼ «.. Nob.
Selach. Tab. Anal. p. 9. gen. 40.
REQDIN feroce, Risso, loco cilato.
SQUALE FERO.CE, Blqiny. loco citato,.
N o n citiamo fra’ sinonimi del nostro pesoe ïl Carcharias Taurus del Rafinesque
che, seppure non fosse dello stesso genere, è certamente della stessa limitatissima fami-
glia. La ragione si è che yeniamo assicurati essere i suoi denti soltanto tricuspidi, non
quinquecuspidi come gli ha il nostro F erox. Questa differenza in yero non sarebbe suf-
heiente a fondare una diversita di genere; ma se altri caratteri peculiari 1’accompagnas-
sero., in lal caso saria giuoco forza dire che la nostra sottofamiglia dei Triglochidini com-
pongasi di due generi, ciasouno di una sola specie; al primo de’ quali che ayra per tipo
il FeroXj dovra conseryarsi il nome Agassiziano Odontaspisj ed al secondo si apparter-
xa quello di Triglochis, Müller et Henle, il cui tipo sara il Carcharias Taurust Rafinesque,
Fino a piü certe osservazioni perö noi proseguiremo a riguardare Odontaspis e Tri-
glochis sinonimi; e percio quel genere unico, dal quale costituiscesi una delle grandi
suddivisioni degli Squalidij racchiude appo noi li due noini Ferox e Taurus, sia che si
riportino a due diyersi Triglochidini, oyyero ad un solo.
I Triglochidinix ossia Odontaspidini per seryire al principio dell* anteriorita, formano
nel nostro lavoro sui Selachi la decimaterza sottofamiglia di quell’ ordine, e la quinta
degli Squalidi collocata fra i Notidanini e i Lamnini. Lor caratteri sono la mancanza di
membrana nittitante, gli spiragli esili, le fessure branchiali lunghe collocate tutte avanti
le pinne pettarali, la seconda pinna dorsale e 1’anale grandi, la caudale col lobo superiore
allungato, e senza yerun’ incavo superiore, i denti lungbi, acuti, fiancheggiati da
uno o due dentini. Differiscono dunque essenzialmente dagli Squatinini, dagli Spinacini
e dagli Scymnini, perchè banno la pinna anale: dai Notidanini perchè banno cinque
fessure branchiali soltanto come tutti gli altri Squalidi. La forma e grandezza dei denti
non permettera giammai che si avvicinino ai Mustelini nè ai Cestraciontini, i quali ultimi
hanno ancora per differenza maggiore 1’aver munite di pungolo le dorsali come gli Spinacini.
La prima dorsale tanto anteposta alle yentrali li diyersifica dagli Scyllinih cui forse
somiglierebbero pei denti quantunque li abbiano assai piü robusti. La mancanza di
membrana nittitante, e la collocazione di tutte le fessure branchiali avanti le pinne pet