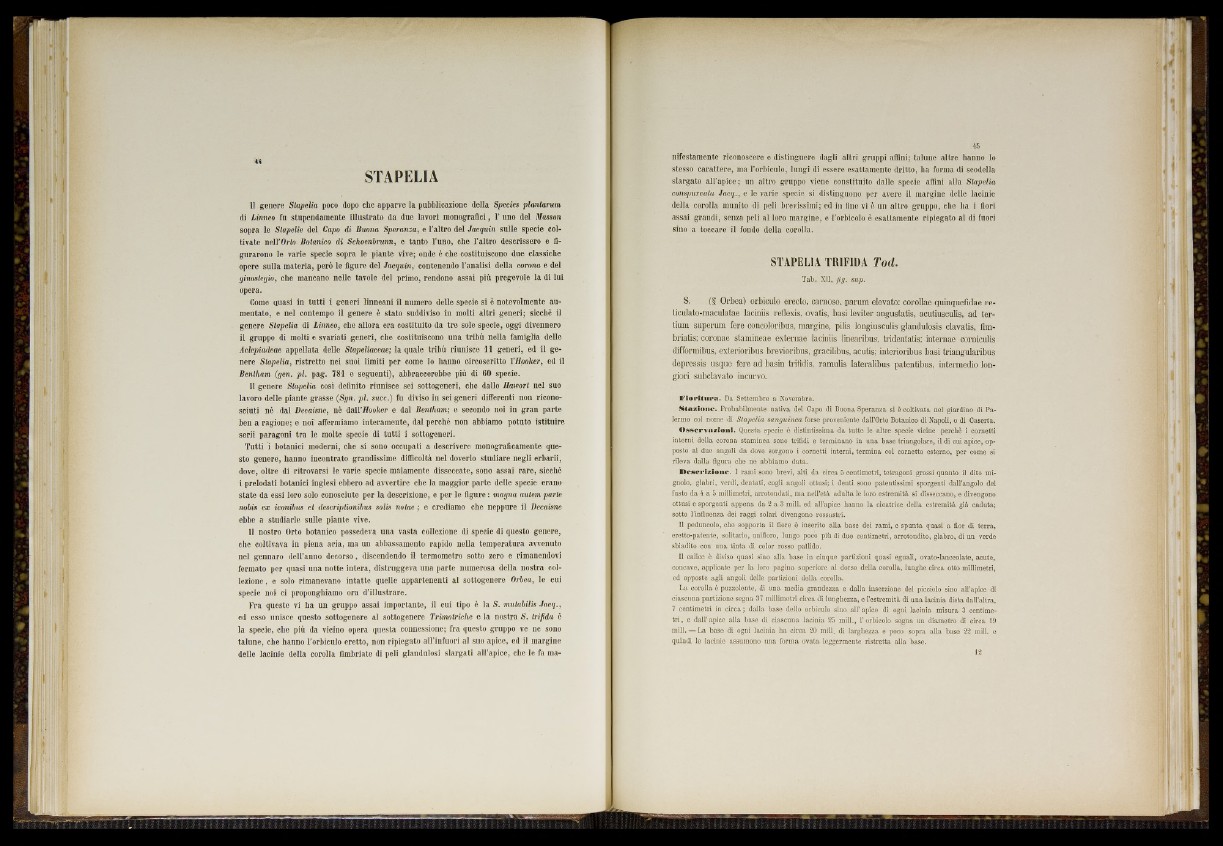
STAPELIA
Il genere Stapelia poco dopo che apparve la pubblicazione della Species plantarum
di Linneo fu stupendamente illustrato da due lavori monografici, l’ uno del Masson
sopra le Slapelie del Capo di Buona Speranza, e l’altro del Jacquin sulle specie coltivate
nell*Orto Botanico di Schoenbrunn, e tanto l’uno, che l’altro descrissero e figurarono
le varie specie sopra le piante vive; onde è che costituiscono due classiche
opere sulla materia, però le figure del Jacquin, contenendo l’analisi della corona e del
ginostcgio, che mancano nelle tavole del primo, rendono assai più pregevole la di lui
opera.
Come quasi in tu tti i generi linneani il numero delle specie si è notevolmente aumentato,
e nel contempo il genere è stato suddiviso in molti altri generi; sicché il
genere Stapelia di Linneo, che allora era costituito da tre sole specie, oggi divennero
il gruppo di molti e svariati generi, che costituiscono una tribù nella famiglia delle
Aclepiadcae appellata delle Stapeliaceae; la quale tribù riunisce 11 generi, ed il genere
Stapelia, ristretto nei suoi limiti per come lo hanno circoscritto YHooker, ed il
Bentham (gen. pi. pag. 781 e seguenti), abbraccerebbe più di 60 specie.
Il genere Stapelia cosi definito riunisce sei sottogeneri, che dallo Haworl nel suo
lavoro delle piante grasse (Syn. pi. succ.) fu diviso in sei generi differenti non riconosciuti
nè dal Decaisne, nè dair/Zoo/ter e dal Bentham; e secondo noi in gran parte
ben a ragione; e nof affermiamo interamente, dal perchè non abbiamo potuto istituire
serii paragoni tra le molte specie di tu tti i sottogeneri.
Tutti i botanici moderni, che si sono occupati a descrivere monograficamente questo
genere, hanno incontrato grandissime difficoltà nel doverlo studiare negli erbarii,
dove, oltre di ritrovarsi le varie specie malamente disseccate, sono assai rare, sicché
i prelodati botanici inglesi ebbero ad avvertire che la maggior parte delle specie erano
state da essi loro solo conosciute per la descrizione, e per le figure : magna autem parte
nobis ex iconibus et descriplionibus solis nolae ; e crediamo che neppure il Decaisne
ebbe a studiarle sulle piante vive.
Il nostro Orto botanico possedeva una vasta collezione di specie di questo genere,
che coltivava in piena aria, ma un abbassamento rapido nella temperatura avvenuto
nel gennaro dell’anno decorso, discendendo il termometro sotto zero e rimanendovi
fermato per quasi una notte intera, distruggeva una parte numerosa della nostra collezione,
e solo rimanevano intatte quelle appartenenti al sottogenere Orbea, le cui
specie noi ci proponghiamo ora d’illustrare.
Fra queste vi ha un gruppo assai importante, il cui tipo è la S. mulabilis Jacq.,
ed esso unisce questo sottogenere al sottogenere Trimotriche e la nostra S. Infida è
la specie, che più da vicino opera questa connessione; fra questo gruppo ve ne sono
talune, che hanno l’orbiculo eretto, non ripiegato all’infuori al suo apice, ed il margine
delle lacinie della corolla fimbriate di peli glandulosi slargati all’apice, che le fa manifestamente
riconoscere e distinguere dagli altri gruppi affini; talune altre hanno lo
stesso carattere, ma l’orbieulo, lungi di essere esattamente dritto, ha forma di scodella
slargato all’apice; un altro gruppo viene constituito dalle specie affini alia Stapelia
conspurcala Jacq., e le varie specie si distinguono per avere il margine delle lacinie
della corolla munito di peli brevissimi; ed in fine vi è un altro gruppo, che ha i fiori
assai grandi, senza peli al loro margine, e l’orbicolo è esattamente ripiegato al di fuori
sino a toccare il fondo della corolla.
STAPELIA TRIFIDA Tod.
Tab. XII, fig. sup.
S. (§ Orbea) orbiculo erecto, carnoso, parum elevato; corollae quinquefidae re-
ticulato-maculatae laciniis reflexis, ovatis, basi Ieviter angustatis, acutiuseulis, ad ter-
tium superum fere concoloribus, margine, pilis longiusculis glandulosis clavatis, fìm-
briatis; coronae stàmineae externae laciniis linearibus, tridentatis; internae corniculis
difformibus, exterioribus brevioribus, gracilibus, acutis; interioribus basi triangularibus
depressis usque fere ad basin trifidis, ramulis Iateralibus patentibus, intermedio lon-
giori subclavato incurvo.
F io r i tu r a . Da Settembre a Novembre.
S ta z io n e . Probabilmente nativa del Capo di Buona Speranza si è coltivata nel giardino di Palermo
col nome di Stapelia sanguinea forse proveniente dall’Orto Botanico di Napoli, o di Oaserta.
O sse rv a z io n i. Questa specie è distintissima da tutte le altre specie vicine perchè i cornetti
interni della corona staminea sono trifidi e terminano in una base triangolare, il di cui apice, opposto
ai due angoli da. dove sorgono i cornetti interni, termina col cornetto esterno, per come si
rileva dalla figura che ne abbiamo data.
D e sc r iz io n e . I rami sono brevi, alti da circa 5 centimetri, tetragoni grossi quanto il dito mignolo,,
glabri, verdi, dentati, cogli angoli ottusi; i denti sono patentissimi sporgenti dall’angolo del
fusto da 4 a 5 millimetri, arrotondati, ma nell’età adulta le loro estremità si disseccano, e divengono
ottusi e sporgenti appena da 2 a 3 mill. ed all’apice hanno la cicatrice della estremità già caduta;
sotto l'influenza dei raggi solari divengono rossastri.
Il peduncolo, che sopporta il fiore è inserito alla base dei rami, e spunta quasi a fior di terra,
eretto-patente, solitario, unifloro, lungo poco più di due centimetri, arrotondito, glabro, di un verde
sbiadito con una tinta di color rosso pallido.
Il calice è diviso quasi sino alla base in cinque partizioni quasi eguali, ovato-lanceolate, acute,
concave, applicate per la loro pagina superiore al dorso della corolla, lunghe circa otto millimetri,
ed opposte agli angoli delle partizioni della corolla.
La corolla è puzzolente, di una media grandezza e dalla inserzione del picciolo sino all’apice di
ciascuna partizione segna 37 millimetri circa di lunghezza, e l’estremità di una lacinia dista dall’altra,
7 centimetri in circa ; dalla base dello orbiculo sino all’ apice di ogni lacinia misura 3 centimetri,
e dall’ apice alla base di ciascuna lacinia 25 mill., l’ orbicolo segna un diametro di circa 19
m ill.— La base di ogni lacinia h a circa 20 mill. di larghezza e poco sopra alla base 22 mill. e
quindi le lacinie assumono una forma ovata leggermente ristretta alla base.
12